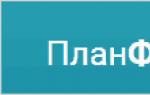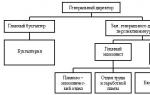Liquido lacrimale di una persona: che cos'è, la sua composizione. Liquido lacrimale: cos'è e a cosa serve? Di cosa è fatta una lacrima?
Le lacrime sono un liquido incolore, inodore e salato. Ha una reazione leggermente alcalina. Senza una lacrima, il lavoro a tutti gli effetti dell'organo della vista è impossibile, poiché il bulbo oculare deve essere costantemente umido.
Gli organi lacrimali sono responsabili della produzione di un fluido importante e gli organi lacrimali, rispettivamente, del suo deflusso. Il pieno bisogno dell'occhio è fornito da una grande ghiandola lacrimale e da un gran numero di secondarie, di piccole dimensioni. Obaglaza.ru attira l'attenzione sul fatto che sono facilmente riconoscibili visivamente.
Composizione chimica delle lacrime
Quasi il 98% delle lacrime sono H 2 O (acqua). La restante soluzione al 2% è composta da:
- elettroliti di sali inorganici;
- mucopolisaccaridi;
- proteine;
- lipidi;
- una piccola parte di vari componenti organici.
Lo strappo è responsabile di mantenere la superficie anteriore della cornea pulita, chiara e umida in ogni momento. Forma una specie di film precorneale, costituito da tre strati:
- lipido superficiale (contatti con l'aria) - grazie al segreto delle ghiandole di Meibomio, non consente allo strato successivo di evaporare;
- acqua con mucina - il segreto delle ghiandole lacrimali;
- mucoide: funge da collegamento tra il secondo strato e la cornea.
Funzioni di una lacrima
Per mantenere umido lo strato superficiale del bulbo oculare, speciali ghiandole producono circa 1 ml di liquido lacrimale in 24 ore. Il rilascio di umidità può essere innescato dall'esposizione a radiazioni luminose, dall'influenza del caldo o del freddo con il vento, da emozioni provate di gioia o risentimento.
Una lacrima svolge diverse funzioni:
- nutrizione della cornea con frazioni di lipidi e proteine, sali (funzione trofica);
- garantire la resistenza del corpo agli effetti dei microrganismi a causa del lisozima contenuto (sostanza antibatterica);
- rimozione meccanica di corpi estranei dalla superficie del bulbo oculare da una corrente di lacrime.
Ghiandole lacrimali
Nel fornice congiuntivale sono presenti piccole ghiandole lacrimali (accessorio). Il principale si trova sotto la palpebra superiore nello scomparto esterno superiore. È diviso in due parti dal tendine del muscolo che solleva la palpebra. Il lobo orbitale (superiore) si trova nella fossa ossea sulla parete esterna superiore dell'orbita. La parte palpebrale (inferiore) è di dimensioni inferiori, situata sopra il fornice superiore della congiuntiva. Di conseguenza, vi entrano circa 10 dotti escretori.
La vena lacrimale (deflusso) e l'arteria (afflusso) sono responsabili della circolazione sanguigna nella ghiandola. Le fibre parasimpatiche del nervo facciale regolano la secrezione del liquido lacrimale. La fornitura di elementi nervosi (innervazione) viene eseguita:
- fibre simpatiche del ganglio cervicale superiore;
- rami del nervo trigemino;
- fibre parasimpatiche del nervo facciale.
Esistono tre gruppi di ghiandole lacrimali accessorie con diverse secrezioni secretorie:
- con muco
- ghiandole granulari con cellule caliciformi - nella congiuntiva del bulbo oculare e della cartilagine;
- Ghiandole di Mantz - nella congiuntiva limbare;
- cripte di Henle - nelle pieghe congiuntivali;
- con acqua:
- Ghiandole di Krause - nella congiuntiva della cartilagine;
- Ghiandole di Wolfring - lungo il bordo della placca cartilaginea e nella congiuntiva;
- Ghiandole di Moll - nella zona dei follicoli delle ciglia;
- con grasso:
- Ghiandole Zeiss - nell'area delle radici delle ciglia;
- ghiandole di Meibomio - sulla placca cartilaginea.
Organi lacrimali
Per il deflusso del liquido lacrimale, esiste un sistema piuttosto complesso. In primo luogo, la lacrima passa attraverso il flusso lacrimale tra la mela e la superficie posteriore della costa palpebrale. Quindi si raccoglie in un lago all'ingresso dei canalicoli lacrimali (puncta lacrimale superiore e inferiore sulle palpebre corrispondenti), entra nel sacco lacrimale e nel canale nasolacrimale. Quest'ultimo ha un'apertura all'interno della cavità nasale. I dotti lacrimali corrono prima verticalmente per circa 2 mm, poi orizzontalmente per circa 8 mm. Il tubulo inferiore drena quasi il 70% del fluido.
Il flusso inverso (reflusso) è limitato dalla valvola di Rosenmuller all'ingresso del tubulo nel sacco lacrimale, lungo 5-10 mm, situato tra le creste lacrimali dell'osso anteriore e posteriore. Dal lago di lacrime accumulato, quando sbattono le palpebre, vengono scaricate da un meccanismo di pompaggio dovuto alla pressione creata dal muscolo orbicolare e dalla fascia del sacco.
Malattie degli organi lacrimali
I principali segni di deviazioni dallo stato normale degli organi lacrimali:
- bruciore agli occhi;
- sensazione della cosiddetta "sabbia" o della presenza di un corpo estraneo sulla mucosa;
- secchezza;
- lacrimazione abbondante.
Tali sintomi sono caratteristici di una produzione insufficiente di liquido lacrimale (ipofunzione) o di una violazione del suo deflusso. La causa della lesione può essere localizzata all'esterno (alle aperture lacrimali, al confine della palpebra inferiore) e più in profondità - nel canale nasolacrimale o nei tubuli. il sito rileva che gonfiore, arrossamento del bordo dell'occhio dall'interno può indicare un'infiammazione del sacco lacrimale con un lungo ritardo nel deflusso del liquido. Tale anomalia della ghiandola lacrimale si verifica più spesso con alcune lesioni degli organi ghiandolari.
Diagnosi delle malattie degli organi lacrimali
- Alla palpazione del sacco lacrimale infiammato, si avverte dolore. Il gonfiore e lo scolorimento delle palpebre vengono rilevati mediante un'ispezione visiva delle loro condizioni e posizione.
- Per esaminare il lobo palpebrale della ghiandola lacrimale, la palpebra superiore è rovesciata alla luce di una lampada a fessura.
- La biomicroscopia condotta dell'occhio consente di diagnosticare la condizione delle aperture lacrimali, la sufficienza di idratazione della cornea e della congiuntiva.
- Il colorante rosa del Bengala viene utilizzato per i campioni al fine di identificare le cellule epiteliali morte (non vitali) che sono apparse a causa di disturbi nelle ghiandole lacrimali.
- La pervietà dei canali lacrimali viene controllata lavando l'afflusso e il deflusso del liquido. Se non ci sono deviazioni dalla norma, l'acqua passa attraverso l'apertura lacrimale nelle cavità nasali e orali. Allo stesso scopo serve una speciale fluoresceina colorante: dovrebbe risaltare dal naso pochi secondi dopo essere stata iniettata nel sacco congiuntivale.
Se si sospetta un'ostruzione dei percorsi, viene prescritto un esame radiografico mediante dacriocistografia a contrasto. Ciò consente di determinare in modo inequivocabile il grado di sviluppo del processo infiammatorio.
La velocità di riproduzione dei fluidi viene valutata eseguendo un test di Schirmer, un test con strisce speciali che vengono poste dietro la palpebra inferiore. Se vengono bagnati con un'umidità inferiore a 1 mm/minuto, questa velocità è considerata insufficiente e indica una violazione della secrezione delle ghiandole lacrimali. Spesso, la produzione di lacrime è inibita dall'uso di determinati farmaci.
Trattamento dei disturbi
- Dopo aver identificato i disturbi nel sistema degli organi lacrimali e aver determinato le cause delle patologie, vengono solitamente prescritte instillazioni di farmaci che, per le loro proprietà, sono in grado di compensare la mancanza di liquido lacrimale per un certo periodo. Questa terapia è chiamata terapia sostitutiva.
- In alcuni casi, le aperture lacrimali sono ostruite da una sorta di "tappi" in modo da prolungare l'effetto della presenza di lacrime.
- La nomina della terapia antinfiammatoria viene eseguita in caso di compromissione della pervietà dei dotti lacrimali. Secondo obaglaza.ru, la causa più comune di questa patologia sono i processi infiammatori.
- Un'altra opzione per risolvere il problema è il trattamento chirurgico con l'ulteriore appuntamento di bougienage per ripristinare il tratto di deflusso.
L'ostruzione cronica del canale nasolacrimale viene eliminata mediante l'uso della dacriocistorinostomia. Durante questa operazione viene eseguita un'anastomosi, ripristinando la comunicazione tra il sacco lacrimale e la cavità nasale direttamente attraverso la parete ossea marginale.
Il liquido lacrimale è un prodotto di un intero sistema di organi. È trasparente, leggermente salmastro, ha un ambiente leggermente alcalino. In una persona sana, una lacrima lava costantemente la superficie del bulbo oculare.
Gli organi lacrimali sono generalmente divisi in due gruppi:
- lacrimale;
- lacrimale.
Ogni giorno, le piccole ghiandole lacrimali secernono in media 1 ml di liquido. Ogni goccia ha una struttura complessa. Il film lacrimale avvolge uno strato d'acqua. All'interno contiene una piccola quantità di muco.
Composto
Anche la composizione delle lacrime è complessa. Oltre all'acqua (circa il 98%), il liquido contiene cloruro di sodio (sale da cucina). Questo spiega perché le lacrime sono salate. Considera un elenco di altre sostanze:
- cloruro di potassio;
- lisozima;
- manganese;
- calcio;
- bicarbonato di sodio.
Alcune sostanze formano sale. Questo è un altro motivo per cui le lacrime sono salate. Vale la pena notare che non ci sono meno informazioni in questo liquido che nel sangue, poiché la loro composizione chimica è simile. Inoltre, varia a seconda dello stato del corpo.
Il film lacrimale è composto da ammidi di acidi grassi e lipidi. La sua struttura è eterogenea:
- strato lipidico (a contatto con l'aria);
- strato mucoide (adiacente all'epitelio del bulbo oculare);
- strato intermedio o acquoso (contiene mucina ed è un collegamento tra gli strati).
Il film lipidico sulla superficie impedisce al liquido lacrimale di asciugarsi rapidamente, quindi gli occhi sono normalmente sempre idratati.
Funzioni
Una lacrima umana assicura il normale funzionamento dell'apparato visivo. Questo liquido svolge diverse funzioni contemporaneamente. Consideriamoli.
- Idrata le mucose degli occhi e del naso. Le ghiandole lacrimali producono circa 4000 gocce al giorno.
- Ha un effetto antibatterico dovuto al lisozima (neutralizza attivamente microbi, virus), che ne fa parte.
- Rimozione meccanica di corpi estranei (polvere, granelli, ciglia).
- Fornisce ulteriore apporto di nutrienti (proteine, sali, lipidi) all'epitelio del bulbo oculare.
- Il segreto della ghiandola oculare contiene sostanze psicotrope. Questo spiega la sensazione che la tensione diminuisca dopo il pianto.
Oltre a influenzare l'organo visivo, le lacrime sono coinvolte nel rilascio degli ormoni dello stress. Se il processo si verifica, si verifica a seguito di un cambiamento nello stato emotivo, quindi, insieme al pianto, si verificano cambiamenti nel corpo. Nel momento del dolore viene rilasciata la prolattina, che aiuta a rilassarsi. E lacrime di risate o di felicità attenuano l'influenza dell'adrenalina.
Ghiandole lacrimali
Considera da dove vengono le lacrime. Sono prodotti da ghiandole chiamate glandulae lacrimales. Circa 20 piccole ghiandole si trovano nella parte esterna superiore della membrana connettiva degli occhi. Sono responsabili della lacrimazione passiva.
Nella cavità ossea della parte esterna dell'orbita, dietro la fascia tarsoorbitale, c'è una grande ghiandola lacrimale. Produce un deflusso di liquidi quando lo stato emotivo cambia.
Il ferro ha la forma di un ferro di cavallo. La sua struttura è eterogenea. Molti lobuli individuali si aprono nella cavità congiuntivale con tubuli. Il tendine divide la ghiandola in due parti:
- reparto orbitale (situato in alto, non visibile in caso di eversione della palpebra);
- regione palpebrale (situata in basso, visualizzata con l'eversione della palpebra).
È innervato da rami del nervo facciale trigemino, fibre simpatiche del ganglio cervicale. L'afflusso di sangue alla ghiandola è fornito dall'arteria lacrimale.
Inoltre, una secrezione mucosa viene secreta direttamente dalla membrana connettiva degli occhi. Contribuisce a un'ulteriore idratazione del corpo.
Organi lacrimali
Per capire da dove provengono le lacrime, analizziamo l'anatomia dell'organo e il loro percorso. Il sistema è costituito da una serie di organi:
- flusso lacrimale;
- lago lacrimale;
- apertura lacrimale superiore e inferiore;
- tubuli;
- sacco lacrimale;
- canale nasolacrimale.
Il processo inizia nella parte superiore della congiuntiva. Le lacrime scorrono attraverso i dotti, lavando il bulbo oculare. Una volta nel ruscello, il liquido si sposta nel lago. I punti lacrimali superiori e inferiori sono immersi in esso. I loro fori sono strettamente collegati al bulbo oculare.
L'osso lacrimale ha un solco. Contiene una sacca in cui scorrono i tubuli. La fossa si trova approssimativamente nella regione del legamento interno delle palpebre. Il canale nasolacrimale è una continuazione del sacco. Si compone di due parti (ossa e membranosa).
La capacità di versare lacrime in connessione con le esperienze emotive è inerente solo agli esseri umani. Negli animali, questo fluido svolge solo funzioni fisiologiche.
Video utile sul perché sono necessarie le lacrime
Da un punto di vista medico, le lacrime sono la risposta del corpo al dolore fisico o allo stress. Scientificamente parlando si tratta di un fenomeno secretomotorio, caratterizzato dalla secrezione di un liquido da parte delle ghiandole lacrimali che non irrita gli occhi.
Gli scienziati hanno scoperto che esiste una connessione neurale tra le ghiandole lacrimali e le aree del cervello umano responsabili delle emozioni.
Naturalmente, la lacrimazione può essere provocata non solo da ragioni emotive, ma anche fisiologiche: può essere causata da un'infezione, da un corpo estraneo o da una sostanza che è entrata nell'occhio. Ma la composizione chimica delle lacrime durante il pianto emotivo è diversa in quanto contiene, oltre all'acqua e ad alcuni minerali, una serie di ormoni dello stress che il corpo produce durante una forte esperienza o uno stress mentale prolungato.
Esiste un'ipotesi secondo la quale le lacrime rimuovono le sostanze ormonali in eccesso dal corpo e quindi, dopo aver pianto, una persona prova sollievo. Non tutti gli scienziati, tuttavia, sono d'accordo con lei, ritenendo che la composizione delle lacrime rifletta parzialmente la composizione del sangue e non abbia nulla a che fare con lo scarico dell'eccesso.
Un altro fatto noto testimonia contro questa ipotesi: le persone piangono non solo per la tristezza e per un forte dolore emotivo o fisico, ma anche per la gioia. C'è chi, come si suol dire, “ha gli occhi sempre in un luogo umido”: qualsiasi evento significativo o evento solenne può commuovere fino alle lacrime, che si tratti di un matrimonio, di un'esibizione di un idolo a un concerto rock, o della perdita di la loro squadra di calcio preferita.
Non "perché", ma "perché"
Piangere è sollievo dallo stress. Le ghiandole lacrimali, rilasciando liquido, non consentono ai vasi oculari di gonfiarsi e provocano gonfiore del bulbo oculare, c'è anche un forte pompaggio respiratorio dei polmoni, che consente di saturare gli organi con l'ossigeno e in qualche modo indebolire la nitidezza delle sensazioni.

Ma non è tutto. Per alcuni, le lacrime possono scorrere come risultato di un'esperienza estetica, in una galleria davanti a un dipinto di un grande maestro, al suono di belle linee poetiche o musica. Le lacrime possono causare un cielo stellato o un paesaggio di montagna. Questo è ciò che lo psicologo dell'ospedale dell'Università della California, Ph.D. Steven Sideroff, chiama "scioglimento".
C'è un'altra funzione del pianto: sociale. Numerosi studi tra culture diverse dimostrano che il pianto ci aiuta a connetterci più strettamente con le nostre famiglie, i nostri cari e gli amici. Le lacrime sono un segnale di vulnerabilità e, consapevolmente o inconsapevolmente, sono strategicamente progettate per legare emotivamente chi le osserva.

Gli esperti sono unanimi sul fatto che le donne piangono più degli uomini, tuttavia è improbabile che i non esperti ne discutano. Nella nostra epoca di emancipazione, questo stato di cose sta cambiando, ma finora le lacrime di molti uomini sono disapprovate come un segno di debolezza che a un uomo non si addice.
Gli estroversi piangono più spesso degli introversi, è facile per una donna con un disturbo d'ansia, così come una persona con empatia altamente sviluppata, piangere, - tali conclusioni sono state tratte da un gruppo di psicologi guidati da Lauren Bylsma, una studentessa laureata presso l'Università della Florida del Sud (Tampa).
Sfortunatamente, la ricerca sul pianto ci dice sempre più ciò che già sappiamo per esperienza e raramente fornisce risposte a domande davvero interessanti.

Ad esempio, perché alcune persone dicono che dopo aver pianto si sentono molto meglio, altri non avvertono cambiamenti positivi nelle loro condizioni e alcuni addirittura si sentono peggio?
Lauren Bylsma e i suoi colleghi hanno intervistato 200 donne in Olanda e hanno scoperto che quelle donne che avevano alti tassi di depressione o ansia hanno sperimentato un deterioramento del loro stato emotivo dopo aver pianto. Ma perché esattamente questo accade, nessuno lo sa esattamente.
Gli animali piangono?
Sembrerebbe che ci sia una risposta a questa domanda. Molti articoli di psicologi e fisiologi affermano che l'uomo è l'unica specie biologica il cui pianto è una reazione emotiva, mentre gli animali piangono solo quando i loro occhi sono irritati. Tuttavia, ci sono ampie prove che mettono in dubbio che ciò sia vero. Gli elefanti sono particolarmente comuni nelle storie di animali piangenti.

Anche Charles Darwin, nel suo libro The Expression of Emotions in Man and Animals, ha raccontato la testimonianza di un guardiano dello zoo di Londra che ha visto gli elefanti indiani piangere per il dolore. E nel 2013, molti media di tutto il mondo hanno pubblicato la foto di un elefantino in lacrime, nato nello zoo cinese e rifiutato dalla madre. Il bambino ha pianto per 5 ore di seguito, secondo il custode, che in seguito lo ha "adottato".

Parlano di cani che versano lacrime di desiderio per il loro proprietario, di piccoli macachi che piangono separati dalla madre, ma finora non c'è una risposta definitiva alla domanda se queste lacrime siano una coincidenza.
Se il pianto con la lacrimazione è inerente esclusivamente agli esseri umani, allora sorge un'altra domanda, a cui non c'è nemmeno una risposta esatta: quando e come si è formata in noi una tale reazione emotiva?
Lo psicologo Paul McLean avanza la seguente ipotesi. La parte vocale del pianto si è formata come un “segnale di commiato”, necessario per il ricongiungimento tra genitori e figli. Ma le lacrime, secondo la sua ipotesi, sono sorte quando è apparsa una connessione tra le strutture del cervello umano e il fuoco. Nelle prime fasi della sua storia, l'uomo era fortemente dipendente dal fuoco e i suoi occhi spesso lacrimavano sotto l'influenza del fumo. Forse, suggerisce McLean, il fumo è stato successivamente associato alla perdita di vite umane, e quindi al dolore. L'ipotesi non sembra essere coerente, ma nessuno spiega esattamente come una tale reazione si sia effettivamente formata in una persona con un sufficiente grado di certezza.
Si presume che le lacrime, come segnale di allarme visibile, siano apparse in una fase in cui era importante per una persona che un'altra persona leggesse questo segnale e venisse in soccorso, ma una bestia predatrice non riusciva a capire che il suo avversario era vulnerabile, che cioè, il pianto con la lacrimazione si sarebbe sviluppato come una sorta di sistema di segnalazione pubblico interno.
In un modo o nell'altro, ma oggi le lacrime svolgono con successo una funzione di segnalazione.
Il biologo Oren Hansen dell'Università di Tel Aviv, che è anche terapeuta familiare, crede che nelle relazioni emotive tra le persone, le lacrime non debbano essere considerate qualcosa di indecente: "Troppo spesso le persone che piangono sono chiamate stupide o deboli", dice, "allora come in realtà le lacrime sono solo legate ai loro sentimenti. In genere vogliono simpatia e abbracci".
Dobbiamo reprimere le lacrime?
Lo psicologo S. Sideroff ritiene che questa sia una cattiva abitudine, che porta al fatto che sopprimendo il bisogno interno di rispondere a un'emozione, una persona inizia a ignorare i propri sentimenti, e questo è il percorso verso la depressione. La tristezza e il dolore devono essere riconosciuti, non hanno bisogno di vergognarsi. Negandoci di piangere, trasferiamo il dolore emotivo a livello somatico.

Lo ha detto bene lo psichiatra inglese Henry Maudsley: "Il dolore, che non ha sfogo nelle lacrime, fa singhiozzare gli organi interni".
Gli organi responsabili della produzione e della circolazione delle lacrime sono un sistema piuttosto complesso che svolge un ruolo enorme nel funzionamento dell'occhio. Tutti gli organi lacrimali sono divisi in due gruppi: secretorio lacrimale e lacrimale.
Il liquido lacrimale è una soluzione limpida con un sapore salato, una reazione leggermente alcalina. Idrata continuamente la superficie del bulbo oculare e viene sintetizzato (uno di questi è grande, il resto è aggiuntivo). Lo strappo gioca un ruolo importante nelle buone prestazioni del sistema ottico.
Composizione delle lacrime
Il liquido lacrimale è costituito principalmente da acqua (98%). Contiene anche elettroliti, una piccola miscela di lipidi, proteine, mucopolisaccaridi e alcuni altri composti organici.
Normalmente, il liquido lacrimale forma un film sulla superficie dell'occhio, che fornisce morbidezza e trasparenza. Poiché contiene uno strato lipidico a contatto con l'aria, non si secca. Il prossimo è lo strato acquoso con la mucina disciolta al suo interno e lo strato mucoide è già adiacente direttamente alla cornea. Lo strato acquoso è prodotto dalle ghiandole accessorie e lacrimali e dalla ghiandola lacrimale stessa. A causa dello stesso strato mucoide, viene creato un adattamento stretto del film alla superficie della cornea.

Il ruolo fisiologico delle lacrime
Il ruolo principale del liquido lacrimale è protettivo. Grazie al fatto che è costantemente sulla superficie dell'occhio, migliora anche le proprietà ottiche della cornea.
Le funzioni delle lacrime includono anche trofiche. È associato a sali, lipidi e proteine disciolte nel liquido lacrimale che nutrono la cornea. La composizione del liquido contiene anche lisozima, che fornisce protezione contro la penetrazione dei batteri (azione battericida).
Una lacrima protegge anche l'occhio dalle piccole particelle meccaniche, poiché aiuta a rimuovere queste ultime dalla superficie della cornea e della mucosa. Viene sintetizzato circa 1 mm di liquido lacrimale al giorno. Questo è sufficiente per irrigare continuamente la superficie dell'occhio. Se una particella estranea entra nell'occhio o è esposto a fattori esterni (luce, temperatura, vento), così come con alcune esperienze emotive, la quantità di liquido lacrimale aumenta a causa dell'attivazione della grande ghiandola lacrimale.
Sintomi di danno all'apparato lacrimale dell'occhio
Le malattie che sono accompagnate da danni agli organi lacrimali sono piuttosto diverse.
Con una produzione insufficiente di lacrime, si verifica secchezza dell'occhio, che è accompagnata da una sensazione di bruciore, sensazione, corpi estranei nell'occhio. Con l'aumento della produzione di lacrime o una violazione del suo deflusso. La causa del deflusso disturbato può verificarsi a qualsiasi livello del sistema tubulare, a partire dalla regione inferiore, terminando con i canalicoli nasolacrimali e lacrimali.
Molto spesso, a causa del ristagno delle lacrime, si verificano cambiamenti infiammatori nel sacco lacrimale. Esternamente, questo si manifesta con dolore e gonfiore nell'area dell'infiammazione. La stessa ghiandola lacrimale è più spesso infiammata a causa di processi specifici che colpiscono il tessuto ghiandolare.
Metodi diagnostici per lesioni dell'apparato lacrimale dell'occhio
Se sospetti problemi con gli organi lacrimali, dovresti iniziare con un esame esterno. Successivamente è la palpazione del sacco lacrimale, che è doloroso in caso di infiammazione. Dopo che il medico gira la palpebra superiore, puoi facilmente esaminare la zona palpebrale della ghiandola lacrimale. È conveniente farlo usando una lampada a fessura. Durante l'esecuzione, vengono visualizzate anche le aperture lacrimali e viene anche valutata la completezza dell'idratazione della superficie della cornea e della congiuntiva.
Se si esegue un test utilizzando un colorante speciale (rosa del Bengala), è possibile determinare le cellule epiteliali non vitali, che sono un segno di lavoro insufficiente delle ghiandole lacrimali.
La pervietà dei dotti e dei tubuli può essere valutata lavandoli con acqua sterile con fluoresceina diluita in essa. Con normale pervietà dei dotti lacrimali, la soluzione posta nel sacco congiuntivale può essere rilevata nella cavità nasale dopo pochi secondi.
Se c'è motivo di sospettare un disturbo della pervietà, deve essere eseguito un esame radiografico con mezzo di contrasto. Utilizzando questa tecnica (dattriocistografia a contrasto), è possibile determinare chiaramente il livello di ostruzione, nonché il grado di ostruzione.
Per valutare la velocità di sintesi del liquido lacrimale, è necessario eseguire uno strip test (test di Schirmer). In questo caso, vengono posizionate delle strisce speciali dietro la palpebra inferiore e viene valutata la velocità di bagnarsi. Se la velocità è inferiore a 1 mm al minuto, la secrezione della lacrima è considerata insufficiente. Va tenuto presente che il liquido lacrimale diminuisce di quantità sotto l'influenza di alcuni farmaci.

Malattie con danno all'apparato lacrimale dell'occhio
Il trattamento della patologia dipende direttamente dalla causa del suo sviluppo. Se la produzione di liquido lacrimale viene interrotta, oltre alla terapia etiotropica, viene utilizzata la sostituzione, cioè una lacrima artificiale, che dovrebbe essere regolarmente instillata. A volte, per ridurre il deflusso delle lacrime dalla superficie dell'occhio, le aperture lacrimali vengono bloccate mediante appositi tappi.
Se ci sono segni di infiammazione, è necessario prescrivere una terapia antinfiammatoria. In caso di violazione della pervietà dei percorsi, è possibile eseguire un intervento chirurgico o un bougienage.
Se l'ostruzione è persistente, ricorrere alla dacriocistorinostomia. Allo stesso tempo, viene applicata un'anastomosi tra il sacco lacrimale e la cavità nasale attraverso lo strato osseo.
L'uomo moderno sa molto su come funziona il suo corpo. Ma vale la pena ricordare che oltre ai grandi sistemi vitali, ci sono piccoli organi e ghiandole. Si trovano in tutto il corpo e svolgono un ruolo significativo nelle condizioni generali del corpo. Un esempio sono i canali lacrimali, dal lavoro da cui dipende la condizione degli occhi.
Cos'è una ghiandola?
Una ghiandola è un organo costituito da cellule secretorie. Serve a produrre sostanze specifiche di natura chimica diversa. La ghiandola può rimuovere il segreto prodotto all'esterno o all'ambiente interno del corpo. I canali lacrimali umani, le ghiandole endocrine e il pancreas possono essere citati come esempio di questi organi.
Gli organi che svelano il segreto sono chiamati esocrini. Le ghiandole che producono un segreto sintetizzato nel sistema circolatorio o linfatico sono chiamate endocrine.
Ghiandole lacrimali dell'uomo. Posizione
Cerca le ghiandole lacrimali appena sotto il bordo esterno superiore dell'orbita. Soprattutto sotto di loro, nell'osso frontale si formava una fossa lacrimale sotto forma di una rientranza poco profonda. Per evitare che la ghiandola si sposti, ci sono corde fibrose, cioè che supportano i muscoli degli occhi e delle palpebre, inoltre sono trattenute dal tessuto adiposo. In media, in un adulto, questi organi misurano 10x20x5 mm. Una ghiandola pesa non più di 0,8 g.

Struttura
Nella sua struttura, la ghiandola lacrimale è alveolare-tubulare. È formato da due quote disuguali:
- orbitale, che si trova in alto ed ha un volume leggermente maggiore;
- palpebrale, che è chiamato lobo inferiore.
Tra i lobi in cui si produce il liquido lacrimale vi è un'aponeurosi del muscolo responsabile del sollevamento della palpebra superiore. Da ciascuno di essi ci sono 5-6 condotti. A poco a poco, vengono combinati in un unico grande condotto.
La parte inferiore della ghiandola ha un cancello. Le arterie e le vene li attraversano, fornendo all'organo sangue, vasi linfatici e il dotto principale della ghiandola, in cui convergono tutti i piccoli dotti lacrimali. Il lume del dotto è aperto nella congiuntiva. La sua uscita si trova nella parte esterna, a circa 5 mm dal punto estremo della palpebra superiore. A volte c'è una partenza di tratti escretori aggiuntivi. Questi piccoli dotti terminano anche al fornice della congiuntiva. Alcuni dotti portano il liquido lacrimale nella regione temporale della congiuntiva, altri nel canto esterno dell'occhio. Quando una persona chiude gli occhi, le lacrime scorrono lungo la parte posteriore delle palpebre, dove si trova il flusso lacrimale, e attraverso il lago lacrimale nelle piccole aperture ai bordi delle palpebre.

Il dotto superiore, che corre lungo l'orbita lungo la fossa ossea, è chiamato sacco lacrimale. Le sue pareti danno origine a numerosi percorsi attraverso i quali scorre il liquido lacrimale.
La parte inferiore della ghiandola lacrimale si trova nella regione subaponeurotica sotto la palpebra inferiore. È costituito da numerosi lobuli di collegamento. Di solito ce ne sono 25-30. Tutti i dotti dei lobuli portano alla ghiandola principale.
Un grande dotto nasolacrimale passa attraverso la base ossea della parete esterna della cavità nasale. Questo canale lacrimale si apre nella cavità nasale con uno spazio speciale nella regione della conca inferiore. Lo spazio vuoto è coperto da una valvola dalla piega della mucosa.
Funzioni
Le ghiandole lacrimali producono una speciale secrezione liquida che ha molte funzioni:
- rimozione di corpi estranei e sporco dall'occhio;
- protezione dall'asciugatura della superficie;
- consegna di nutrienti alla congiuntiva e alla cornea;
- rifrazione della luce;
- lubrificazione durante il movimento delle palpebre;
- protezione antibatterica.

Cos'è una lacrima?
Il liquido lacrimale è un trasudato chiaro che si accumula nelle cavità sierose (proteiche). Nella composizione chimica delle lacrime si osservano coincidenze con la composizione del sangue. Tuttavia, hanno una maggiore concentrazione di potassio e fluoro e un contenuto inferiore di acidi organici. La composizione chimica delle lacrime reagisce allo stato del corpo ed è in continua evoluzione.
La base del liquido lacrimale è l'acqua. Sale (1,5% NaCl), albumina (0,5%), muco si sciolgono in esso. Se esaminato, mostra una reazione leggermente alcalina. Le lacrime possono essere riflessive ed emotive. Nel primo caso, il corpo utilizza la lacrima rilasciata per inumidire e pulire l'occhio. Nel secondo caso - per alleviare la tensione e l'ansia. Le cellule secretorie delle ghiandole lacrimali producono una piccola quantità di una sostanza psicotropa che può portare sollievo in situazioni stressanti. In uno stato di disperazione, gli ormoni dello stress leucina-encefalina e prolattina compaiono in lacrime. Le lacrime felici riducono la quantità di adrenalina, che aumenta notevolmente quando si è sovraeccitati. Inoltre, le cellule secretorie forniscono la presenza di immunoglobuline, numerose proteine, aminoacidi, sostanze enzimatiche, urea e altri elementi chimici nel liquido lacrimale.

Dato che ora hai un'idea approssimativa di cosa sia il liquido lacrimale, capisci che la capacità di piangere è molto importante per una persona. Le lacrime non sono solo un segno di un aumento del background emotivo, ma anche un assistente per i nostri occhi, preservandone la salute.