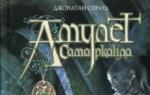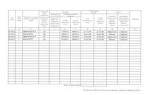Quale gamma di suoni può sentire l'orecchio umano? Meccanismo dell'orecchio e della percezione del suono
Per il nostro orientamento nel mondo che ci circonda, l'udito gioca lo stesso ruolo della vista. L'orecchio ci permette di comunicare tra noi utilizzando i suoni; ha una sensibilità speciale per le frequenze sonore della parola. Con l'aiuto dell'orecchio, una persona capta varie vibrazioni sonore nell'aria. Le vibrazioni provenienti da un oggetto (sorgente sonora) vengono trasmesse attraverso l'aria, che svolge il ruolo di trasmettitore del suono, e vengono captate dall'orecchio. L'orecchio umano percepisce le vibrazioni dell'aria con una frequenza compresa tra 16 e 20.000 Hz. Le vibrazioni con una frequenza più alta sono considerate ultrasoniche, ma l'orecchio umano non le percepisce. La capacità di distinguere i toni alti diminuisce con l'età. La capacità di captare il suono con entrambe le orecchie consente di determinare dove si trova. Nell'orecchio, le vibrazioni dell'aria vengono convertite in impulsi elettrici, che vengono percepiti dal cervello come suono.
L'orecchio ospita anche l'organo che rileva il movimento e la posizione del corpo nello spazio - apparato vestibolare. Il sistema vestibolare gioca un ruolo importante nell’orientamento spaziale di una persona, analizza e trasmette informazioni sulle accelerazioni e decelerazioni del movimento lineare e rotatorio, nonché quando la posizione della testa cambia nello spazio.
Struttura dell'orecchio
In base alla struttura esterna, l'orecchio è diviso in tre parti. Le prime due parti dell'orecchio, quella esterna (esterna) e quella centrale, conducono il suono. La terza parte - l'orecchio interno - contiene cellule uditive, meccanismi per percepire tutte e tre le caratteristiche del suono: altezza, forza e timbro.
Orecchio esterno- si chiama la parte sporgente dell'orecchio esterno padiglione auricolare, la sua base è costituita da un tessuto di sostegno semirigido: la cartilagine. La superficie anteriore del padiglione auricolare ha una struttura complessa e una forma variabile. È costituito da cartilagine e tessuto fibroso, ad eccezione della parte inferiore, il lobulo (lobo dell'orecchio), formato da tessuto adiposo. Alla base del padiglione auricolare si trovano i muscoli auricolari anteriori, superiori e posteriori, i cui movimenti sono limitati.
Oltre alla funzione acustica (raccolta del suono), il padiglione auricolare svolge un ruolo protettivo, proteggendo il condotto uditivo nel timpano dagli influssi ambientali dannosi (acqua, polvere, forti correnti d'aria). Sia la forma che la dimensione delle orecchie sono individuali. La lunghezza del padiglione auricolare negli uomini è di 50–82 mm e la larghezza di 32–52 mm; nelle donne le dimensioni sono leggermente più piccole. La piccola area del padiglione auricolare rappresenta tutta la sensibilità del corpo e degli organi interni. Pertanto, può essere utilizzato per ottenere informazioni biologicamente importanti sullo stato di qualsiasi organo. Il padiglione auricolare concentra le vibrazioni sonore e le dirige verso l'apertura uditiva esterna.
Canale uditivo esterno serve a condurre le vibrazioni sonore dell'aria dal padiglione auricolare al timpano. Il canale uditivo esterno ha una lunghezza da 2 a 5 cm, il suo terzo esterno è formato da tessuto cartilagineo e i 2/3 interni sono formati da osso. Il canale uditivo esterno è arcuato nella direzione superiore-posteriore e si raddrizza facilmente quando il padiglione auricolare viene tirato su e indietro. Nella pelle del condotto uditivo sono presenti ghiandole speciali che secernono una secrezione giallastra (cerume), la cui funzione è quella di proteggere la pelle dalle infezioni batteriche e da particelle estranee (insetti).
Il canale uditivo esterno è separato dall'orecchio medio dal timpano, che è sempre retratto verso l'interno. Si tratta di una sottile placca di tessuto connettivo, ricoperta all'esterno da epitelio multistrato e all'interno da mucosa. Il canale uditivo esterno serve a condurre le vibrazioni sonore al timpano, che separa l'orecchio esterno dalla cavità timpanica (orecchio medio).
Orecchio medio, o cavità timpanica, è una piccola camera piena d'aria che si trova nella piramide dell'osso temporale ed è separata dal canale uditivo esterno dal timpano. Questa cavità ha pareti ossee e membranose (membrana timpanica).

Timpanoè una membrana a basso movimento spessa 0,1 micron, tessuta da fibre che corrono in direzioni diverse e sono tese in modo non uniforme in aree diverse. A causa di questa struttura, il timpano non ha un proprio periodo di oscillazione, il che porterebbe ad un'amplificazione dei segnali sonori che coincidono con la frequenza delle proprie oscillazioni. Inizia a vibrare sotto l'influenza delle vibrazioni sonore che passano attraverso il canale uditivo esterno. Attraverso un'apertura sulla parete posteriore, la membrana timpanica comunica con la grotta mastoidea.
L'apertura della tromba uditiva (di Eustachio) si trova nella parete anteriore della cavità timpanica e conduce nella parte nasale della faringe. Grazie a ciò, l'aria atmosferica può entrare nella cavità timpanica. Normalmente, l'apertura della tromba di Eustachio è chiusa. Si apre durante i movimenti di deglutizione o di sbadiglio, aiutando a bilanciare la pressione dell'aria sul timpano dal lato della cavità dell'orecchio medio e dall'apertura uditiva esterna, proteggendolo così da rotture che portano a danni all'udito.
Nella cavità timpanica si trovano ossicini uditivi. Sono di dimensioni molto piccole e sono collegati in una catena che si estende dal timpano fino alla parete interna della cavità timpanica.

L'osso più esterno è martello- il suo manico è collegato al timpano. La testa del martello è collegata all'incudine, che si articola in modo mobile con la testa staffe.

Gli ossicini uditivi hanno ricevuto tali nomi a causa della loro forma. Le ossa sono ricoperte da una membrana mucosa. Due muscoli regolano il movimento delle ossa. La connessione delle ossa è tale da aumentare di 22 volte la pressione delle onde sonore sulla membrana della finestra ovale, consentendo alle onde sonore deboli di spostare il liquido all'interno lumaca.

Orecchio interno racchiuso nell'osso temporale ed è un sistema di cavità e canali situati nella sostanza ossea della parte petrosa dell'osso temporale. Insieme formano il labirinto osseo, all'interno del quale si trova il labirinto membranoso. Labirinto osseoÈ una cavità ossea di varia forma ed è costituita dal vestibolo, da tre canali semicircolari e dalla coclea. Labirinto membranoso consiste in un complesso sistema di sottili formazioni membranose situate nel labirinto osseo.

Tutte le cavità dell'orecchio interno sono piene di liquido. All'interno del labirinto membranoso c'è l'endolinfa, e il fluido che lava il labirinto membranoso all'esterno è la perilinfa ed è simile nella composizione al liquido cerebrospinale. L'endolinfa differisce dalla perilinfa (contiene più ioni potassio e meno ioni sodio) - trasporta una carica positiva rispetto alla perilinfa.
Preludio- la parte centrale del labirinto osseo, che comunica con tutte le sue parti. Dietro al vestibolo ci sono tre canali ossei semicircolari: superiore, posteriore e laterale. Il canale semicircolare laterale è orizzontale, gli altri due sono ad angolo retto. Ogni canale ha una parte espansa: un'ampolla. Contiene un'ampolla membranosa piena di endolinfa. Quando l'endolinfa si muove durante un cambiamento nella posizione della testa nello spazio, le terminazioni nervose sono irritate. L'eccitazione viene trasmessa lungo le fibre nervose al cervello.
Lumacaè un tubo a spirale che forma due giri e mezzo attorno ad un'asta ossea a forma di cono. È la parte centrale dell'organo uditivo. All'interno del canale osseo della coclea è presente un labirinto membranoso, o dotto cocleare, al quale si avvicinano le terminazioni della parte cocleare dell'ottavo nervo cranico. Le vibrazioni della perilinfa vengono trasmesse all'endolinfa del dotto cocleare e attivano le terminazioni nervose della parte uditiva dell'ottavo nervo cranico.

Il nervo vestibolococleare è costituito da due parti. La parte vestibolare conduce gli impulsi nervosi dal vestibolo e dai canali semicircolari ai nuclei vestibolari del ponte e del midollo allungato e successivamente al cervelletto. La parte cocleare trasmette l'informazione lungo le fibre che seguono dall'organo spirale (corti) ai nuclei uditivi del tronco cerebrale e poi - attraverso una serie di commutazioni nei centri sottocorticali - alla corteccia della parte superiore del lobo temporale del cervello. emisfero.
Meccanismo di percezione delle vibrazioni sonore
I suoni nascono a causa delle vibrazioni dell'aria e sono amplificati nel padiglione auricolare. L'onda sonora viene quindi condotta attraverso il canale uditivo esterno al timpano, facendolo vibrare. La vibrazione del timpano viene trasmessa alla catena degli ossicini uditivi: martello, incudine e staffa. La base della staffa è fissata alla finestra del vestibolo con l'aiuto di un legamento elastico, grazie al quale le vibrazioni vengono trasmesse alla perilinfa. A loro volta, attraverso la parete membranosa del condotto cocleare, queste vibrazioni passano all'endolinfa, il cui movimento provoca l'irritazione delle cellule recettrici dell'organo spirale. L'impulso nervoso risultante segue le fibre della parte cocleare del nervo vestibolococleare fino al cervello.

La traduzione dei suoni percepiti dall'organo dell'udito come sensazioni piacevoli e spiacevoli viene effettuata nel cervello. Le onde sonore irregolari producono la sensazione del rumore, mentre le onde regolari e ritmiche vengono percepite come toni musicali. I suoni viaggiano ad una velocità di 343 km/s ad una temperatura dell'aria di 15–16ºС.
Spesso valutiamo la qualità del suono. Quando si sceglie un microfono, un software di elaborazione audio o un formato di registrazione di file audio, una delle domande più importanti è quanto suonerà bene. Ma ci sono differenze tra le caratteristiche del suono che possono essere misurate e quelle che possono essere udite.
Tono, timbro, ottava.
Il cervello percepisce i suoni di determinate frequenze. Ciò è dovuto alle peculiarità del meccanismo dell'orecchio interno. I recettori situati sulla membrana principale dell'orecchio interno convertono le vibrazioni sonore in potenziali elettrici che eccitano le fibre nervose uditive. Le fibre del nervo uditivo hanno selettività di frequenza dovuta all'eccitazione delle cellule dell'organo del Corti situate in diversi punti della membrana principale: le alte frequenze vengono percepite vicino alla finestra ovale, le basse frequenze vengono percepite all'apice della spirale.
La caratteristica fisica del suono, la frequenza, è strettamente correlata all'altezza che percepiamo. La frequenza viene misurata come il numero di cicli completi di un'onda sinusoidale in un secondo (hertz, Hz). Questa definizione di frequenza si basa sul fatto che un'onda sinusoidale ha esattamente la stessa forma d'onda. Nella vita reale, pochissimi suoni hanno questa proprietà. Tuttavia, qualsiasi suono può essere rappresentato come un insieme di oscillazioni sinusoidali. Di solito chiamiamo questo set un tono. Cioè, un tono è un segnale di una certa altezza che ha uno spettro discreto (suoni musicali, suoni vocalici del discorso), in cui viene evidenziata la frequenza di un'onda sinusoidale, che ha l'ampiezza massima in questo insieme. Un segnale con un ampio spettro continuo, le cui componenti di frequenza hanno tutte la stessa intensità media, è chiamato rumore bianco.
Un aumento graduale della frequenza delle vibrazioni sonore è percepito come un cambiamento graduale del tono dal più basso (basso) al più alto.
Il grado di precisione con cui una persona determina l'altezza di un suono a orecchio dipende dall'acutezza e dalla formazione del suo udito. L'orecchio umano può distinguere chiaramente due toni di tono vicino. Ad esempio, nella gamma di frequenza di circa 2000 Hz, una persona può distinguere tra due toni che differiscono l'uno dall'altro in frequenza di 3-6 Hz o anche meno.
Lo spettro di frequenze di uno strumento musicale o di una voce contiene una sequenza di picchi equidistanti: armoniche. Corrispondono a frequenze multiple di una certa frequenza base, la più intensa delle onde sinusoidali che compongono il suono.
Il suono particolare (timbro) di uno strumento musicale (voce) è associato all'ampiezza relativa di varie armoniche e l'altezza percepita da una persona trasmette in modo più accurato la frequenza di base. Il timbro, essendo un riflesso soggettivo del suono percepito, non ha una valutazione quantitativa ed è caratterizzato solo qualitativamente.
In un tono “puro” esiste una sola frequenza. Tipicamente, il suono percepito è costituito dalla frequenza del tono principale e da diverse frequenze "impurità", chiamate sovratoni. I sovratoni sono multipli della frequenza del tono principale e hanno un'ampiezza minore. Il timbro del suono dipende dalla distribuzione dell'intensità dalla distribuzione dell'intensità tra gli armonici. Lo spettro delle combinazioni di suoni musicali, chiamato accordo, dipende dalla distribuzione dell'intensità tra gli armonici. Tale spettro contiene diverse frequenze fondamentali insieme agli armonici di accompagnamento.
Se la frequenza di un suono è esattamente il doppio della frequenza di un altro, le onde sonore “si adattano” l’una all’altra. La distanza di frequenza tra tali suoni è chiamata ottava. La gamma di frequenze percepite dagli esseri umani, 16-20.000 Hz, copre circa da dieci a undici ottave.
Ampiezza delle vibrazioni sonore e volume.
La parte udibile della gamma sonora è divisa in suoni a bassa frequenza - fino a 500 Hz, media frequenza - 500-10.000 Hz e alta frequenza - oltre 10.000 Hz. L'orecchio è più sensibile a una gamma relativamente ristretta di suoni a media frequenza da 1000 a 4000 Hz. Cioè, i suoni con la stessa intensità nella gamma delle frequenze medie possono essere percepiti come forti, ma nella gamma delle frequenze basse o alte possono essere percepiti come silenziosi o non essere affatto uditi. Questa caratteristica della percezione del suono è dovuta al fatto che le informazioni sonore necessarie per l'esistenza umana - parole o suoni della natura - vengono trasmesse principalmente nella gamma delle frequenze medie. Pertanto, il volume non è un parametro fisico, ma l'intensità della sensazione uditiva, una caratteristica soggettiva del suono associata alle caratteristiche della nostra percezione.
L'analizzatore uditivo percepisce un aumento dell'ampiezza dell'onda sonora dovuto ad un aumento dell'ampiezza della vibrazione della membrana principale dell'orecchio interno e alla stimolazione di un numero crescente di cellule ciliate con la trasmissione di impulsi elettrici a una frequenza più elevata e lungo un maggior numero di fibre nervose.
Il nostro orecchio può distinguere l'intensità del suono nella gamma dal più debole sussurro al rumore più forte, che corrisponde approssimativamente ad un aumento dell'ampiezza del movimento della membrana principale di 1 milione di volte. Tuttavia, l'orecchio interpreta questa enorme differenza nell'ampiezza del suono come un cambiamento di circa 10.000 volte. Cioè, la scala di intensità è fortemente “compressa” dal meccanismo di percezione del suono dell'analizzatore uditivo. Ciò consente a una persona di interpretare le differenze nell'intensità del suono su una gamma estremamente ampia.
L'intensità del suono si misura in decibel (dB) (1 bel equivale a dieci volte l'ampiezza). Lo stesso sistema viene utilizzato per determinare le variazioni di volume.
Per confronto, possiamo fornire un livello approssimativo di intensità di diversi suoni: suono appena udibile (soglia di udibilità) 0 dB; sussurro vicino all'orecchio 25-30 dB; volume medio della parola 60-70 dB; parlato molto forte (urla) 90 dB; ai concerti di musica rock e pop al centro della sala 105-110 dB; accanto ad un aereo di linea in decollo 120 dB.
L'entità dell'incremento del volume del suono percepito ha una soglia di discriminazione. Il numero di gradazioni di volume distinte alle frequenze medie non supera 250; alle frequenze basse e alte diminuisce bruscamente e si aggira in media intorno a 150.
La perdita dell'udito è una condizione patologica caratterizzata da diminuzione dell'udito e difficoltà di comprensione del linguaggio parlato. Si verifica abbastanza spesso, soprattutto negli anziani. Tuttavia, al giorno d'oggi c'è la tendenza ad uno sviluppo precoce della perdita dell'udito, anche tra i giovani e i bambini. A seconda di quanto l’udito è indebolito, la perdita dell’udito è divisa in diversi gradi.
Cosa sono i decibel e gli hertz
Qualsiasi suono o rumore può essere caratterizzato da due parametri: altezza e intensità del suono.
Pece
L'altezza di un suono è determinata dal numero di volte in cui un'onda sonora oscilla ed è espressa in hertz (Hz): maggiore è l'hertz, più alta è l'altezza. Ad esempio, il primo tasto bianco a sinistra su un pianoforte normale (il "LA" del subcontratto) produce un suono basso a 27.500 Hz, e l'ultimo tasto bianco a destra (il "DO" della quinta ottava ) produce un suono basso di 4186,0 Hz.
L'orecchio umano è in grado di distinguere i suoni nell'intervallo 16-20.000 Hz. Tutto ciò che è inferiore a 16 Hz è chiamato infrasuono e superiore a 20.000 è chiamato ultrasuono. Sia gli ultrasuoni che gli infrasuoni non vengono percepiti dall'orecchio umano, ma possono influenzare il corpo e la psiche.
In base alla frequenza, tutti i suoni udibili possono essere suddivisi in alta, media e bassa frequenza. I suoni a bassa frequenza includono suoni fino a 500 Hz, i suoni a media frequenza nell'intervallo 500-10.000 Hz, i suoni ad alta frequenza tutti i suoni con una frequenza superiore a 10.000 Hz. L'orecchio umano, a parità di forza d'impatto, percepisce meglio i suoni a media frequenza, che vengono percepiti come più forti. Di conseguenza, le frequenze basse e alte vengono “sentite” più silenziose o addirittura “smettono di suonare” del tutto. In generale, dopo 40-50 anni, il limite superiore di udibilità dei suoni diminuisce da 20.000 a 16.000 Hz.
Potenza del suono
Se l’orecchio è esposto a un suono molto forte, il timpano potrebbe rompersi. Nella foto sotto c'è una membrana normale, in alto c'è una membrana con un difetto.Qualsiasi suono può influenzare l'organo uditivo in diversi modi. Ciò dipende dall'intensità del suono, o volume, che viene misurato in decibel (dB).
L'udito normale è in grado di distinguere i suoni da 0 dB e oltre. Se esposto a un suono forte superiore a 120 dB.
L'orecchio umano si sente più a suo agio nell'intervallo fino a 80–85 dB.
Per confronto:
- foresta invernale con tempo calmo - circa 0 dB,
- fruscio delle foglie nel bosco, parco – 20–30 dB,
- discorso normale, lavoro d'ufficio – 40–60 dB,
- rumore del motore all’interno dell’auto – 70–80 dB,
- urla forti – 85–90 dB,
- tuoni - 100 dB,
- un martello pneumatico a una distanza di 1 metro da esso - circa 120 dB.
Gradi di perdita dell'udito rispetto ai livelli di volume
Tipicamente, si distinguono i seguenti gradi di perdita dell'udito:
- Udito normale: una persona sente suoni nell'intervallo da 0 a 25 dB e oltre. Può sentire il fruscio delle foglie, il canto degli uccelli nella foresta, il ticchettio di un orologio a muro, ecc.
- Perdita dell'udito:
- I grado (lieve): una persona inizia a sentire suoni da 26 a 40 dB.
- II grado (moderato) - la soglia per la percezione dei suoni inizia da 40–55 dB.
- III grado (grave): sente suoni da 56 a 70 dB.
- IV grado (profondo) – da 71–90 dB.
- La sordità è una condizione in cui una persona non riesce a sentire un suono più forte di 90 dB.
Una versione abbreviata dei gradi di perdita dell'udito:
- Grado lieve: capacità di percepire suoni inferiori a 50 dB. Una persona capisce quasi completamente la lingua parlata a una distanza superiore a 1 m.
- Grado medio: la soglia per la percezione dei suoni inizia con un volume di 50–70 dB. La comunicazione tra loro è difficile, perché in questo caso una persona sente bene il discorso a una distanza massima di 1 m.
- Grado grave – più di 70 dB. Il parlato di intensità normale non è più udibile o è incomprensibile all'orecchio. Devi urlare o usare un apparecchio acustico speciale.
Nella vita pratica di tutti i giorni, gli specialisti possono utilizzare un’altra classificazione della perdita dell’udito:
- Udito normale. Una persona sente il parlato e sussurra a una distanza superiore a 6 m.
- Lieve perdita dell'udito. Una persona capisce il parlato da una distanza superiore a 6 m, ma sente i sussurri a non più di 3-6 metri di distanza. Il paziente può distinguere il parlato anche nel rumore di fondo.
- Perdita dell'udito moderata. I sussurri possono essere distinti a una distanza non superiore a 1–3 me il normale parlato parlato fino a 4–6 m La percezione del parlato può essere disturbata da rumori estranei.
- Grado significativo di perdita dell'udito. Il discorso colloquiale può essere ascoltato al massimo a una distanza di 2-4 m, mentre il sussurro fino a 0,5-1 m. La percezione delle parole è illeggibile, alcune singole frasi o parole devono essere ripetute più volte.
- Grado severo. I sussurri sono praticamente indistinguibili anche vicino all'orecchio, il parlato difficilmente si distingue anche gridando a una distanza inferiore a 2 metri, legge di più le labbra.
Gradi di perdita dell'udito rispetto all'altezza dei suoni
- Gruppo I. I pazienti sono in grado di percepire solo le basse frequenze nell’intervallo 125-150 Hz. Rispondono solo a voci basse e forti.
- Gruppo II. In questo caso diventano disponibili per la percezione frequenze più alte, che vanno da 150 a 500 Hz. Di solito diventano percepibili le vocali semplici “o” e “u”.
- III gruppo. Buona percezione delle frequenze basse e medie (fino a 1000 Hz). Tali pazienti ascoltano già la musica, distinguono il campanello, sentono quasi tutte le vocali e comprendono il significato di frasi semplici e singole parole.
- IV gruppo. Per la percezione diventano disponibili frequenze fino a 2000 Hz. I pazienti distinguono quasi tutti i suoni, nonché singole frasi e parole. Capiscono il discorso.
Questa classificazione della perdita dell'udito è importante non solo per la corretta selezione dell'apparecchio acustico, ma anche per l'inserimento dei bambini in una scuola normale o specializzata per la perdita dell'udito.
Diagnosi di perdita dell'udito
 L'audiometria aiuterà a determinare il grado di perdita dell'udito in un paziente.
L'audiometria aiuterà a determinare il grado di perdita dell'udito in un paziente. Il modo più accurato e affidabile per identificare e determinare il grado di perdita dell'udito è l'audiometria. A tale scopo, il paziente indossa cuffie speciali nelle quali viene fornito un segnale con frequenze e intensità adeguate. Se il soggetto sente il segnale, lo avvisa premendo il pulsante del dispositivo o annuendo con la testa. Sulla base dei risultati dell'audiometria, viene costruita una corrispondente curva di percezione uditiva (audiogramma), la cui analisi consente non solo di identificare il grado di perdita dell'udito, ma anche in alcune situazioni di ottenere una comprensione più approfondita della natura della perdita dell'udito.
A volte, quando conducono l'audiometria, non indossano le cuffie, ma usano un diapason o semplicemente pronunciano determinate parole a una certa distanza dal paziente.
Quando vedere un medico
È necessario contattare un medico ORL se:
- Cominciavi a girare la testa verso chi parlava, e allo stesso tempo ti sforzavi di ascoltarlo.
- I parenti che vivono con te o gli amici che vengono a trovarti commentano il fatto che hai acceso la TV, la radio o il lettore a un volume troppo alto.
- Il campanello non suona più così chiaramente come prima, oppure potresti non sentirlo più.
- Quando parli al telefono, chiedi all'altra persona di parlare più forte e più chiaramente.
- Hanno iniziato a chiederti di ripetere di nuovo ciò che ti era stato detto.
- Se c'è rumore intorno a te, diventa molto più difficile ascoltare il tuo interlocutore e capire cosa sta dicendo.
Nonostante il fatto che, in generale, quanto prima si effettua una diagnosi corretta e si inizia il trattamento, migliori saranno i risultati e maggiore sarà la probabilità che l'udito persista per molti anni.
Il contenuto dell'articolo
UDITO, capacità di percepire i suoni. L'udito dipende: 1) dall'orecchio - esterno, medio e interno - che percepisce le vibrazioni sonore; 2) il nervo uditivo, che trasmette i segnali ricevuti dall'orecchio; 3) alcune parti del cervello (centri uditivi), in cui gli impulsi trasmessi dai nervi uditivi provocano la consapevolezza dei segnali sonori originali.
Qualsiasi fonte sonora - una corda di violino lungo la quale viene teso un arco, una colonna d'aria che si muove in una canna d'organo o le corde vocali di una persona che parla - provoca vibrazioni nell'aria circostante: prima compressione istantanea, poi rarefazione istantanea. In altre parole, ciascuna sorgente sonora emette una serie di onde alternate di alta e bassa pressione che viaggiano velocemente nell'aria. Questo flusso di onde in movimento crea il suono percepito dagli organi uditivi.
La maggior parte dei suoni che incontriamo ogni giorno sono piuttosto complessi. Sono generati da complessi movimenti oscillatori di una sorgente sonora, creando un intero complesso di onde sonore. Negli esperimenti di ricerca sull'udito, cercano di scegliere i segnali sonori più semplici possibili per facilitare la valutazione dei risultati. Vengono spesi molti sforzi per garantire semplici oscillazioni periodiche della sorgente sonora (come un pendolo). Il flusso risultante di onde sonore di una frequenza è chiamato tono puro; rappresenta un cambiamento regolare e graduale di alta e bassa pressione.
Confini della percezione uditiva.
La sorgente sonora "ideale" descritta può essere fatta vibrare velocemente o lentamente. Ciò permette di chiarire una delle principali domande che si pongono nello studio dell'udito, ovvero quale sia la frequenza minima e massima delle vibrazioni percepite dall'orecchio umano come suono. Gli esperimenti hanno dimostrato quanto segue. Quando le oscillazioni si verificano molto lentamente, meno di 20 cicli di oscillazione completi al secondo (20 Hz), ciascuna onda sonora viene ascoltata separatamente e non forma un tono continuo. All'aumentare della frequenza di vibrazione, una persona inizia a sentire un tono basso e continuo, simile al suono della canna dei bassi più bassa di un organo. Man mano che la frequenza aumenta ulteriormente, l'altezza percepita diventa più alta; a 1000 Hz assomiglia al Do acuto di un soprano. Tuttavia, questa nota è ancora lontana dal limite superiore dell’udito umano. È solo quando la frequenza si avvicina a circa 20.000 Hz che l’orecchio umano normale gradualmente diventa incapace di sentire.
La sensibilità dell'orecchio alle vibrazioni sonore di frequenze diverse non è la stessa. Risponde in modo particolarmente sensibile alle fluttuazioni delle frequenze medie (da 1000 a 4000 Hz). Qui la sensibilità è così grande che qualsiasi aumento significativo della stessa sarebbe sfavorevole: allo stesso tempo si percepirebbe un rumore di fondo costante del movimento casuale delle molecole d'aria. Man mano che la frequenza diminuisce o aumenta rispetto alla gamma media, l'acuità uditiva diminuisce gradualmente. Ai margini della gamma di frequenze percepibili, il suono deve essere molto forte per essere udito, così forte che a volte viene percepito fisicamente prima di essere udito.
Il suono e la sua percezione.
Un tono puro ha due caratteristiche indipendenti: 1) frequenza e 2) forza o intensità. La frequenza è misurata in hertz, cioè determinato dal numero di cicli oscillatori completi al secondo. L'intensità viene misurata dall'entità della pressione pulsante delle onde sonore su qualsiasi superficie in arrivo ed è solitamente espressa in unità logaritmiche relative - decibel (dB). Va ricordato che i concetti di frequenza e intensità si applicano solo al suono come stimolo fisico esterno; questo è il cosiddetto caratteristiche acustiche del suono. Quando parliamo di percezione, ad es. riguardo ad un processo fisiologico, un suono viene valutato come alto o basso e la sua forza è percepita come volume. In generale l'altezza, caratteristica soggettiva del suono, è strettamente correlata alla sua frequenza; I suoni ad alta frequenza vengono percepiti come acuti. Inoltre, per generalizzare, possiamo dire che l'intensità percepita dipende dalla forza del suono: sentiamo i suoni più intensi più forti. Tali rapporti, tuttavia, non sono immutabili e assoluti, come spesso si crede. L'altezza percepita di un suono è influenzata in una certa misura dalla sua intensità, e il volume percepito è influenzato in una certa misura dalla frequenza. Pertanto, modificando la frequenza di un suono, si può evitare di modificare l'altezza percepita, variandone di conseguenza l'intensità.
"Differenza minima evidente."
Sia dal punto di vista pratico che teorico, determinare la differenza minima di frequenza e intensità del suono che può essere rilevata dall'orecchio è un problema molto importante. Come dovrebbero essere modificate la frequenza e l'intensità dei segnali sonori in modo che l'ascoltatore se ne accorga? Si scopre che la differenza minima percepibile è determinata da un cambiamento relativo nelle caratteristiche del suono piuttosto che da un cambiamento assoluto. Questo vale sia per la frequenza che per l'intensità del suono.
La variazione relativa di frequenza necessaria per la discriminazione è diversa sia per suoni di frequenze diverse che per suoni della stessa frequenza, ma di diversa intensità. Si può dire però che sia pari a circa lo 0,5% su un ampio intervallo di frequenze da 1000 a 12.000 Hz. Questa percentuale (la cosiddetta soglia di discriminazione) è leggermente più alta alle frequenze più alte e significativamente più alta alle frequenze più basse. Di conseguenza, l'orecchio è meno sensibile ai cambiamenti di frequenza ai margini della gamma di frequenze che ai valori medi, e questo viene spesso notato da tutti coloro che suonano il pianoforte; l'intervallo tra due note molto alte o molto gravi appare inferiore a quello delle note della gamma media.
La differenza minima evidente è leggermente diversa quando si tratta di intensità del suono. La discriminazione richiede una variazione abbastanza ampia, circa il 10%, nella pressione delle onde sonore (cioè circa 1 dB), e questo valore è relativamente costante per suoni di quasi tutte le frequenze e intensità. Tuttavia, quando l’intensità dello stimolo è bassa, la differenza minima percepibile aumenta notevolmente, soprattutto per i toni a bassa frequenza.
Sovratoni nell'orecchio.
Una proprietà caratteristica di quasi tutte le sorgenti sonore è che non solo produce semplici oscillazioni periodiche (tono puro), ma esegue anche movimenti oscillatori complessi che producono più toni puri contemporaneamente. Tipicamente, un tono così complesso è costituito da serie armoniche (armoniche), ad es. dalla frequenza più bassa, fondamentale, più gli armonici, le cui frequenze superano la fondamentale per un numero intero di volte (2, 3, 4, ecc.). Pertanto, un oggetto che vibra ad una frequenza fondamentale di 500 Hz può produrre anche armonici di 1000, 1500, 2000 Hz, ecc. L'orecchio umano si comporta in modo simile in risposta a un segnale sonoro. Le caratteristiche anatomiche dell'orecchio offrono molte opportunità per convertire l'energia del tono puro in arrivo, almeno parzialmente, in sovratoni. Ciò significa che anche quando la sorgente produce un tono puro, un ascoltatore attento può sentire non solo il tono principale, ma anche uno o due armonici sottili.
Interazione di due toni.
Quando due toni puri vengono percepiti contemporaneamente dall'orecchio, si possono osservare le seguenti varianti della loro azione congiunta, a seconda della natura dei toni stessi. Possono mascherarsi a vicenda riducendo reciprocamente il volume. Ciò si verifica più spesso quando i toni non differiscono molto in frequenza. I due toni possono connettersi tra loro. Allo stesso tempo, sentiamo suoni che corrispondono alla differenza di frequenze tra loro o alla somma delle loro frequenze. Quando due toni hanno una frequenza molto vicina, sentiamo un singolo tono la cui altezza è approssimativamente uguale a quella frequenza. Questo tono, tuttavia, diventa più forte e più basso poiché i due segnali acustici leggermente discordanti interagiscono continuamente, potenziandosi o annullandosi a vicenda.
Timbro.
Oggettivamente parlando, gli stessi toni complessi possono variare in grado di complessità, ad es. per composizione e intensità degli armonici. Una caratteristica soggettiva della percezione, che generalmente riflette la peculiarità del suono, è il timbro. Pertanto, le sensazioni causate da un tono complesso sono caratterizzate non solo da una certa altezza e volume, ma anche dal timbro. Alcuni suoni sembrano ricchi e pieni, altri no. Grazie soprattutto alle differenze timbriche, tra tanti suoni riconosciamo le voci di vari strumenti. Una nota LA suonata su un pianoforte può essere facilmente distinta dalla stessa nota suonata su un corno. Se però si riesce a filtrare e smorzare gli armonici di ciascuno strumento, queste note non potranno essere distinte.
Localizzazione dei suoni.
L'orecchio umano non solo distingue i suoni e le loro fonti; entrambe le orecchie, lavorando insieme, sono in grado di determinare con precisione la direzione da cui proviene il suono. Poiché le orecchie si trovano ai lati opposti della testa, le onde sonore della sorgente sonora non le raggiungono esattamente nello stesso momento e agiscono con intensità leggermente diverse. A causa della differenza minima di tempo e forza, il cervello determina in modo abbastanza accurato la direzione della sorgente sonora. Se la sorgente sonora è rigorosamente di fronte, il cervello la localizza lungo l'asse orizzontale con una precisione di diversi gradi. Se la sorgente viene spostata da un lato, la precisione della localizzazione risulta leggermente inferiore. Distinguere il suono proveniente da dietro da quello anteriore, così come localizzarlo lungo l'asse verticale, risulta essere un po' più difficile.
Rumore
spesso descritto come un suono atonale, cioè composto da vari. frequenze non correlate e quindi non ripete costantemente tale alternanza di onde di alta e bassa pressione per produrre una frequenza specifica. Tuttavia, in realtà, quasi ogni "rumore" ha una propria altezza, che è facile da verificare ascoltando e confrontando i rumori ordinari. D'altra parte, qualsiasi "tono" ha elementi di ruvidità. Pertanto, le differenze tra rumore e tono sono difficili da definire in questi termini. Oggi c’è la tendenza a definire il rumore dal punto di vista psicologico piuttosto che acustico, definendolo semplicemente un suono indesiderato. Ridurre il rumore in questo senso è diventato un problema moderno urgente. Anche se il rumore forte e costante provoca indubbiamente la sordità e il lavoro nel rumore provoca uno stress temporaneo, il suo effetto è probabilmente meno duraturo e meno grave di quanto talvolta gli viene attribuito.
Udito anormale e udito degli animali.
Lo stimolo naturale per l'orecchio umano è il suono che viaggia nell'aria, ma l'orecchio può essere stimolato in altri modi. Tutti sanno, ad esempio, che sott'acqua si sente il rumore. Inoltre, se si applica una fonte di vibrazione alla parte ossea della testa, si avverte una sensazione di suono dovuta alla conduzione ossea. Questo fenomeno è molto utile in alcune forme di sordità: un piccolo trasmettitore applicato direttamente sul processo mastoideo (la parte del cranio situata subito dietro l'orecchio) permette al paziente di sentire i suoni amplificati dal trasmettitore attraverso le ossa del cranio attraverso l'osso. conduzione.
Naturalmente, non solo le persone hanno l'udito. La capacità di sentire nasce nelle prime fasi dell'evoluzione ed esiste già negli insetti. Diverse specie di animali percepiscono suoni di frequenze diverse. Alcuni sentono una gamma di suoni più piccola rispetto agli esseri umani, altri ne sentono una più ampia. Un buon esempio è un cane, il cui orecchio è sensibile alle frequenze oltre la portata dell'udito umano. Uno degli usi è quello di produrre fischi, il cui suono non è udibile dagli esseri umani ma abbastanza forte da essere sentito dai cani.
È noto che una persona riceve il 90% delle informazioni sul mondo che lo circonda attraverso la visione. Sembrerebbe che non sia rimasto molto per l'udito, ma in realtà l'organo uditivo umano non è solo un analizzatore altamente specializzato delle vibrazioni sonore, ma anche un mezzo di comunicazione molto potente. Medici e fisici si preoccupano da tempo della questione: è possibile determinare con precisione la portata dell'udito umano in diverse condizioni, se l'udito differisce tra uomini e donne, ci sono detentori di record "particolarmente eccezionali" che sentono suoni inaccessibili o possono produrre loro? Proviamo a rispondere a queste e ad altre domande correlate in modo più dettagliato.
Ma prima di capire quanti hertz sente l'orecchio umano, devi comprendere un concetto così fondamentale come il suono e, in generale, capire cosa si misura esattamente in hertz.
Le vibrazioni sonore sono un modo unico di trasmettere energia senza trasferire materia; sono vibrazioni elastiche in qualsiasi mezzo. Quando si tratta della vita umana ordinaria, un tale mezzo è l’aria. Contengono molecole di gas in grado di trasmettere energia acustica. Questa energia rappresenta l'alternanza di fasce di compressione e di tensione della densità del mezzo acustico. Nel vuoto assoluto le vibrazioni sonore non possono essere trasmesse.
Qualsiasi suono è un'onda fisica e contiene tutte le caratteristiche d'onda necessarie. Questa è frequenza, ampiezza, tempo di decadimento, se parliamo di un'oscillazione libera smorzata. Diamo un'occhiata a questo utilizzando semplici esempi. Immaginiamo, ad esempio, il suono della corda Sol aperta di un violino quando viene suonata con un archetto. Possiamo definire le seguenti caratteristiche:
- suono debole o forte. Non è altro che l'ampiezza, o la forza, del suono. Un suono più forte corrisponde ad un'ampiezza di vibrazione maggiore, mentre un suono debole corrisponde a un'ampiezza di vibrazione più piccola. Un suono con maggiore forza può essere udito a maggiore distanza dal punto di origine;
- durata del suono. Questo è chiaro a tutti, e tutti sanno distinguere il suono di un rullo di tamburi dal suono prolungato di una melodia di organo corale;
- altezza o frequenza della vibrazione del suono. È questa caratteristica fondamentale che ci aiuta a distinguere i suoni “cigolanti” dal registro dei bassi. Se non esistesse la frequenza del suono, la musica sarebbe possibile solo sotto forma di ritmo. La frequenza si misura in hertz e 1 hertz equivale a una vibrazione al secondo;
- timbro del suono. Dipende dalla mescolanza di ulteriori vibrazioni acustiche - formanti, ma è molto facile spiegarlo in parole semplici: anche con gli occhi chiusi, capiamo che è il violino che suona, e non il trombone, anche se hanno esattamente le stesse caratteristiche sopra elencate.
Il timbro del suono può essere paragonato a numerose sfumature di sapore. In totale abbiamo gusti amaro, dolce, acido e salato, ma queste quattro caratteristiche non esauriscono tutte le possibili sensazioni gustative. La stessa cosa accade con il timbro.
Soffermiamoci più in dettaglio sull'altezza del suono, poiché è da questa caratteristica che dipende in massima misura l'acuità dell'udito e la gamma delle vibrazioni acustiche percepite. Qual è la gamma di frequenze audio?
Campo uditivo in condizioni ideali

Le frequenze percepite dall'orecchio umano in condizioni di laboratorio o ideali rientrano in una banda relativamente ampia da 16 Hertz a 20.000 Hertz (20 kHz). Tutto ciò che è inferiore e superiore non può essere udito dall'orecchio umano. Stiamo parlando di infrasuoni e ultrasuoni. Cos'è?
Infrasuoni
Non può essere ascoltato, ma il corpo può sentirlo, come il lavoro di un grande altoparlante per bassi: un subwoofer. Queste sono vibrazioni infrasoniche. Tutti sanno perfettamente che se allenti costantemente la corda del basso di una chitarra, nonostante le continue vibrazioni, il suono scompare. Ma queste vibrazioni possono ancora essere percepite con la punta delle dita quando tocchi la corda.
Molti organi umani interni operano nella gamma degli infrasuoni: si verificano contrazione dell'intestino, dilatazione e costrizione dei vasi sanguigni e molte reazioni biochimiche. Gli infrasuoni molto forti possono causare gravi condizioni dolorose, persino ondate di panico, questa è la base dell'azione delle armi infrasoniche.
Ultrasuoni

Sul lato opposto dello spettro ci sono suoni molto acuti. Se il suono ha una frequenza superiore a 20 kilohertz, smette di "cigolare" e in linea di principio diventa impercettibile all'orecchio umano. Diventa ultrasuoni. Gli ultrasuoni sono ampiamente utilizzati nell'economia nazionale, la diagnostica ecografica si basa su di essi. Con l'aiuto degli ultrasuoni, le navi navigano nel mare, evitando gli iceberg e le acque poco profonde. Utilizzando gli ultrasuoni, gli specialisti trovano vuoti nelle strutture metalliche solide, come le rotaie. Tutti hanno visto come i lavoratori facevano rotolare uno speciale carrello per il rilevamento dei difetti lungo i binari, generando e ricevendo vibrazioni acustiche ad alta frequenza. Gli ultrasuoni vengono utilizzati dai pipistrelli per orientarsi con precisione nell'oscurità senza sbattere contro le pareti di caverne, balene e delfini.
È noto che la capacità di distinguere i suoni acuti diminuisce con l'età e i bambini li sentono meglio. La ricerca moderna mostra che già all’età di 9-10 anni, la portata uditiva dei bambini inizia a diminuire gradualmente e negli anziani l’udibilità delle alte frequenze è molto peggiore.
Per sentire come percepiscono la musica gli anziani, è sufficiente abbassare una o due file di alte frequenze sull'equalizzatore multibanda del lettore del cellulare. Il conseguente fastidioso "mormorio, come da un barile" sarà un eccellente esempio di come sentirai tu stesso dopo i 70 anni.
Una dieta scorretta, il consumo di alcol, il fumo e la deposizione di placche di colesterolo sulle pareti dei vasi sanguigni svolgono un ruolo importante nella perdita dell'udito. Le statistiche dei medici otorinolaringoiatri affermano che le persone con il primo gruppo sanguigno sviluppano la perdita dell'udito più spesso e più velocemente di altre. La perdita dell'udito è causata dall'eccesso di peso e da patologie endocrine.
Campo uditivo in condizioni normali

Se eliminiamo le "aree marginali" dello spettro sonoro, allora non c'è molto a disposizione per una vita umana confortevole: questa è la gamma da 200 Hz a 4000 Hz, che corrisponde quasi completamente alla gamma della voce umana, dal profondo dal basso profondo al soprano con alta coloratura. Tuttavia, anche in condizioni confortevoli, l’udito di una persona si deteriora costantemente. Di solito, la massima sensibilità e suscettibilità negli adulti di età inferiore ai 40 anni è al livello di 3 kilohertz e all'età di 60 anni o più diminuisce a 1 kilohertz.
Gamma uditiva negli uomini e nelle donne
Attualmente, la segregazione di genere non è incoraggiata, ma uomini e donne percepiscono il suono in modo diverso: le donne sono in grado di sentire meglio nella gamma alta, e l’involuzione del suono nella regione delle alte frequenze, legata all’età, è più lenta per loro, mentre gli uomini percepiscono le alte frequenze. suona un po' peggio. Sembrerebbe logico supporre che gli uomini sentano meglio nel registro basso, ma non è così. La percezione dei suoni bassi è quasi la stessa sia negli uomini che nelle donne.
Ma ci sono donne uniche nel “generare” suoni. Pertanto, l'estensione vocale della cantante peruviana Ima Sumac (quasi cinque ottave) si estendeva dal suono “B” dell'ottava grande (123,5 Hz) a “A” della quarta ottava (3520 Hz). Di seguito è riportato un esempio della sua voce unica.
Allo stesso tempo, c'è una differenza piuttosto ampia nel funzionamento dell'apparato vocale tra uomini e donne. Secondo i dati medi, le donne producono suoni da 120 a 400 Hz e gli uomini da 80 a 150 Hz.
Varie scale per indicare la portata dell'udito
All'inizio abbiamo parlato di come l'altezza non sia l'unica caratteristica del suono. Pertanto, esistono scale diverse a seconda degli intervalli. Il suono udito dall'orecchio umano può essere, ad esempio, debole e forte. La scala di intensità sonora più semplice e clinicamente accettabile è quella che misura la pressione sonora percepita dal timpano.
Questa scala si basa sulla vibrazione energetica più bassa del suono, che può essere trasformata in un impulso nervoso e provocare una sensazione sonora. Questa è la soglia della percezione uditiva. Più bassa è la soglia di percezione, maggiore è la sensibilità e viceversa. Gli esperti distinguono tra l’intensità del suono, che è un parametro fisico, e il volume, che è un valore soggettivo. È noto che un suono della stessa intensità verrà percepito da una persona sana e da una persona con perdita dell'udito come due suoni diversi, più forte e più basso.
Tutti sanno come nello studio otorinolaringoiatrico il paziente sta in un angolo, si volta e il medico dall'angolo successivo controlla la percezione del paziente del discorso sussurrato, pronunciando i singoli numeri. Questo è l'esempio più semplice di diagnosi primaria di perdita dell'udito.
È noto che il respiro appena percettibile di un'altra persona corrisponde a 10 decibel (dB) di intensità di pressione sonora, una normale conversazione in ambiente domestico corrisponde a 50 dB, il lamento di una sirena antincendio corrisponde a 100 dB e un aereo a reazione il decollo vicino alla soglia del dolore corrisponde a 120 decibel.
Può sorprendere che tutta l'enorme intensità delle vibrazioni sonore rientri in una scala così piccola, ma questa impressione è ingannevole. Questa è una scala logaritmica e ogni passaggio successivo è 10 volte più intenso del precedente. Con lo stesso principio è stata costruita una scala per valutare l’intensità dei terremoti, con soli 12 punti.