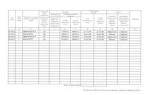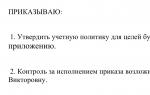Cos'è un elettrocardiogramma. Come leggere un ECG? Come decifrare tu stesso un elettrocardiogramma? Cosa mostra un ECG?
Grazie
Il sito fornisce informazioni di riferimento solo a scopo informativo. La diagnosi e il trattamento delle malattie devono essere effettuati sotto la supervisione di uno specialista. Tutti i farmaci hanno controindicazioni. È necessaria la consultazione con uno specialista!
Elettrocardiogrammaè un metodo obiettivo ampiamente utilizzato diagnostica varie patologie del cuore umano, che oggi viene utilizzato quasi ovunque. Un elettrocardiogramma (ECG) viene eseguito in una clinica, in un'ambulanza o in un reparto ospedaliero. L'ECG è una registrazione molto importante che riflette le condizioni del cuore. Ecco perché il riflesso di vari tipi di patologie cardiache sull'ECG è descritto da una scienza separata: l'elettrocardiografia. L'elettrocardiografia affronta anche i problemi della corretta registrazione dell'ECG, problemi di decodifica, interpretazione di punti controversi e poco chiari, ecc.Definizione ed essenza del metodo
Un elettrocardiogramma è una registrazione del cuore, che viene presentata come una linea curva su carta. La linea del cardiogramma in sé non è caotica; ha determinati intervalli, denti e segmenti che corrispondono a determinati stadi del cuore.Per comprendere l'essenza di un elettrocardiogramma, è necessario sapere cosa viene registrato esattamente da un dispositivo chiamato elettrocardiografo. L'ECG registra l'attività elettrica del cuore, che cambia ciclicamente in base all'inizio della diastole e della sistole. L'attività elettrica del cuore umano può sembrare una finzione, ma questo fenomeno biologico unico esiste nella realtà. In realtà il cuore contiene le cosiddette cellule del sistema di conduzione, che generano impulsi elettrici che vengono trasmessi ai muscoli dell'organo. Sono questi impulsi elettrici che fanno contrarre e rilassare il miocardio con un certo ritmo e frequenza.
L'impulso elettrico si propaga attraverso le cellule del sistema di conduzione del cuore in modo rigorosamente sequenziale, provocando la contrazione e il rilassamento delle sezioni corrispondenti: ventricoli e atri. L'elettrocardiogramma riflette esattamente la differenza di potenziale elettrico totale nel cuore.
decrittazione?
 Un elettrocardiogramma può essere eseguito in qualsiasi clinica o ospedale multidisciplinare. Puoi rivolgerti ad un centro medico privato dove sia presente uno specialista cardiologo o terapista. Dopo aver registrato il cardiogramma, il medico esamina il nastro con le curve. È lui che analizza la registrazione, la decifra e scrive un rapporto finale, che riflette tutte le patologie visibili e le deviazioni funzionali dalla norma.
Un elettrocardiogramma può essere eseguito in qualsiasi clinica o ospedale multidisciplinare. Puoi rivolgerti ad un centro medico privato dove sia presente uno specialista cardiologo o terapista. Dopo aver registrato il cardiogramma, il medico esamina il nastro con le curve. È lui che analizza la registrazione, la decifra e scrive un rapporto finale, che riflette tutte le patologie visibili e le deviazioni funzionali dalla norma. Un elettrocardiogramma viene registrato utilizzando un dispositivo speciale: un elettrocardiografo, che può essere multicanale o monocanale. La velocità di registrazione dell'ECG dipende dalla modifica e dalla modernità del dispositivo. I dispositivi moderni possono essere collegati a un computer che, con un programma speciale, analizzerà la registrazione e rilascerà una conclusione finale immediatamente dopo il completamento della procedura.
Qualsiasi cardiografo ha elettrodi speciali applicati in un ordine rigorosamente definito. Ci sono quattro mollette rosse, gialle, verdi e nere che vengono posizionate su entrambe le braccia e su entrambe le gambe. Se vai in cerchio, le mollette vengono applicate secondo la regola “rosso-giallo-verde-nero”, dalla mano destra. È facile ricordare questa sequenza grazie alla frase dello studente: "Ogni donna è un tratto più malvagio". Oltre a questi elettrodi esistono anche elettrodi toracici che vengono installati negli spazi intercostali.
Di conseguenza, l'elettrocardiogramma è composto da dodici forme d'onda, sei delle quali vengono registrate dagli elettrodi toracici e sono chiamate derivazioni toraciche. Le restanti sei derivazioni vengono registrate da elettrodi attaccati alle braccia e alle gambe, tre di esse chiamate standard e altre tre chiamate potenziate. Le derivazioni del torace sono designate V1, V2, V3, V4, V5, V6, quelle standard sono semplicemente numeri romani - I, II, III e le derivazioni delle gambe rinforzate - le lettere aVL, aVR, aVF. Per creare il quadro più completo dell'attività del cuore sono necessarie diverse derivazioni del cardiogramma, poiché alcune patologie sono visibili sulle derivazioni toraciche, altre su quelle standard e altre ancora su quelle potenziate.
La persona si sdraia sul lettino, il medico attacca gli elettrodi e accende l'apparecchio. Mentre viene scritto l'ECG, la persona deve essere assolutamente calma. Non dobbiamo permettere la comparsa di sostanze irritanti che possano distorcere la vera immagine del lavoro del cuore.
Come eseguire correttamente un elettrocardiogramma seguito da
trascrizione - video
Il principio di decodificazione di un ECG
Poiché l'elettrocardiogramma riflette i processi di contrazione e rilassamento del miocardio, è possibile tracciare come si verificano questi processi e identificare i processi patologici esistenti. Gli elementi dell'elettrocardiogramma sono strettamente correlati e riflettono la durata delle fasi del ciclo cardiaco: sistole e diastole, cioè contrazione e successivo rilassamento. La decodifica dell'elettrocardiogramma si basa sullo studio dei denti, sulla loro posizione reciproca, sulla durata e su altri parametri. I seguenti elementi dell'elettrocardiogramma vengono studiati per l'analisi:1. Denti.
2. Intervalli.
3. Segmenti.
Tutte le convessità e concavità affilate e lisce sulla linea ECG sono chiamate denti. Ogni dente è designato da una lettera dell'alfabeto latino. L'onda P riflette la contrazione degli atri, il complesso QRS la contrazione dei ventricoli del cuore, l'onda T il rilassamento dei ventricoli. A volte dopo l'onda T sull'elettrocardiogramma c'è un'altra onda U, ma non ha alcun ruolo clinico e diagnostico.
Un segmento ECG è considerato un segmento racchiuso tra denti adiacenti. Per diagnosticare la patologia cardiaca, di grande importanza sono i segmenti P – Q e S – T. L'intervallo sull'elettrocardiogramma è un complesso che comprende un dente e un intervallo. Gli intervalli P–Q e Q–T sono di grande importanza per la diagnosi.
Spesso nel referto del medico si vedono piccole lettere latine, che indicano anche denti, intervalli e segmenti. Le lettere minuscole vengono utilizzate se la punta è lunga meno di 5 mm. Inoltre, nel complesso QRS possono comparire diverse onde R, solitamente indicate con R’, R”, ecc. A volte l'onda R semplicemente manca. Quindi l'intero complesso è designato solo da due lettere: QS. Tutto ciò ha un importante significato diagnostico.
Piano di interpretazione dell'ECG - schema generale per la lettura dei risultati
 Quando si decifra un elettrocardiogramma, è necessario stabilire i seguenti parametri che riflettono il lavoro del cuore:
Quando si decifra un elettrocardiogramma, è necessario stabilire i seguenti parametri che riflettono il lavoro del cuore: - posizione dell'asse elettrico del cuore;
- determinare la correttezza del ritmo cardiaco e la conduttività dell'impulso elettrico (vengono rilevati blocchi, aritmie);
- determinare la regolarità delle contrazioni del muscolo cardiaco;
- determinazione della frequenza cardiaca;
- identificare la fonte dell'impulso elettrico (se il ritmo sinusale è determinato o meno);
- analisi della durata, profondità e ampiezza dell'onda P atriale e dell'intervallo P – Q;
- analisi della durata, profondità, ampiezza del complesso d'onda ventricolare QRST;
- analisi dei parametri del segmento RS – T e dell'onda T;
- analisi dei parametri dell'intervallo Q – T.
Nella conclusione sull'elettrocardiogramma, il medico deve riflettere i seguenti parametri:
- ritmo sinusale o meno;
- regolarità del ritmo;
- frequenza cardiaca (FC);
- posizione dell'asse elettrico del cuore.
Esempio di decifrazione di un elettrocardiogramma
All'inizio del nastro dell'elettrocardiogramma dovrebbe esserci un segnale di calibrazione, che assomiglia ad una grande lettera "P" alta 10 mm. Se questo segnale di calibrazione non è presente, l'elettrocardiogramma non è informativo. Se l'altezza del segnale di calibrazione è inferiore a 5 mm nelle derivazioni standard e avanzate e inferiore a 8 mm nelle derivazioni toraciche, è presente una bassa tensione dell'elettrocardiogramma, che è un segno di una serie di patologie cardiache. Per la successiva decodifica e calcolo di alcuni parametri, è necessario sapere quale periodo di tempo si inserisce in una cella di carta millimetrata. Una cella lunga 1 mm equivale a 0,04 secondi con una velocità del nastro di 25 mm/s e con una velocità di 50 mm/s a 0,02 secondi.Controllo della regolarità delle contrazioni cardiache
Viene valutato dagli intervalli R - R. Se i denti si trovano alla stessa distanza l'uno dall'altro durante l'intera registrazione, il ritmo è regolare. Altrimenti si dice corretto. Stimare la distanza tra i denti R - R è molto semplice: l'elettrocardiogramma viene registrato su carta millimetrata, il che rende facile misurare eventuali spazi in millimetri.Calcolo della frequenza cardiaca (FC).
 Viene eseguito utilizzando un semplice metodo aritmetico: contare il numero di grandi quadrati su carta millimetrata posizionati tra due onde R. Quindi la frequenza cardiaca viene calcolata utilizzando la formula, che è determinata dalla velocità del nastro nel cardiografo:
Viene eseguito utilizzando un semplice metodo aritmetico: contare il numero di grandi quadrati su carta millimetrata posizionati tra due onde R. Quindi la frequenza cardiaca viene calcolata utilizzando la formula, che è determinata dalla velocità del nastro nel cardiografo: 1. La velocità del nastro è 50 mm/s, quindi la frequenza cardiaca è 600 divisa per il numero di quadrati.
2. La velocità del nastro è 25 mm/s, quindi la frequenza cardiaca è 300 divisa per il numero di quadrati.
Ad esempio, se tra due denti R si inseriscono 4,8 quadrati grandi, la frequenza cardiaca, con una velocità della cinghia di 50 mm/s, sarà pari a 600/4,8 = 125 battiti al minuto.
Se la frequenza cardiaca è anomala, viene determinata la frequenza cardiaca massima e minima, prendendo come base anche le distanze massime e minime tra le onde R.
Identificare la fonte del ritmo
Il medico studia il ritmo delle contrazioni cardiache e scopre quale nodo delle cellule nervose provoca i processi ciclici di contrazione e rilassamento del muscolo cardiaco. Questo è molto importante per identificare i blocchi.Decodifica ECG - ritmi
Normalmente, il pacemaker è il nodo senoatriale. E un ritmo così normale si chiama sinusale: tutte le altre opzioni sono patologiche. In diverse patologie qualsiasi altro nodo delle cellule nervose del sistema di conduzione cardiaca può fungere da pacemaker. In questo caso, gli impulsi elettrici ciclici si confondono e il ritmo cardiaco viene interrotto: si verifica un'aritmia.Nel ritmo sinusale sull'elettrocardiogramma nella derivazione II c'è un'onda P prima di ciascun complesso QRS, ed è sempre positiva. In una derivazione, tutte le onde P dovrebbero avere la stessa forma, lunghezza e larghezza.
Con ritmo atriale l'onda P nelle derivazioni II e III è negativa, ma è presente prima di ciascun complesso QRS.
Ritmi atrioventricolari sono caratterizzati dall'assenza di onde P sui cardiogrammi, o dalla comparsa di quest'onda dopo il complesso QRS e non prima, come è normale. Con questo tipo di ritmo, la frequenza cardiaca è bassa, compresa tra 40 e 60 battiti al minuto.
Ritmo ventricolare caratterizzato da un aumento dell'ampiezza del complesso QRS, che diventa ampio e abbastanza spaventoso. Le onde P e il complesso QRS sono completamente indipendenti tra loro. Cioè, non esiste una sequenza normale rigorosamente corretta: l'onda P, seguita dal complesso QRS. Il ritmo ventricolare è caratterizzato da una diminuzione della frequenza cardiaca - inferiore a 40 battiti al minuto.
Rilevazione della patologia della conduzione dell'impulso elettrico attraverso le strutture del cuore
Per fare ciò, misurare la durata dell'onda P, l'intervallo P–Q e il complesso QRS. La durata di questi parametri viene calcolata dal nastro millimetrico su cui è registrato il cardiogramma. Innanzitutto contare quanti millimetri occupa ciascun dente o intervallo, dopodiché il valore risultante viene moltiplicato per 0,02 con una velocità di registrazione di 50 mm/s o per 0,04 con una velocità di registrazione di 25 mm/s.La durata normale dell'onda P è fino a 0,1 secondi, l'intervallo P – Q è 0,12-0,2 secondi, il complesso QRS è 0,06-0,1 secondi.
Asse elettrico del cuore
 Indicato come angolo alfa. Può avere una posizione normale, orizzontale o verticale. Inoltre, in una persona magra l'asse del cuore è più verticale rispetto ai valori medi, mentre in una persona grassa è più orizzontale. La posizione normale dell'asse elettrico del cuore è 30–69°, verticale – 70–90°, orizzontale – 0–29°. L'angolo alfa, compreso tra 91 e ±180°, riflette una brusca deviazione dell'asse elettrico del cuore verso destra. L'angolo alfa, compreso tra 0 e –90°, riflette una brusca deviazione dell'asse elettrico del cuore verso sinistra.
Indicato come angolo alfa. Può avere una posizione normale, orizzontale o verticale. Inoltre, in una persona magra l'asse del cuore è più verticale rispetto ai valori medi, mentre in una persona grassa è più orizzontale. La posizione normale dell'asse elettrico del cuore è 30–69°, verticale – 70–90°, orizzontale – 0–29°. L'angolo alfa, compreso tra 91 e ±180°, riflette una brusca deviazione dell'asse elettrico del cuore verso destra. L'angolo alfa, compreso tra 0 e –90°, riflette una brusca deviazione dell'asse elettrico del cuore verso sinistra. L'asse elettrico del cuore può deviare in varie condizioni patologiche. Ad esempio, l'ipertensione porta ad una deviazione a destra; un disturbo della conduzione (blocco) può spostarla a destra o a sinistra.
Onda P atriale
L'onda P atriale dovrebbe essere:- positivo in I, II, aVF e derivazioni toraciche (2, 3,4, 5, 6);
- negativo nell'aVR;
- bifasico (parte del dente si trova nella regione positiva e parte in quella negativa) in III, aVL, V1.
Le forme patologiche dell'onda P possono indicare le seguenti patologie:
1.
Denti alti e aguzzi nelle derivazioni II, III, aVF compaiono con ipertrofia dell'atrio destro (“cor polmonare”);
2.
Un'onda P con due picchi e un'ampia larghezza nelle derivazioni I, aVL, V5 e V6 indica ipertrofia dell'atrio sinistro (ad esempio, malattia della valvola mitrale).
Intervallo P-Q
L'intervallo P–Q ha una durata normale compresa tra 0,12 e 0,2 secondi. Un aumento della durata dell’intervallo P–Q è un riflesso del blocco atrioventricolare. Sull'elettrocardiogramma si possono distinguere tre gradi di blocco atrioventricolare (AV):- I laurea: semplice allungamento dell'intervallo P – Q preservando tutti gli altri complessi e onde.
- II grado: prolungamento dell'intervallo P–Q con perdita parziale di alcuni complessi QRS.
- III grado: mancanza di connessione tra l'onda P e i complessi QRS. In questo caso, gli atri funzionano secondo il proprio ritmo e i ventricoli secondo il proprio ritmo.
Complesso QRST ventricolare
 Il complesso QRST ventricolare è costituito dal complesso QRS stesso e dal segmento S – T. La durata normale del complesso QRST non supera 0,1 secondi e il suo aumento viene rilevato con blocchi dei rami del fascio di Hiss.
Il complesso QRST ventricolare è costituito dal complesso QRS stesso e dal segmento S – T. La durata normale del complesso QRST non supera 0,1 secondi e il suo aumento viene rilevato con blocchi dei rami del fascio di Hiss. Complesso QRSè costituito da tre onde, rispettivamente Q, R e S. L'onda Q è visibile sul cardiogramma in tutte le derivazioni tranne 1, 2 e 3 derivazioni toraciche. Un'onda Q normale ha un'ampiezza fino al 25% di quella di un'onda R. La durata dell'onda Q è di 0,03 secondi. L'onda R viene registrata assolutamente in tutte le derivazioni. Anche l'onda S è visibile in tutte le derivazioni, ma la sua ampiezza diminuisce dalla 1a toracica alla 4a, e nella 5a e 6a può essere completamente assente. L'ampiezza massima di questo dente è di 20 mm.
Il segmento S-T è molto importante dal punto di vista diagnostico. È da questo dente che si può rilevare l'ischemia miocardica, cioè la mancanza di ossigeno nel muscolo cardiaco. Solitamente questo segmento decorre lungo l'isolinea, nella 1a, 2a e 3a derivazione toracica; può sollevarsi al massimo di 2 mm. E nelle derivazioni 4a, 5a e 6a del torace, il segmento S-T può spostarsi al di sotto dell'isolinea di un massimo di mezzo millimetro. È la deviazione del segmento dall'isolina che riflette la presenza di ischemia miocardica.
Onda T
L'onda T è un riflesso del processo di eventuale rilassamento nel muscolo cardiaco dei ventricoli del cuore. Tipicamente, quando l’ampiezza dell’onda R è grande, anche l’onda T sarà positiva. Un'onda T negativa viene normalmente registrata solo nella derivazione aVR.Intervallo Q-T
L'intervallo Q-T riflette il processo di eventuale contrazione nel miocardio dei ventricoli del cuore.Interpretazione dell'ECG: indicatori normali
La trascrizione dell'elettrocardiogramma viene solitamente registrata dal medico in conclusione. Un tipico esempio di un normale cardiogramma cardiaco si presenta così:1. PQ – 0,12 secondi.
2. QRS – 0,06 s.
3. QT – 0,31 s.
4. RR – 0,62 – 0,66 – 0,6.
5. La frequenza cardiaca è di 70 - 75 battiti al minuto.
6. ritmo sinusale.
7. L'asse elettrico del cuore si trova normalmente.
Normalmente il ritmo dovrebbe essere solo sinusale, la frequenza cardiaca di un adulto è di 60-90 battiti al minuto. L'onda P normalmente non supera 0,1 s, l'intervallo P – Q è 0,12-0,2 secondi, il complesso QRS è 0,06-0,1 secondi, Q – T fino a 0,4 s.
Se il cardiogramma è patologico, indica sindromi specifiche e deviazioni dalla norma (ad esempio blocco parziale del ramo sinistro, ischemia miocardica, ecc.). Il medico può anche riflettere violazioni e cambiamenti specifici nei parametri normali di onde, intervalli e segmenti (ad esempio, accorciamento dell'onda P o dell'intervallo Q-T, ecc.).
Interpretazione dell'ECG nei bambini e nelle donne in gravidanza
In linea di principio, i bambini e le donne incinte hanno valori normali dell'elettrocardiogramma cardiaco, gli stessi degli adulti sani. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche fisiologiche. Ad esempio, la frequenza cardiaca dei bambini è superiore a quella di un adulto. La frequenza cardiaca normale di un bambino fino a 3 anni è di 100-110 battiti al minuto, di 3-5 anni è di 90-100 battiti al minuto. Poi gradualmente la frequenza cardiaca diminuisce e nell'adolescenza viene confrontata con quella di un adulto: 60-90 battiti al minuto.Nelle donne in gravidanza, nella tarda gestazione, può verificarsi una leggera deviazione dell'asse elettrico del cuore a causa della compressione da parte dell'utero in crescita. Inoltre, spesso si sviluppa tachicardia sinusale, cioè un aumento della frequenza cardiaca a 110-120 battiti al minuto, che è una condizione funzionale e scompare da sola. Un aumento della frequenza cardiaca è associato ad un maggiore volume di sangue circolante e ad un aumento del carico di lavoro. A causa dell'aumento del carico sul cuore, le donne incinte possono sperimentare un sovraccarico in varie parti dell'organo. Questi fenomeni non sono una patologia: sono associati alla gravidanza e scompaiono da soli dopo il parto.
Decodificare l'elettrocardiogramma durante un infarto
 L'infarto miocardico è un'improvvisa cessazione dell'apporto di ossigeno alle cellule del muscolo cardiaco, con conseguente necrosi di un'area tissutale che si trova in uno stato di ipossia. Il motivo dell'interruzione dell'apporto di ossigeno può essere diverso: molto spesso si tratta di un blocco di un vaso sanguigno o della sua rottura. Un attacco cardiaco coinvolge solo una parte del tessuto muscolare del cuore e l’entità del danno dipende dalle dimensioni del vaso sanguigno bloccato o rotto. Su un elettrocardiogramma, l'infarto del miocardio presenta alcuni segni con cui può essere diagnosticato.
L'infarto miocardico è un'improvvisa cessazione dell'apporto di ossigeno alle cellule del muscolo cardiaco, con conseguente necrosi di un'area tissutale che si trova in uno stato di ipossia. Il motivo dell'interruzione dell'apporto di ossigeno può essere diverso: molto spesso si tratta di un blocco di un vaso sanguigno o della sua rottura. Un attacco cardiaco coinvolge solo una parte del tessuto muscolare del cuore e l’entità del danno dipende dalle dimensioni del vaso sanguigno bloccato o rotto. Su un elettrocardiogramma, l'infarto del miocardio presenta alcuni segni con cui può essere diagnosticato. Nel processo di sviluppo dell'infarto miocardico si distinguono quattro fasi, che hanno diverse manifestazioni sull'ECG:
- acuto;
- acuto;
- subacuto;
- cicatriziale.
Talvolta è possibile individuare la fase di ischemia miocardica che precede la fase acuta, caratterizzata da onde T elevate.
Fase acuta Un infarto dura 2-3 settimane. Durante questo periodo, sull'ECG vengono registrate un'onda Q ampia e di elevata ampiezza e un'onda T negativa.
Stadio subacuto dura fino a 3 mesi. L'ECG mostra un'onda T negativa molto grande con un'ampiezza enorme, che si normalizza gradualmente. A volte viene rilevato un aumento del segmento S-T, che in questo periodo dovrebbe essersi stabilizzato. Questo è un sintomo allarmante, poiché potrebbe indicare la formazione di un aneurisma cardiaco.
Stadio della cicatrice l'infarto è definitivo, poiché nel sito danneggiato si forma tessuto connettivo incapace di contrarsi. Questa cicatrice viene registrata sull'ECG come un'onda Q, che rimarrà per tutta la vita. Spesso l'onda T è attenuata, ha un'ampiezza bassa o è completamente negativa.
Interpretazione degli ECG più comuni
 In conclusione, i medici scrivono il risultato dell'interpretazione dell'ECG, che spesso è incomprensibile perché costituito da termini, sindromi e semplici enunciati di processi fisiopatologici. Consideriamo le conclusioni dell'ECG più comuni, che sono incomprensibili per una persona senza un'educazione medica.
In conclusione, i medici scrivono il risultato dell'interpretazione dell'ECG, che spesso è incomprensibile perché costituito da termini, sindromi e semplici enunciati di processi fisiopatologici. Consideriamo le conclusioni dell'ECG più comuni, che sono incomprensibili per una persona senza un'educazione medica. Ritmo ectopico significa non seno - che può essere una patologia o una norma. La norma è il ritmo ectopico quando c'è una malformazione congenita del sistema di conduzione del cuore, ma la persona non presenta alcun disturbo e non soffre di altre patologie cardiache. In altri casi, un ritmo ectopico indica la presenza di blocchi.
Cambiamenti nei processi di ripolarizzazione sull'ECG riflette una violazione del processo di rilassamento del muscolo cardiaco dopo la contrazione.
Ritmo sinusale Questa è la frequenza cardiaca normale di una persona sana.
Tachicardia sinusale o sinusoidale significa che una persona ha un ritmo corretto e regolare, ma una frequenza cardiaca aumentata - più di 90 battiti al minuto. Nei giovani sotto i 30 anni questa è una variante della norma.
Bradicardia sinusale- questa è una frequenza cardiaca bassa - meno di 60 battiti al minuto sullo sfondo di un ritmo normale e regolare.
Cambiamenti ST-T non specifici significano che ci sono piccole deviazioni dalla norma, ma la loro causa potrebbe essere completamente estranea alla patologia cardiaca. È necessario sottoporsi ad un esame completo. Tali cambiamenti ST-T non specifici possono svilupparsi con uno squilibrio di potassio, sodio, cloro, ioni magnesio o vari disturbi endocrini, spesso durante la menopausa nelle donne.
Onda R bifasica in combinazione con altri segni di infarto indica un danno alla parete anteriore del miocardio. Se non vengono rilevati altri segni di infarto, l'onda R bifasica non è un segno di patologia.
Prolungamento del QT può indicare ipossia (mancanza di ossigeno), rachitismo o sovraeccitazione del sistema nervoso del bambino, che è una conseguenza del trauma alla nascita.
Ipertrofia miocardica significa che la parete muscolare del cuore è ispessita e lavora sotto carico enorme. Ciò può portare alla formazione di:
- insufficienza cardiaca;
- aritmie.
Cambiamenti diffusi moderati nel miocardio significa che la nutrizione dei tessuti è compromessa e si è sviluppata la distrofia del muscolo cardiaco. Questa è una condizione risolvibile: è necessario consultare un medico e sottoporsi a un ciclo di trattamento adeguato, inclusa la normalizzazione della dieta.
Deviazione dell'asse elettrico del cuore (EOS) sinistra o destra è possibile con ipertrofia del ventricolo sinistro o destro, rispettivamente. L'EOS può deviare a sinistra nelle persone obese e a destra nelle persone magre, ma in questo caso questa è una variante della norma.
ECG di tipo sinistro– Deviazione EOS a sinistra.
NBPNG– l’abbreviazione di “blocco di branca destra incompleto”. Questa condizione può verificarsi nei neonati ed è una variante normale. In rari casi, il BBD può causare aritmia, ma generalmente non porta allo sviluppo di conseguenze negative. Il blocco del ramo del fascio di sibilo è abbastanza comune nelle persone, ma se non ci sono lamentele sul cuore, allora non è affatto pericoloso.
BPVLNPG– un’abbreviazione che significa “blocco del ramo anteriore della branca sinistra”. Riflette una violazione della conduzione degli impulsi elettrici nel cuore e porta allo sviluppo di aritmie.
Piccola crescita dell'onda R in V1-V3 può essere un segno di infarto del setto interventricolare. Per determinare con precisione se questo è il caso, è necessario eseguire un altro studio ECG.
Sindrome CLC(Sindrome di Klein-Levy-Kritesco) è una caratteristica congenita del sistema di conduzione del cuore. Può causare lo sviluppo di aritmie. Questa sindrome non richiede trattamento, ma è necessario essere visitata regolarmente da un cardiologo.
ECG a bassa tensione spesso registrato con pericardite (una grande quantità di tessuto connettivo nel cuore che ha sostituito il tessuto muscolare). Inoltre, questo segno può essere un riflesso di esaurimento o mixedema.
Cambiamenti metabolici sono il riflesso di una nutrizione insufficiente del muscolo cardiaco. È necessario essere esaminati da un cardiologo e sottoporsi a un ciclo di trattamento.
Rallentamento della conduzione significa che l'impulso nervoso viaggia attraverso i tessuti del cuore più lentamente del normale. Questa condizione in sé non richiede un trattamento speciale: potrebbe essere una caratteristica congenita del sistema di conduzione del cuore. Si raccomanda il monitoraggio regolare da parte di un cardiologo.
Blocco 2 e 3 gradi riflette un grave disturbo della conduzione cardiaca, che si manifesta con aritmia. In questo caso è necessario il trattamento.
Rotazione del cuore in avanti da parte del ventricolo destro può essere un segno indiretto dello sviluppo dell'ipertrofia. In questo caso, è necessario scoprirne la causa e sottoporsi a un ciclo di trattamento o modificare la dieta e lo stile di vita.
Prezzo di un elettrocardiogramma con interpretazione
Il costo di un elettrocardiogramma con interpretazione varia in modo significativo, a seconda della specifica istituzione medica. Pertanto, negli ospedali e nelle cliniche pubbliche il prezzo minimo per la procedura di rilevamento di un ECG e interpretazione da parte di un medico è di 300 rubli. In questo caso riceverai filmati con le curve registrate e la conclusione del medico su di esse, che realizzerà lui stesso o utilizzando un programma per computer.Se desideri ricevere una conclusione approfondita e dettagliata sull'elettrocardiogramma, una spiegazione da parte del medico di tutti i parametri e le modifiche, è meglio contattare una clinica privata che fornisce tali servizi. Qui il medico potrà non solo scrivere una conclusione dopo aver decifrato il cardiogramma, ma anche parlarvi con calma, prendendosi il suo tempo per spiegare tutti i punti di interesse. Tuttavia, il costo di un tale cardiogramma con interpretazione in un centro medico privato varia da 800 rubli a 3.600 rubli. Non dovresti dare per scontato che cattivi specialisti lavorino in una normale clinica o ospedale - è solo che un medico in un'istituzione pubblica, di regola, ha una grande quantità di lavoro, quindi semplicemente non ha tempo di parlare con ogni paziente in grande dettaglio.
Quando si sceglie un istituto medico per eseguire un cardiogramma con interpretazione, prestare prima attenzione alle qualifiche del medico. È meglio che sia uno specialista: un cardiologo o un terapista con una buona esperienza. Se un bambino ha bisogno di un cardiogramma, è meglio contattare specialisti - pediatri, poiché i medici "adulti" non sempre tengono conto delle specificità e delle caratteristiche fisiologiche dei bambini.
Prima dell'uso, è necessario consultare uno specialista.Già nel 19 ° secolo, gli scienziati, studiando le caratteristiche anatomiche e fisiologiche del cuore degli animali e degli esseri umani, giunsero alla conclusione che questo organo è un muscolo in grado di generare e condurre impulsi elettrici. Il cuore umano è costituito da due atri e due ventricoli. La corretta conduzione dei segnali elettrici attraverso di essi garantisce una buona contrattilità del miocardio (muscolo cardiaco) e garantisce il corretto ritmo delle contrazioni.
Inizialmente, l'impulso avviene nelle cellule del nodo senoatriale (atriale), situato al confine dell'atrio destro e della vena cava superiore. Si diffonde poi attraverso gli atri, raggiungendo il nodo atrioventricolare (situato tra l'atrio destro e il ventricolo), qui si verifica un leggero ritardo nell'impulso, poi passa attraverso il fascio di His nello spessore del setto interventricolare e si diffonde lungo il Purkinje fibre nelle pareti di entrambi i ventricoli. È questo percorso di conduzione del segnale elettrico attraverso il sistema di conduzione del cuore che è corretto e garantisce la piena contrazione cardiaca, poiché sotto l'influenza dell'impulso la cellula muscolare si contrae.
Sistema di conduzione del cuore
Poco dopo, gli scienziati sono stati in grado di creare un dispositivo che consente loro di registrare e leggere i processi dell'attività elettrica nel cuore posizionando gli elettrodi sul petto. Un ruolo enorme qui spetta a Willem Uythoven, uno scienziato olandese che progettò il primo apparecchio per l'elettrocardiografia e dimostrò che nelle persone con varie malattie cardiache, gli indicatori dell'elettrofisiologia cardiaca cambiano durante la registrazione di un ECG (1903). Allora, cos’è l’elettrocardiografia?
è un metodo strumentale per lo studio dell'attività elettrofisiologica del cuore, basato sulla registrazione e la rappresentazione grafica della differenza di potenziale che si verifica durante la contrazione del muscolo cardiaco allo scopo di diagnosticare le malattie cardiache.
Un ECG viene eseguito posizionando gli elettrodi sulla parete anteriore del torace nella proiezione del cuore e degli arti, quindi utilizzando il dispositivo ECG stesso, i potenziali elettrici del cuore vengono registrati e visualizzati come curva grafica sul monitor di un computer o su una termocamera. carta (usando un registratore a inchiostro). Gli impulsi elettrici generati dal cuore si propagano in tutto il corpo, quindi per facilitare la lettura sono stati sviluppati dei cavi, circuiti che consentono di registrare differenze di potenziale in diverse parti del cuore. Esistono tre derivazioni standard: 1, 11, 111; tre derivazioni potenziate: aVL, aVR, aVF; e sei derivazioni toraciche: da V1 a V6. Tutte le dodici derivazioni vengono visualizzate sulla pellicola ECG e consentono di vedere il lavoro di una parte particolare del cuore in ciascuna derivazione specifica.
Nei tempi moderni, il metodo elettrocardiografico è molto diffuso grazie alla sua disponibilità, facilità d'uso, basso costo e mancanza di invasività (violazione dell'integrità dei tessuti corporei). Un ECG consente di diagnosticare tempestivamente molte malattie: patologia coronarica acuta (infarto del miocardio), ipertensione, disturbi del ritmo e della conduzione, ecc., E consente anche di valutare l'efficacia del trattamento farmacologico o chirurgico delle malattie cardiache.
Si distinguono i seguenti metodi ECG:
- Monitoraggio ECG Holter (24 ore).– al paziente viene applicato sul torace un piccolo dispositivo portatile, che registra le più piccole deviazioni nell'attività del cuore durante il giorno. L’aspetto positivo di questo metodo è che consente di monitorare il lavoro del cuore durante le normali attività quotidiane del paziente e per un periodo di tempo più lungo rispetto a quando si esegue un semplice ECG. Aiuta nella registrazione di aritmie cardiache e ischemie miocardiche che non sono state rilevate con un singolo ECG.
- ECG sotto sforzo– si ricorre alla medicazione (con l’uso di farmaci farmacologici) o all’attività fisica (test sul tapis roulant, bicicletta ergometrica); così come la stimolazione elettrica del cuore quando un sensore viene inserito attraverso l'esofago (TEPS - studio elettrofisiologico transesofageo). Permette di diagnosticare gli stadi iniziali della malattia coronarica, quando il paziente lamenta dolore al cuore durante l'attività fisica, ma l'ECG a riposo non rivela alcun cambiamento.
- ECG transesofageo– di norma, viene eseguito prima del TEE, così come nei casi in cui un ECG attraverso la parete toracica anteriore risulta non informativo e non aiuta il medico a stabilire la vera natura dei disturbi del ritmo cardiaco.
Indicazioni per l'ECG
Perché è necessario un ECG? L'elettrocardiografia consente di diagnosticare molte malattie cardiache. Le indicazioni per l'ECG sono:
1. Esame di routine di bambini, adolescenti, donne incinte, personale militare, conducenti, atleti, persone di età superiore ai 40 anni, pazienti prima di interventi chirurgici, pazienti con altre malattie (diabete mellito, malattie della tiroide, malattie polmonari, malattie dell'apparato digerente, ecc. );
2. Diagnosi di malattie:
- ipertensione arteriosa;
- malattia coronarica (CHD), compreso infarto miocardico acuto, subacuto, cardiosclerosi post-infartuale;
- cardiomiopatie endocrine, dismetaboliche, alcol-tossiche;
- insufficienza cardiaca cronica;
- difetti cardiaci;
- disturbi del ritmo e della conduzione - sindrome SVC, fibrillazione atriale, extrasistole, tachicardia - e bradicardia, blocco senoatriale e atrioventricolare, blocco di branca, ecc.
- pericardite
3. Controllo dopo il trattamento delle malattie elencate (farmaci o cardiochirurgia)
Controindicazioni per l'ECG
Non ci sono controindicazioni per l’elettrocardiografia standard. Tuttavia, la procedura stessa può essere difficile in persone con lesioni toraciche complesse, con un alto grado di obesità, con peli sul torace gravi (gli elettrodi semplicemente non saranno in grado di adattarsi perfettamente alla pelle). Anche la presenza di un pacemaker nel cuore del paziente può distorcere significativamente i dati ECG.
Esistono controindicazioni all'esecuzione di un ECG sotto sforzo: periodo acuto di infarto miocardico, malattie infettive acute, peggioramento dell'ipertensione arteriosa, malattia coronarica, insufficienza cardiaca cronica, disturbi del ritmo complessi, sospetto di dissezione dell'aneurisma aortico, scompenso (peggioramento della corso) di malattie di altri organi e sistemi – digestivo, respiratorio, urinario. Controindicazioni per l'ECG transesofageo sono le malattie dell'esofago: tumori, stenosi, diverticoli, ecc.
Preparazione per lo studio
Un ECG non richiede una preparazione speciale per il paziente. Non ci sono restrizioni sulle normali attività domestiche, sul mangiare o sul bere. Non è consigliabile consumare caffè, alcol o grandi quantità di sigarette prima della procedura, poiché ciò influenzerebbe il funzionamento del cuore al momento dello studio e i risultati potrebbero essere interpretati erroneamente.
Come viene eseguita l'elettrocardiografia?
Un ECG può essere eseguito in un ospedale o in una clinica. In ospedale viene effettuato uno studio su pazienti consegnati da un'équipe di ambulanza con sintomi cardiaci, o su pazienti già ricoverati in un ospedale di qualsiasi profilo (terapeutico, chirurgico, neurologico, ecc.). Nella clinica, l'ECG viene eseguito come esame di routine, nonché per i pazienti le cui condizioni di salute non richiedono il ricovero urgente.

Esecuzione di un ECG
Il paziente si presenta all'orario stabilito nella sala diagnostica ECG, si sdraia sul divano sulla schiena; l'infermiera pulisce il torace, i polsi e le caviglie con una spugna inumidita con acqua (per una migliore conduttività) e posiziona gli elettrodi: una "molletta" sui polsi e sui piedi e sei "ventose" sul petto nella proiezione del cuore. Successivamente, il dispositivo viene acceso, viene letta l'attività elettrica del cuore e il risultato viene registrato sotto forma di curva grafica su pellicola termica utilizzando un registratore a inchiostro o immediatamente salvato nel computer del medico. L'intero studio dura circa 5 - 10 minuti, senza provocare alcun disagio al paziente.
Successivamente, l'ECG viene analizzato da un medico di diagnostica funzionale, dopo di che la conclusione viene data al paziente o inviata direttamente allo studio del medico curante. Se l'ECG non rivela cambiamenti gravi che richiedano ulteriore osservazione in ospedale, il paziente può tornare a casa.
Interpretazione dell'ECG
Ora diamo uno sguardo più da vicino all'analisi dell'elettrocardiogramma. Ogni complesso di un elettrocardiogramma normale è costituito da onde P, Q, R, S, T e segmenti - PQ e ST. I denti possono essere positivi (diretti verso l'alto) o negativi (diretti verso il basso) e i segmenti sono sopra e sotto l'isolinea.

Il paziente vedrà i seguenti indicatori nel protocollo ECG:
1. Fonte di eccitazione. Durante la normale funzione cardiaca, la fonte si trova nel nodo del seno, cioè il ritmo è sinusale. I suoi segni sono la presenza di onde P positive nell'undicesima derivazione davanti a ciascun complesso ventricolare della stessa forma. Il ritmo non sinusale è caratterizzato da onde P negative e si manifesta con blocco senoatriale, extrasistole, fibrillazione atriale, flutter atriale, fibrillazione e flutter ventricolare.
2. Correttezza (regolarità) del ritmo. Viene determinato quando la distanza tra le onde R di diversi complessi differisce non più del 10%. Se il ritmo è anomalo viene indicata anche la presenza di aritmie. Un ritmo sinusale ma irregolare si verifica con l'aritmia sinusale (respiratoria), mentre un ritmo sinusale regolare si verifica con bradi sinusale e tachicardia.
3. FC: frequenza cardiaca. Normalmente 60 – 80 battiti al minuto. Una condizione con una frequenza cardiaca inferiore a questo valore è chiamata bradicardia (battito cardiaco lento), mentre al di sopra è chiamata tachicardia (battito cardiaco accelerato).
4. Determinazione dell'EOS (rotazione dell'asse elettrico del cuore). EOS è il vettore sommatore dell'attività elettrica del cuore, coincidente con la direzione del suo asse anatomico. Normalmente, l'EOS varia dalla posizione semi-verticale a quella semi-orizzontale. Nelle persone obese il cuore è posizionato orizzontalmente, mentre nelle persone magre è più verticale. Le deviazioni dell'EOS possono indicare ipertrofia miocardica (proliferazione del muscolo cardiaco, ad esempio, con ipertensione arteriosa, difetti cardiaci, cardiomiopatie) o disturbi della conduzione (blocco delle gambe e dei rami del fascio di His).
5. Analisi dell'onda P. L'onda P riflette la comparsa di un impulso nel nodo senoatriale e la sua conduzione attraverso gli atri. Normalmente, l'onda P è positiva (l'eccezione è la piombo aVR), la sua larghezza è fino a 0,1 secondi e la sua altezza va da 1,5 a 2,5 mm. La deformazione dell'onda P è caratteristica della patologia della valvola mitrale (P mitrale) o delle malattie del sistema broncopolmonare con sviluppo di insufficienza circolatoria (P pulmonale).
6. Analisi del segmento PQ. Riflette la conduzione e il ritardo fisiologico dell'impulso attraverso il nodo atrioventricolare ed è compreso tra 0,02 e 0,09 sec. Un cambiamento nella durata è caratteristico dei disturbi della conduzione: sindrome PQ abbreviata, blocco atrioventricolare.
7. Analisi del complesso QRS. Riflette la conduzione di un impulso lungo il setto interventricolare e il miocardio ventricolare. Normalmente, la sua durata è fino a 0,1 secondi. Un cambiamento nella sua durata, così come la deformazione del complesso, è caratteristico dell'infarto miocardico, del blocco di branca, dell'extrasistole ventricolare e della tachicardia ventricolare parossistica.
8. Analisi del segmento ST. Riflette il processo di copertura completa dei ventricoli mediante eccitazione. Normalmente si trova sull'isolinea; è consentito uno spostamento verso l'alto o verso il basso di 0,5 mm. La depressione (diminuzione) o l'elevazione del tratto ST indicano la presenza di ischemia miocardica o lo sviluppo di infarto miocardico.
9. Analisi dell'onda T. Riflette il processo di attenuazione dell'eccitazione ventricolare. Normalmente positivo. Un T negativo indica anche la presenza di ischemia o piccolo infarto miocardico focale.
Il paziente deve ricordare che l'analisi indipendente del protocollo ECG non è accettabile. L'interpretazione degli indicatori dell'elettrocardiogramma deve essere eseguita solo da un medico di diagnostica funzionale, un cardiologo, un terapista o un medico d'urgenza, poiché solo un medico, durante un esame di persona, può confrontare i dati ottenuti con i sintomi clinici e il rischio di condizioni che richiedono un trattamento, compreso in un ospedale. Altrimenti, sottovalutare la conclusione dell’ECG può danneggiare la salute e la vita di una persona.
Complicazioni dell'ECG
Ci sono possibili complicazioni durante l'elettrocardiografia? La procedura ECG è abbastanza innocua e sicura, quindi non ci sono complicazioni. Quando si esegue un ECG sotto stress, può verificarsi un aumento della pressione sanguigna, disturbi del ritmo e della conduzione nel cuore, ma questo, piuttosto, può essere attribuito non a complicazioni, ma a malattie, per il chiarimento delle quali sono stati prescritti test provocatori.
Il medico di medicina generale Sazykina O.Yu.
L'elettrocardiografia è uno dei metodi più comuni e più informativi per diagnosticare un numero enorme di malattie. Un ECG comporta una visualizzazione grafica dei potenziali elettrici che si formano nel cuore pulsante. Gli indicatori vengono rilevati e visualizzati utilizzando dispositivi speciali: elettrocardiografi, che vengono costantemente migliorati.
Sommario:Di norma, durante lo studio vengono registrate 5 onde: P, Q, R, S, T. In alcuni momenti è possibile registrare un'onda U sottile.

L'elettrocardiografia consente di identificare i seguenti indicatori, nonché le varianti delle deviazioni dai valori di riferimento:
- Frequenza cardiaca (polso) e regolarità delle contrazioni miocardiche (si possono rilevare aritmie ed extrasistoli);
- Disturbi del muscolo cardiaco di natura acuta o cronica (in particolare con ischemia o infarto);
- disordini metabolici dei principali composti ad attività elettrolitica (K, Ca, Mg);
- disturbi della conduzione intracardiaca;
- ipertrofia del cuore (atri e ventricoli).
 Nota:Se utilizzato in parallelo con un cardiofono, l'elettrocardiografo consente di determinare a distanza alcune malattie cardiache acute (presenza di aree di ischemia o infarti).
Nota:Se utilizzato in parallelo con un cardiofono, l'elettrocardiografo consente di determinare a distanza alcune malattie cardiache acute (presenza di aree di ischemia o infarti).
L’ECG è la tecnica di screening più importante per individuare la malattia coronarica. Informazioni preziose sono fornite dall'elettrocardiografia con il cosiddetto. "test di stress".
Isolato o in combinazione con altre tecniche diagnostiche, l'ECG viene spesso utilizzato nello studio dei processi cognitivi (di pensiero).
Importante:Durante la visita medica è necessario eseguire un elettrocardiogramma, indipendentemente dall'età e dalle condizioni generali del paziente.
Consigliamo la lettura:ECG: indicazioni per la prestazione
Esistono numerose patologie del sistema cardiovascolare e di altri organi e sistemi per i quali è prescritto l'esame elettrocardiografico. Questi includono:
- angina pectoris;
- infarto miocardico;
- artrite reattiva;
- peri- e miocardite;
- periarterite nodosa;
- aritmie;
- insufficienza renale acuta;
- nefropatia diabetica;
- sclerodermia.
Con l'ipertrofia ventricolare destra, aumenta l'ampiezza dell'onda S nelle derivazioni V1-V3, che può essere un indicatore di patologia simmetrica da parte del ventricolo sinistro.

Nell'ipertrofia ventricolare sinistra, l'onda R è pronunciata nelle derivazioni precordiali sinistre e la sua profondità è aumentata nelle derivazioni V1-V2. L'asse elettrico è orizzontale o deviato a sinistra, ma spesso può corrispondere alla norma. Il complesso QRS nella derivazione V6 è caratterizzato da una forma qR o R.
Nota:Questa patologia è spesso accompagnata da alterazioni secondarie del muscolo cardiaco (distrofia).
L'ipertrofia atriale sinistra è caratterizzata da un aumento abbastanza significativo dell'onda P (fino a 0,11-0,14 s). Acquisisce una forma a “due gobbe” nel petto sinistro e conduce I e II. In rari casi clinici si nota un certo appiattimento dell'onda e la durata della deviazione interna di P supera 0,06 s nelle derivazioni I, II, V6. Tra le evidenze prognosticamente più attendibili di questa patologia vi è l'aumento della fase negativa dell'onda P nella derivazione V1.
L'ipertrofia dell'atrio destro è caratterizzata da un aumento dell'ampiezza dell'onda P (oltre 1,8-2,5 mm) nelle derivazioni II, III, aVF. Questo dente acquisisce una caratteristica forma appuntita e l'asse elettrico P è installato verticalmente o presenta un leggero spostamento verso destra.
L'ipertrofia atriale combinata è caratterizzata dall'espansione parallela dell'onda P e da un aumento della sua ampiezza. In alcuni casi clinici si notano cambiamenti come l'affilamento di P nelle derivazioni II, III, aVF e lo sdoppiamento dell'apice in I, V5, V6. Nella derivazione V1 si registra occasionalmente un aumento di entrambe le fasi dell'onda P.

Per i difetti cardiaci formati durante lo sviluppo intrauterino, è più comune un aumento significativo dell'ampiezza dell'onda P nelle derivazioni V1-V3.
Nei pazienti con una forma grave di cardiopatia polmonare cronica con danno polmonare enfisematoso, di norma, viene determinato un ECG di tipo S.
Importante:l'ipertrofia combinata di due ventricoli contemporaneamente viene raramente rilevata dall'elettrocardiografia, soprattutto se l'ipertrofia è uniforme. In questo caso i segni patologici tendono a compensarsi a vicenda.
Con la "sindrome da eccitazione ventricolare prematura" sull'ECG, la larghezza del complesso QRS aumenta e l'intervallo PR si accorcia. L'onda delta, che influenza l'aumento del complesso QRS, si forma a seguito di un aumento precoce dell'attività delle aree del muscolo cardiaco dei ventricoli.
I blocchi sono causati dalla cessazione dell'impulso elettrico in una delle aree.

I disturbi della conduzione degli impulsi si manifestano sull'ECG con un cambiamento nella forma e un aumento delle dimensioni dell'onda P e con un blocco intraventricolare - un aumento del QRS. Il blocco atrioventricolare può essere caratterizzato dalla perdita di singoli complessi, da un aumento dell'intervallo P-Q e, nei casi più gravi, da una completa assenza di connessione tra QRS e P.
Importante:il blocco senoatriale appare sull'ECG come un'immagine piuttosto luminosa; è caratterizzato dalla completa assenza del complesso PQRST.
In caso di disturbi del ritmo cardiaco, i dati dell'elettrocardiografia vengono valutati sulla base dell'analisi e del confronto di intervalli (inter e intraciclo) per 10-20 secondi o anche di più.

La direzione e la forma dell'onda P, così come il complesso QRS, sono di grande importanza diagnostica nella diagnosi delle aritmie.
Distrofia miocardica
Questa patologia è visibile solo in alcune derivazioni. Si manifesta con cambiamenti nell'onda T. Di norma, si osserva la sua pronunciata inversione. In un certo numero di casi, viene registrata una deviazione significativa dalla normale linea RST. La distrofia pronunciata del muscolo cardiaco si manifesta spesso con una marcata diminuzione dell'ampiezza delle onde QRS e P.
Se un paziente sviluppa un attacco di angina, l'elettrocardiogramma mostra una notevole diminuzione (depressione) dell'RST e, in alcuni casi, un'inversione di T. Questi cambiamenti nell'ECG riflettono processi ischemici negli strati intramurali e subendocardici del muscolo cardiaco di il ventricolo sinistro. Queste aree sono le più esigenti per l'afflusso di sangue.
Nota:un aumento a breve termine del segmento RST è un segno caratteristico di una patologia nota come angina di Prinzmetal.
In circa il 50% dei pazienti, tra un attacco di angina e l'altro, è possibile che i cambiamenti sull'ECG non vengano registrati affatto. 
In questa condizione pericolosa per la vita, un elettrocardiogramma fornisce informazioni sull'entità della lesione, sulla sua esatta posizione e profondità. Inoltre, un ECG consente di monitorare il processo patologico nel tempo.
Morfologicamente è consuetudine distinguere tre zone:
- centrale (zona di cambiamenti necrotici nel tessuto miocardico);
- la zona di distrofia pronunciata del muscolo cardiaco che circonda la lesione;
- zona periferica di pronunciati cambiamenti ischemici.
Tutti i cambiamenti che si riflettono sull'ECG cambiano dinamicamente in base allo stadio di sviluppo dell'infarto miocardico.

Distrofia miocardica disormonale
La distrofia miocardica, causata da un brusco cambiamento nel background ormonale del paziente, si manifesta solitamente con un cambiamento nella direzione (inversioni) dell'onda T. I cambiamenti depressivi nel complesso RST sono molto meno comuni.
Importante: la gravità delle modifiche può variare nel tempo. I cambiamenti patologici registrati sull'ECG sono solo in rari casi associati a sintomi clinici come dolore al torace.
Per distinguere le manifestazioni della malattia coronarica dalla distrofia miocardica sullo sfondo dello squilibrio ormonale, i cardiologi praticano test utilizzando agenti farmacologici come bloccanti dei recettori beta-adrenergici e farmaci contenenti potassio.
Cambiamenti nei parametri dell'elettrocardiogramma mentre il paziente sta assumendo determinati farmaci
I cambiamenti nel modello ECG possono essere causati dall'assunzione dei seguenti farmaci:
- farmaci del gruppo dei diuretici;
- farmaci correlati ai glicosidi cardiaci;
- Amiodarone;
- Chinidina.
In particolare, se il paziente assume preparati digitalici (glicosidi) nelle dosi raccomandate, si determina il sollievo dalla tachicardia (battito cardiaco accelerato) e una diminuzione dell'intervallo Q-T. Sono anche possibili il "livellamento" del segmento RST e l'accorciamento di T. Un sovradosaggio di glicosidi si manifesta con cambiamenti gravi come l'aritmia (extrasistoli ventricolari), il blocco AV e persino una condizione pericolosa per la vita - fibrillazione ventricolare (richiede misure di rianimazione immediate) .
La patologia provoca un aumento eccessivo del carico sul ventricolo destro e porta alla sua carenza di ossigeno e ai cambiamenti distrofici in rapido aumento. In tali situazioni, al paziente viene diagnosticato un “cuore polmonare acuto”. In presenza di embolia polmonare non è raro il blocco dei rami del fascio di His.
L'ECG mostra un aumento del segmento RST in parallelo nelle derivazioni III (a volte in aVF e V1,2). C'è un'inversione T nelle derivazioni III, aVF, V1-V3.

La dinamica negativa aumenta rapidamente (passano pochi minuti) e la progressione viene notata entro 24 ore. Con dinamiche positive, i sintomi caratteristici scompaiono gradualmente entro 1-2 settimane.
Ripolarizzazione precoce dei ventricoli cardiaci
Questa deviazione è caratterizzata da uno spostamento verso l'alto del complesso RST dal cosiddetto isolinee. Un altro segno caratteristico è la presenza di un'onda di transizione specifica sulle onde R o S. Questi cambiamenti nell'elettrocardiogramma non sono ancora stati associati ad alcuna patologia miocardica, quindi sono considerati una norma fisiologica.
Pericardite
L'infiammazione acuta del pericardio si manifesta con un significativo innalzamento unidirezionale del segmento RST in qualsiasi derivazione. In alcuni casi clinici, lo spostamento può essere discordante.
Miocardite
L'infiammazione del muscolo cardiaco è evidente sull'ECG dalle deviazioni dall'onda T. Possono variare da una diminuzione della tensione a un'inversione. Se, parallelamente, il cardiologo esegue test con farmaci contenenti potassio o β-bloccanti, l'onda T rimane negativa.
Le malattie cardiovascolari rappresentano la causa di morte più comune nella società postindustriale. La diagnosi e il trattamento tempestivi del sistema cardiovascolare aiutano a ridurre il rischio di sviluppare patologie cardiache tra la popolazione.
Un elettrocardiogramma (ECG) è uno dei metodi più semplici e informativi per studiare l'attività cardiaca. Un ECG registra l'attività elettrica del muscolo cardiaco e visualizza le informazioni sotto forma di onde su un nastro di carta.
I risultati dell'ECG vengono utilizzati in cardiologia per diagnosticare varie malattie. Non è consigliabile eseguire il trattamento cardiaco da soli, è meglio consultare uno specialista. Tuttavia, per avere un'idea generale, vale la pena sapere cosa mostra il cardiogramma.
Indicazioni per un elettrocardiogramma
Nella pratica clinica, ci sono diverse indicazioni per l'elettrocardiografia:
- forte dolore al petto;
- svenimento costante;
- dispnea;
- intolleranza all'esercizio;
- vertigini;
- soffi al cuore.
Durante un esame di routine, un ECG è un metodo diagnostico obbligatorio. Potrebbero esserci altre indicazioni determinate dal medico curante. Se riscontri altri sintomi allarmanti, consulta immediatamente il medico per determinarne la causa.
Come decifrare un cardiogramma del cuore?
Un piano rigoroso per decifrare un ECG consiste nell'analizzare il grafico risultante. In pratica viene utilizzato solo il vettore totale del complesso QRS. Il lavoro del muscolo cardiaco è presentato sotto forma di una linea continua con segni e designazioni alfanumeriche. Chiunque può decifrare un ECG con una certa formazione, ma solo un medico può fare la diagnosi corretta. L'analisi dell'ECG richiede la conoscenza dell'algebra, della geometria e la comprensione dei simboli delle lettere.
Indicatori ECG che devono essere presi in considerazione quando si interpretano i risultati:
- intervalli;
- segmenti;
- denti.
Ci sono indicatori rigorosi di normalità sull'ECG e qualsiasi deviazione è già un segno di disturbi nel funzionamento del muscolo cardiaco. La patologia può essere esclusa solo da uno specialista qualificato, un cardiologo.
Interpretazione dell'ECG negli adulti: la norma nella tabella
Analisi del cardiogramma
L'ECG registra l'attività cardiaca in dodici derivazioni: 6 derivazioni degli arti (aVR, aVL, aVF, I, II, III) e sei derivazioni toraciche (V1-V6). L'onda P riflette il processo di eccitazione e rilassamento degli atri. Le onde Q, S mostrano la fase di depolarizzazione del setto interventricolare. L'onda R indica la depolarizzazione delle camere inferiori del cuore e l'onda T indica il rilassamento del miocardio.
 Analisi dell'elettrocardiogramma
Analisi dell'elettrocardiogramma Il complesso QRS mostra il momento della depolarizzazione ventricolare. Il tempo impiegato da un impulso elettrico per viaggiare dal nodo SA al nodo AV è misurato dall'intervallo PR.
I computer integrati nella maggior parte dei dispositivi ECG sono in grado di misurare il tempo impiegato da un impulso elettrico per viaggiare dal nodo SA ai ventricoli. Queste misurazioni possono aiutare il medico a valutare la frequenza cardiaca e alcuni tipi di blocco cardiaco.
I programmi per computer possono anche interpretare i risultati dell'ECG. E man mano che l’intelligenza artificiale e la programmazione migliorano, spesso diventano più precise. Tuttavia, l’interpretazione dell’ECG presenta molte sottigliezze, quindi i fattori umani rimangono ancora una parte importante della valutazione.
Potrebbero essere presenti anomalie nell’elettrocardiogramma che non influiscono sulla qualità della vita del paziente. Tuttavia, esistono standard per la normale prestazione cardiaca accettati dalla comunità cardiologica internazionale.
Sulla base di questi standard, un normale elettrocardiogramma in una persona sana si presenta così:
- Intervallo RR – 0,6-1,2 secondi;
- Onda P – 80 millisecondi;
- Intervallo PR – 120-200 millisecondi;
- Segmento PR – 50-120 millisecondi;
- Complesso QRS – 80-100 millisecondi;
- Onda J: assente;
- Segmento ST – 80-120 millisecondi;
- Onda T – 160 millisecondi;
- Intervallo ST – 320 millisecondi;
- L'intervallo QT è di 420 millisecondi o meno se la frequenza cardiaca è di sessanta battiti al minuto.
- ind.succo – 17.3.
 ECG normale
ECG normale Parametri patologici dell'ECG
L'ECG in condizioni normali e patologiche è significativamente diverso. Pertanto, è necessario avvicinarsi con attenzione alla decodifica del cardiogramma cardiaco.
Complesso QRS
Qualsiasi anomalia nel sistema elettrico del cuore provoca un prolungamento del complesso QRS. I ventricoli hanno una massa muscolare maggiore rispetto agli atri, quindi il complesso QRS è significativamente più lungo dell'onda P. La durata, l'ampiezza e la morfologia del complesso QRS sono utili per identificare aritmie cardiache, anomalie di conduzione, ipertrofia ventricolare, infarto miocardico, alterazioni elettrolitiche anomalie e altre condizioni patologiche.
Denti Q, R, T, P, U
Le onde Q anomale si verificano quando un segnale elettrico passa attraverso il muscolo cardiaco danneggiato. Sono considerati marcatori di precedente infarto miocardico.
Anche la depressione dell'onda R è solitamente associata all'infarto del miocardio, ma può anche essere causata dal blocco di branca sinistra, dalla sindrome di WPW o dall'ipertrofia delle camere inferiori del muscolo cardiaco.
 La tabella degli indicatori ECG è normale
La tabella degli indicatori ECG è normale L'inversione dell'onda T è sempre considerata un valore anomalo sul nastro ECG. Tale onda può essere un segno di ischemia coronarica, sindrome di Wellens, ipertrofia delle camere cardiache inferiori o di un disturbo del sistema nervoso centrale.
Un'onda P con ampiezza aumentata può indicare ipokaliemia e ipertrofia atriale destra. Al contrario, un'onda P con ampiezza ridotta può indicare iperkaliemia.
Le onde U si osservano più spesso in caso di ipokaliemia, ma possono anche essere presenti in caso di ipercalcemia, tireotossicosi o assunzione di epinefrina, farmaci antiaritmici di classe 1A e 3. Si riscontrano spesso nella sindrome congenita del QT lungo e nell'emorragia intracranica.
Un'onda U invertita può indicare cambiamenti patologici nel miocardio. A volte è possibile osservare un'altra onda U sugli ECG negli atleti.
Intervalli QT, ST, PR
Il prolungamento del QTc provoca potenziali d’azione prematuri durante le fasi tardive della depolarizzazione. Ciò aumenta il rischio di sviluppare aritmie ventricolari o fibrillazione ventricolare fatale. Tassi più elevati di prolungamento dell’intervallo QTc si osservano nelle donne, nei pazienti anziani, nei pazienti ipertesi e nelle persone di bassa statura.
Le cause più comuni del prolungamento dell’intervallo QT sono l’ipertensione e alcuni farmaci. La durata dell'intervallo viene calcolata utilizzando la formula di Bazett. Con questo sintomo, l'interpretazione dell'elettrocardiogramma dovrebbe essere eseguita tenendo conto dell'anamnesi. Questa misura è necessaria per eliminare l'influenza ereditaria.
La depressione dell'intervallo ST può indicare ischemia coronarica, infarto miocardico transmurale o ipokaliemia.
 Caratteristiche di tutti gli indicatori di ricerca elettrocardiografica
Caratteristiche di tutti gli indicatori di ricerca elettrocardiografica Un intervallo PR prolungato (maggiore di 200 ms) può indicare un blocco cardiaco di primo grado. Il prolungamento può essere associato a ipokaliemia, febbre reumatica acuta o malattia di Lyme. Un breve intervallo PR (meno di 120 ms) può essere associato alla sindrome di Wolff-Parkinson-White o alla sindrome di Lown-Ganong-Levine. La depressione del segmento PR può indicare un danno atriale o una pericardite.
Esempi di descrizioni della frequenza cardiaca e interpretazione dell'ECG
Ritmo sinusale normale
Il ritmo sinusale è qualsiasi ritmo cardiaco in cui l'eccitazione del muscolo cardiaco inizia dal nodo senoatriale. È caratterizzato da onde P orientate correttamente sull'ECG. Per convenzione, il termine "ritmo sinusale normale" comprende non solo le onde P normali, ma anche tutte le altre misurazioni ECG.
 Norma dell'ECG e interpretazione di tutti gli indicatori
Norma dell'ECG e interpretazione di tutti gli indicatori Norma ECG negli adulti:
- frequenza cardiaca da 55 a 90 battiti al minuto;
- ritmo regolare;
- intervallo PR, complesso QT e QRS normali;
- Il complesso QRS è positivo in quasi tutte le derivazioni (I, II, AVF e V3-V6) e negativo in aVR.
Bradicardia sinusale
Una frequenza cardiaca inferiore a 55 nel ritmo sinusale è chiamata bradicardia. L'interpretazione dell'ECG negli adulti dovrebbe tenere conto di tutti i parametri: sport, fumo, anamnesi. Perché in alcuni casi la bradicardia è una variante della norma, soprattutto negli atleti.
La bradicardia patologica si verifica con la sindrome del nodo senoatriale debole e viene registrata sull'ECG in qualsiasi momento della giornata. Questa condizione è accompagnata da svenimenti costanti, pallore e iperidrosi. In casi estremi, i pacemaker vengono prescritti per la bradicardia maligna.
 Bradicardia sinusale
Bradicardia sinusale Segni di bradicardia patologica:
- frequenza cardiaca inferiore a 55 battiti al minuto;
- ritmo sinusale;
- Le onde P sono verticali, coerenti e normali nella morfologia e nella durata;
- Intervallo PR da 0,12 a 0,20 secondi;
Tachicardia sinusale
Un ritmo regolare con una frequenza cardiaca elevata (superiore a 100 battiti al minuto) è comunemente chiamato tachicardia sinusale. Tieni presente che la frequenza cardiaca normale varia a seconda dell'età; ad esempio, nei neonati, la frequenza cardiaca può raggiungere i 150 battiti al minuto, un valore considerato normale.
Consiglio! A casa, una forte tosse o una pressione sui bulbi oculari possono aiutare in caso di grave tachicardia. Queste azioni stimolano il nervo vago, che attiva il sistema nervoso parasimpatico, facendo battere il cuore più lentamente.
 Tachicardia sinusale
Tachicardia sinusale Segni di tachicardia patologica:
- La frequenza cardiaca è superiore a cento battiti al minuto;
- ritmo sinusale;
- Le onde P sono verticali, coerenti e normali nella morfologia;
- L'intervallo PR oscilla tra 0,12-0,20 secondi e si accorcia con l'aumento della frequenza cardiaca;
- Complesso QRS inferiore a 0,12 secondi.
Fibrillazione atriale
La fibrillazione atriale è un ritmo cardiaco anomalo caratterizzato da una contrazione rapida e irregolare degli atri. La maggior parte degli episodi sono asintomatici. A volte un attacco è accompagnato dai seguenti sintomi: tachicardia, svenimento, vertigini, mancanza di respiro o dolore al petto. La malattia è associata ad un aumentato rischio di insufficienza cardiaca, demenza e ictus.
 Fibrillazione atriale
Fibrillazione atriale Segni di fibrillazione atriale:
- La frequenza cardiaca è invariata o accelerata;
- Le onde P sono assenti;
- l'attività elettrica è caotica;
- Gli intervalli RR sono irregolari;
- Complesso QRS inferiore a 0,12 secondi (in rari casi, il complesso QRS si allunga).
Importante! Nonostante le spiegazioni di cui sopra con la decodifica dei dati, la conclusione dell'ECG dovrebbe essere effettuata solo da uno specialista qualificato: un cardiologo o un medico generico. La decodifica dell'elettrocardiogramma e la diagnosi differenziale richiedono un'istruzione medica superiore.
Come “leggere” l'infarto miocardico su un ECG?
Gli studenti che iniziano a studiare cardiologia hanno spesso una domanda: come imparare a leggere correttamente un cardiogramma e identificare l'infarto miocardico (IM)? Puoi "leggere" un infarto su un nastro di carta in base a diversi segni:
- Elevazione del segmento ST;
- onda T con picco;
- onda Q profonda o mancanza della stessa.
Quando si analizzano i risultati dell'elettrocardiografia, vengono prima identificati questi indicatori e poi vengono trattati gli altri. A volte il primo segno di infarto miocardico acuto è solo un’onda T con picco. In pratica, questo è piuttosto raro perché compare solo 3-28 minuti dopo l'inizio di un infarto.
ELETTROCARDIOGRAMMA
ELETTROCARDIOGRAMMA -S; E. Immagine grafica del cuore, realizzata da un elettrocardiografo. Fai un elettrocardiogramma. / Razg. Sullo stato del cuore, sul lavoro del cuore. Cattivo e. Soddisfacente e. E. è migliorato.
ELETTROCARDIOGRAMMAELETTROCARDIOGRAMMA (ECG), una curva che riflette l'attività bioelettrica del cuore.
Quando il cuore è eccitato, sulla sua superficie e nei suoi tessuti si forma una differenza di potenziale, che cambia naturalmente in grandezza e direzione man mano che nuove aree del cuore vengono coinvolte nell'eccitazione. L'attività bioelettrica delle diverse parti del cuore avviene in una sequenza rigorosamente definita, ripetuta in ogni ciclo di eccitazione cardiaca. I cambiamenti risultanti nelle cariche sulla superficie del cuore creano un campo elettrico dinamico nel mezzo conduttore che circonda il cuore, che può essere registrato dalla superficie del corpo dopo un'adeguata amplificazione sotto forma di una differenza di potenziale variabile. Ciò produce una curva caratteristica composta da più denti separati da determinati intervalli. Questa curva è chiamata elettrocardiogramma - ECG. Le onde ECG sono designate dalle lettere latine P, Q, R, S e T e gli intervalli, o segmenti, corrispondenti sono P-Q, S-T, Q-T. Le onde e gli intervalli dell'ECG riflettono i processi di attivazione e recupero in diverse parti del cuore.
Storia dell'elettrocardiografia
Per la prima volta, la presenza di fenomeni elettrici nel cuore in contrazione di una rana fu suggerita dai ricercatori tedeschi A. Kölliker e G. Müller (1856), i quali, applicando un nervo al muscolo cardiaco, osservarono una contrazione ritmica del muscolo scheletrico in ritmo con il cuore. Nel 1862 I. M. Sechenov (cm. SECHENOV Ivan Mikhailovich) nella monografia “On Animal Electricity” scrisse che quando il nervo dell'“apparato motore” di una rana viene applicato al ventricolo del cuore di un coniglio, “il muscolo dell'apparato della rana trema ad ogni sistole del ventricolo. " Questa è la prima menzione conosciuta della presenza di fenomeni elettrici nel cuore degli animali a sangue caldo. La prima registrazione strumentale dell'attività elettrica del cuore in una tartaruga e in una rana fu effettuata da Moray nel 1876 utilizzando un elettrometro capillare Lipmann. Il primo ECG umano fu registrato nel 1887 dal ricercatore inglese A. Waller utilizzando un elettrometro capillare. Waller ha posizionato degli elettrodi per la registrazione dei potenziali sul busto (petto e schiena) e sugli arti di una persona. Successivamente, lo stesso ricercatore ha pubblicato un metodo per registrare l'ECG negli animali (cane, gatto, cavallo). Insegnò ai suoi animali domestici a stare tranquillamente in vasche d'acqua per garantire un contatto affidabile del corpo con l'apparecchio di registrazione e ottenne lo stesso tipo di curve in tutti gli animali. Metodologia per la rimozione dell'ECG dalle estremità successivamente su suggerimento dello scienziato olandese V. Einthoven (cm. EINTHOVEN Willem)è diventato universale e standard. Nelle sue ricerche, V. Einthoven utilizzò un galvanometro a corda più avanzato, che permise di registrare l'ECG nella sua espressione moderna; all'inizio del secolo introdusse in pratica il termine "elettrocardiogramma", designando le onde ECG e intervalli, introdusse derivazioni standard e sviluppò la prima teoria degli elettrocardiogrammi di genesi. In Russia, l'introduzione del metodo elettrocardiografico è associata al lavoro di A.F. Samoilova (cm. SAMOILOV Aleksandr Filippovič), che introdusse nella pratica il termine ECG e creò una delle teorie sulla genesi dell'elettrocardiogramma.
Relazione tra eccitazione delle strutture cardiache e onde e intervalli ECG.
Nel cuore degli animali a sangue caldo e degli esseri umani, l'eccitazione avviene nel nodo senoauricolare (nel cuore di una rana - il nodo senoatriale). L'eccitazione di questo nodo non viene registrata sull'ECG, viene rilevata solo con metodi speciali. L'inizio dell'eccitazione atriale corrisponde all'onda P dell'ECG. Questo è seguito dall'intervallo PQ, durante il quale l'eccitazione viene trasferita al nodo atrioventricolare. Il complesso QRS corrisponde alla copertura di eccitazione del miocardio ventricolare lavorativo. Dopo il complesso QRS viene registrato l'intervallo isoelettrico S-T, durante il quale l'intera superficie dei ventricoli rimane eccitata. Normalmente, il segmento S-T devia dal livello isoelettrico di non più di 0,1 mV.
L'inizio del processo di recupero nei ventricoli corrisponde alla comparsa dell'onda T, al termine della quale il recupero è completamente completato. Dopo l'onda T viene registrato l'intervallo isoelettrico, corrispondente al rilassamento del cuore.
Metodi di derivazione ECG
L'entità della differenza di potenziale catturata dagli elettrodi dipende dalla distanza degli elettrodi dal cuore, dal grado di conduttività elettrica del tessuto tra il cuore e gli elettrodi e dalla massa degli elementi eccitati del cuore che generano l'elettromotore forza. Pertanto, per poter confrontare e contrapporre gli ECG di persone diverse o tracciare la dinamica dei cambiamenti nell'ECG della stessa persona, è stato necessario standardizzare i metodi di derivazione. A questo scopo, gli elettrodi di rapimento vengono applicati su aree del corpo strettamente definite - a seconda di ciò, si parla dell'uno o dell'altro metodo di rapimento. I metodi principali sono le derivazioni degli arti, o derivazioni standard, e le derivazioni toraciche unipolari.
In clinica e negli esperimenti fisiologici vengono utilizzati numerosi altri metodi di registrazione dell'ECG: derivazioni unipolari dagli arti e dal torace, derivazioni esofagee (l'elettrodo attivo è localizzato nell'esofago nell'area in cui si trovano alcune parti del cuore) , elettrocateteri intracavitari (l'elettrodo funge da elettrodo attivo), un catetere che viene inserito attraverso la vena giugulare nella cavità cardiaca), ecc.
Standard dell'ECG
L'ampiezza e la durata delle onde, così come la dimensione degli intervalli ECG, cambiano naturalmente con vari influssi fisici e fisiologici sul cuore - con l'attività fisica, i cambiamenti nella posizione del corpo, ecc. Questi cambiamenti possono essere causati, da un lato , da fenomeni puramente fisici, ad esempio, cambiamenti nella posizione del cuore nel torace durante la respirazione, quando si cambia postura, cambiamenti nella conduttività elettrica dei tessuti tra il cuore e gli elettrodi di scarica durante la respirazione. D'altra parte, possono anche essere causati da ragioni fisiologiche: cambiamenti nell'afflusso venoso, effetti riflessi sul lavoro del cuore e sulla velocità di conduzione in esso.
Pertanto, con il normale funzionamento del cuore, la forma dell'ECG può variare entro certi limiti. In relazione a ciò, una condizione indispensabile per la corretta interpretazione dell'ECG in vari tipi di patologia cardiaca è la capacità di riconoscere la normale curva elettrocardiografica in tutte le sue varietà. Varianti ECG normali possono essere trovate in vari riferimenti clinici e libri di testo sull'elettrocardiografia.
Per varie patologie cardiache, la forma dell'ECG si discosta significativamente dagli standard sopra indicati. Quelli che si riflettono più chiaramente sull'ECG sono i processi patologici associati a disturbi nell'attività ritmica del cuore (extrasistole (cm. EXTRASISTOLIA), fibrillazione, ecc.), eccitazione (blocco di branca), la comparsa di focolai ischemici L'ECG consente di diagnosticare varie forme di infarto miocardico e monitorare il processo di ripristino della circolazione coronarica nel periodo post-infarto.
Dizionario enciclopedico. 2009 .
Sinonimi:Scopri cos'è "ELETTROCARDIOGRAMMA" in altri dizionari:
Elettrocardiogramma... Libro di consultazione del dizionario ortografico
- (ECG), registrazione dell'attività elettrica del cuore effettuata mediante un dispositivo su una striscia di carta in movimento. Un dispositivo che serve a questo scopo è chiamato elettrocardiografo. L'ECG viene utilizzato per diagnosticare le malattie cardiache... Dizionario enciclopedico scientifico e tecnico
Sostantivo, numero di sinonimi: 3 cardiogramma (8) normogramma (1) ecg (1) ... Dizionario dei sinonimi
elettrocardiogramma- - [Ya.N.Luginsky, M.S.Fezi Zhilinskaya, Yu.S.Kabirov. Dizionario inglese-russo di ingegneria elettrica e ingegneria energetica, Mosca, 1999] Argomenti di ingegneria elettrica, concetti di base Elettrocardiogramma EN ... Guida del traduttore tecnico
L'elettrocardiografia è una tecnica per la registrazione e lo studio dei campi elettrici generati durante il lavoro del cuore. L'elettrocardiografia è un metodo relativamente economico ma prezioso di diagnostica strumentale elettrofisiologica in ... ... Wikipedia
- (vedi elettrico...) registrazione grafica dei fenomeni elettrici che si verificano nel cuore durante il suo funzionamento cfr. cardiogramma). Nuovo dizionario di parole straniere. di EdwART, 2009. elettrocardiogramma med. curva di registrazione dell'attività cardiaca ottenuta... ... Dizionario delle parole straniere della lingua russa
- (elettro + cardiogramma; ECG; sin. actinocardiogramma obsoleto) curva che riflette i cambiamenti nel tempo della differenza di potenziale del campo elettrico (biopotenziali) del cuore durante le sue contrazioni... Ampio dizionario medico
- (da Elettro..., Cardio... e... una curva registrata su carta, che riflette le fluttuazioni dei biopotenziali del cuore che batte. Vedi Elettrocardiografia... Grande Enciclopedia Sovietica
G. Registrazione grafica della funzione cardiaca effettuata da un elettrocardiografo. Il dizionario esplicativo di Efraim. T. F. Efremova. 2000... Dizionario esplicativo moderno della lingua russa di Efremova
Elettrocardiogramma, elettrocardiogrammi, elettrocardiogrammi, elettrocardiogrammi, elettrocardiogrammi, elettrocardiogrammi, elettrocardiogrammi, elettrocardiogrammi, elettrocardiogrammi, elettrocardiogrammi, elettrocardiogrammi,... ... Forme delle parole
Libri
- Elettrocardiogramma con pacemaker artificiale, S. Grigorov. La monografia sull'elettrocardiografia presenta dati sulla stimolazione elettrica del cuore, le tecniche utilizzate e le tipologie di stimolatori elettrici. Gli ECG vengono presi in considerazione per il funzionamento di ciascuno...