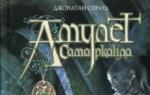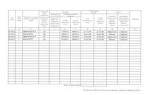Qual è l'elemento principale che costituisce la crosta terrestre? Composizione della crosta terrestre.
Attualmente, la crosta terrestre viene studiata meglio fino a una profondità di 15-20 km. Sulla base dei risultati dell'analisi di numerosi campioni di rocce e minerali venuti alla superficie della terra durante i processi di formazione delle montagne, nonché prelevati da miniere, pozzi profondi e affioramenti, la composizione media degli elementi chimici del è stata calcolata la crosta terrestre.
COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA CROSTA TERRESTRE
Gli elementi più comuni nella crosta terrestre sono 46, di cui 8 costituiscono il 97,2-98,8% della sua massa, 2 (ossigeno e silicio) - il 75% della massa totale della Terra.
La distribuzione degli elementi chimici come percentuale della massa della crosta terrestre (secondo A.E. Fersman) è la seguente:
Ossigeno 49.13
Silicio 26.00
Alluminio 7.45
Ferro 4.20
Calcio 3,25
Sodio 2,40
Magnesio 2,35
Zinco 0,020
Boro 0,010
Rame 0,010
Ittrio 0,005
Berillio 0,003
Cesio 0,0029
I primi 13 elementi (ad eccezione del titanio), più spesso presenti nella crosta terrestre, fanno parte della sostanza organica delle piante, partecipano a tutti i processi vitali e svolgono un ruolo importante nella fertilità del suolo. Un gran numero di elementi che partecipano alle reazioni chimiche nelle viscere della Terra portano alla formazione di un'ampia varietà di composti.
MINERALI
Un minerale è qualsiasi corpo naturale omogeneo presente nella crosta terrestre che ha una composizione chimica più o meno costante e determinate proprietà fisiche.
Minerali e loro formazione. Minerale tradotto dal latino minera significa minerale. Attualmente si conoscono circa 3mila minerali. I minerali presenti in forma solida si dividono in amorfi, ovvero non cristallini (asfalto, ghiaccio, opale) e cristallini (feldspato, cristallo di rocca, gesso). Nei minerali amorfi, gli atomi (ioni) o le molecole sono disposti in modo casuale, nei cristalli, secondo una certa legge che forma la struttura del cristallo o il suo reticolo cristallino. I minerali più comuni presenti in quantità significative nelle rocce sono chiamati minerali che formano le rocce.
A seconda delle condizioni di origine i minerali si dividono in endogeni ed esogeni. I minerali endogeni si formano a seguito di processi fisico-chimici che avvengono nel magma vicino alla superficie terrestre. Un esempio di minerali endogeni possono essere feldspati, olivina, pirosseno, quarzo, ecc. I minerali esogeni si formano nelle parti più superficiali della crosta terrestre o sulla superficie della Terra a seguito dell'erosione (distruzione e trasformazione) dei minerali endogeni. I minerali esogeni si dividono in minerali argillosi, formati durante gli agenti atmosferici (vedi Capitolo III), minerali di precipitazione chimica, formati in piccoli serbatoi contenenti sale durante la cristallizzazione (gesso, solfito, silvinite), e minerali biogenici, formati a seguito della decomposizione di residui organici (nitrato di potassio, zolfo, talvolta pirite, marcasite).
Tutti i minerali sono classificati in base alla loro composizione chimica e sono divisi in cinque tipi, riportati di seguito (secondo E. K. Lazarenko):
1. Tipologia di sostanze semplici (metalli e non metalli, gruppi di rame e ferro, ecc.)
2. Tipologia di solfuri (gruppi sfalerite, galena, molibdeno, ecc.)
3. Tipo di composti dell'ossigeno (ossidi, idrossidi, silicati, alluminosilicati, borati, fosfati, carbonati, solfati, ecc.)
4. Tipologia degli alogeni (fluoruri, cloruri)
5. Tipologia di composti organici
Proprietà fisiche dei minerali. Uno studio dettagliato dei minerali esamina la loro composizione chimica, la disposizione degli atomi, la formazione dei cristalli, la cui forma e proprietà dipendono dai modelli di disposizione di atomi e molecole. In questo caso vengono utilizzati moderni metodi di ricerca chimica, fisica e ottica. Tuttavia, i minerali possono spesso essere identificati sul campo utilizzando otto proprietà fisiche basate sulle proprietà fisiche: colore, colore della striscia, trasparenza, lucentezza, durezza, densità, sfaldatura e frattura.
Il colore dipende dalla composizione chimica e dallo stato fisico dei minerali e può essere molto diverso. Il colore dello stesso minerale è più o meno costante.
Il colore caratteristico - il colore del minerale allo stato frantumato - è solitamente determinato sulla superficie ruvida di una tazza di porcellana. Potrebbe differire dal colore del minerale stesso.
La trasparenza è la capacità di un minerale di trasmettere la luce. Esistono minerali trasparenti (cristallo, calcite), traslucidi, traslucidi (opale) e opachi (augite, limonite, bauxite).
La lucentezza è la capacità di un minerale di riflettere la luce. Esistono metallici (pirite, ferro), vetrosi (quarzo, feldspato), grassi (grafite, talco), setosi (gesso fibroso, amianto), opachi; i minerali terrosi non hanno lucentezza.
Domande: 1. Composizione chimica della crosta terrestre. Minerali, loro origine e distribuzione.
2. Rocce, origine e significato nel processo di formazione del suolo.
1. Composizione chimica della crosta terrestre. Minerali, loro origine e distribuzione.
La crosta terrestre è composta da gruppi di minerali e rocce che differiscono per composizione chimica, origine e condizioni di comparsa. Le rocce sono aggregati costituiti da una specifica combinazione di minerali. Questi ultimi, a loro volta, sono costituiti da atomi e molecole di elementi chimici.
Composizione chimica della crosta terrestre.
Esistono le informazioni più attendibili sulla composizione chimica della crosta terrestre, poiché nella sua parte superiore è accessibile a osservazioni e ricerche dirette. Le prime informazioni sulla composizione chimica di questa parte della crosta terrestre furono pubblicate nel 1889 dallo scienziato americano F. Clark come medie aritmetiche delle 6.000 analisi chimiche di varie rocce a sua disposizione. Negli anni successivi questi valori furono affinati. F. Clark ha dedicato circa 40 anni a questo problema, il suo contributo alla scienza è stato notato dalla comunità scientifica mondiale. A.E. Fersman propose di nominare la percentuale di un elemento nella crosta terrestre Clark di questo elemento (ad esempio clarke aluminium, clarke silicon, ecc.). Tali studi furono condotti all'estero da G.S. Washington, V.M. Goldshmidt, F. Taylor, V. Mason e in Unione Sovietica gli accademici V.I. Vernadsky, A.E. Fersman, A.P. Vinogradov, A.B. Ronov si sono occupati dei problemi della composizione chimica della crosta terrestre, così come eminenti scienziati come V. G. Khlopin, G. V. Voitkevich, A. A. Yaroshevskij. Secondo i dati di A. B. Ronov e A. A. Yaroshevsky (1976), ossigeno, silicio, alluminio, ferro, calcio, magnesio, sodio e potassio sono i più abbondanti nella crosta terrestre. In totale, costituiscono il 98% della crosta terrestre. Inoltre, oltre l'80% è costituito da ossigeno, silicio e alluminio, contrariamente alla composizione media della Terra, dove la quantità totale di questi elementi chimici è nettamente ridotta. Il contenuto di ossigeno e silicio è particolarmente elevato nella crosta terrestre. La tabella 1 dà un'idea generale della composizione della crosta terrestre. 1.
Tabella 1
Presenza (clarks) dei principali elementi chimici nella crosta terrestre fino a una profondità di 16 km
|
secondo F. Clark e G. Washington (1924) |
secondo A.E. Fersmann (1933-1939) |
secondo A.P. Vinogradov |
|
|
Ossigeno | |||
|
Alluminio | |||
Clark: la percentuale di ciascun elemento chimico nella Terra
Nota. AP Vinogradov calcolò il contenuto medio dell'intera crosta terrestre, composta da due parti di rocce acide e una parte di rocce basiche.
Si osservano alcuni schemi nella distribuzione degli elementi chimici nella crosta terrestre: ossigeno, silicio e metalli leggeri predominano nelle parti superficiali; con la profondità, il ruolo del ferro e del magnesio aumenta notevolmente e diminuisce il ruolo dell'alluminio, del calcio e del sodio. Quando si scende più in profondità nella crosta terrestre, aumenta il contenuto di elementi pesanti, in particolare metalli pesanti.
La composizione chimica della crosta terrestre è stata determinata sulla base dei risultati dell'analisi di numerosi campioni di rocce e minerali venuti alla superficie della terra durante i processi di formazione delle montagne, nonché prelevati da miniere e pozzi profondi.
Attualmente la crosta terrestre è stata studiata fino ad una profondità di 15-20 km. È costituito da elementi chimici che fanno parte delle rocce.
Gli elementi più comuni nella crosta terrestre sono 46, di cui 8 costituiscono il 97,2-98,8% della sua massa, 2 (ossigeno e silicio) - il 75% della massa terrestre.
I primi 13 elementi (ad eccezione del titanio), più spesso presenti nella crosta terrestre, fanno parte della sostanza organica delle piante, partecipano a tutti i processi vitali e svolgono un ruolo importante nella fertilità del suolo. Un gran numero di elementi che partecipano alle reazioni chimiche nelle viscere della Terra portano alla formazione di un'ampia varietà di composti. Gli elementi chimici più abbondanti nella litosfera si trovano in molti minerali (da essi sono costituite per lo più rocce diverse).
I singoli elementi chimici sono distribuiti nelle geosfere come segue: ossigeno e idrogeno riempiono l'idrosfera; ossigeno, idrogeno e carbonio costituiscono la base della biosfera; ossigeno, idrogeno, silicio e alluminio sono i principali componenti delle argille e delle sabbie o prodotti del disfacimento (costituiscono principalmente la parte superiore della crosta terrestre).
Gli elementi chimici in natura si trovano in una varietà di composti chiamati minerali. Si tratta di sostanze chimiche omogenee della crosta terrestre che si sono formate a seguito di complessi processi fisico-chimici o biochimici, ad esempio salgemma (NaCl), gesso (CaS04*2H20), ortoclasio (K2Al2Si6016).
In natura gli elementi chimici partecipano in modo diseguale alla formazione dei diversi minerali. Ad esempio, il silicio (Si) è un componente di oltre 600 minerali ed è molto comune anche sotto forma di ossidi. Lo zolfo forma fino a 600 composti, calcio - 300, magnesio -200, manganese - 150, boro - 80, potassio - fino a 75, sono noti solo 10 composti di litio e ancora meno composti di iodio.
Tra i minerali più conosciuti della crosta terrestre predomina un folto gruppo di feldspati con tre elementi principali: K, Na e Ca. Nelle rocce che formano il suolo e nei loro prodotti di alterazione, i feldspati occupano una posizione importante. I feldspati si deteriorano gradualmente (si disintegrano) e arricchiscono il terreno con K, Na, Ca, Mg, Fe e altre sostanze di cenere, nonché microelementi.
Numero di Clark- numeri che esprimono il contenuto medio di elementi chimici nella crosta terrestre, nell'idrosfera, nella Terra, nei corpi cosmici, nei sistemi geochimici o cosmochimici, ecc., in relazione alla massa totale di questo sistema. Espresso in % o g/kg.
Tipi di Clark
Ci sono Clark di peso (%, g/t o g/g) e atomici (% del numero di atomi). Una generalizzazione dei dati sulla composizione chimica delle varie rocce che compongono la crosta terrestre, tenendo conto della loro distribuzione a una profondità di 16 km, fu fatta per la prima volta dallo scienziato americano F. W. Clark (1889). I numeri da lui ottenuti per la percentuale di elementi chimici nella composizione della crosta terrestre, successivamente alquanto perfezionati da A.E. Fersman, su suggerimento di quest'ultimo, furono chiamati numeri di Clark o Clarks.
Struttura della molecola. Le proprietà elettriche, ottiche, magnetiche e altre proprietà delle molecole sono legate alle funzioni d'onda e alle energie dei vari stati delle molecole. Gli spettri molecolari forniscono informazioni sugli stati delle molecole e sulla probabilità di transizione tra di loro.
Le frequenze di vibrazione negli spettri sono determinate dalle masse degli atomi, dalla loro posizione e dalla dinamica delle interazioni interatomiche. Le frequenze negli spettri dipendono dai momenti di inerzia delle molecole, la cui determinazione da dati spettroscopici consente di ottenere valori accurati delle distanze interatomiche nella molecola. Il numero totale di linee e bande nello spettro vibrazionale di una molecola dipende dalla sua simmetria.
Le transizioni elettroniche nelle molecole caratterizzano la struttura dei loro gusci elettronici e lo stato dei legami chimici. Gli spettri delle molecole che hanno un maggior numero di legami sono caratterizzati da bande di assorbimento a onda lunga che cadono nella regione del visibile. Le sostanze costituite da tali molecole sono caratterizzate dal colore; Queste sostanze includono tutti i coloranti organici.
Ioni. Come risultato delle transizioni elettroniche, si formano ioni: atomi o gruppi di atomi in cui il numero di elettroni non è uguale al numero di protoni. Se uno ione contiene più particelle caricate negativamente rispetto a quelle caricate positivamente, tale ione viene chiamato negativo. Altrimenti lo ione si dice positivo. Gli ioni sono molto comuni nelle sostanze; ad esempio, si trovano in tutti i metalli senza eccezioni. Il motivo è che uno o più elettroni di ciascun atomo di metallo vengono separati e si muovono all'interno del metallo, formando quello che viene chiamato gas di elettroni. È a causa della perdita di elettroni, cioè di particelle negative, che gli atomi metallici diventano ioni positivi. Questo vale per i metalli in qualsiasi stato: solido, liquido o gassoso.
Il reticolo cristallino modella la disposizione degli ioni positivi all'interno di un cristallo di una sostanza metallica omogenea.
È noto che allo stato solido tutti i metalli sono cristalli. Gli ioni di tutti i metalli sono disposti in modo ordinato, formando un reticolo cristallino. Nei metalli fusi ed evaporati (gassosi), non esiste una disposizione ordinata degli ioni, ma il gas di elettroni rimane ancora tra gli ioni.
Isotopi- varietà di atomi (e nuclei) di un elemento chimico che hanno lo stesso numero atomico (ordinale), ma allo stesso tempo numeri di massa diversi. Il nome è dovuto al fatto che tutti gli isotopi di un atomo sono collocati nello stesso posto (in una cella) della tavola periodica. Le proprietà chimiche di un atomo dipendono dalla struttura del guscio elettronico, che, a sua volta, è determinato principalmente dalla carica del nucleo Z (cioè dal numero di protoni in esso contenuti) e quasi non dipende dalla sua massa numero A (cioè il numero totale di protoni Z e neutroni N) . Tutti gli isotopi dello stesso elemento hanno la stessa carica nucleare, differendo solo per il numero di neutroni. Tipicamente un isotopo è designato con il simbolo dell'elemento chimico a cui appartiene, con l'aggiunta di un suffisso in alto a sinistra che indica il numero di massa. Puoi anche scrivere il nome dell'elemento seguito da un numero di massa con trattino. Alcuni isotopi hanno nomi propri tradizionali (ad esempio deuterio, actinone).
Il guscio solido più superficiale del nostro pianeta è chiamato crosta terrestre; insieme al mantello superiore forma la litosfera. Il confine tra la crosta e il mantello superiore, chiamato superficie di Mohorovicic, si trova sotto i continenti a una profondità media di circa 50 km, mentre sotto gli oceani la crosta ha uno spessore di soli 5-10 km. La parte superiore della crosta continentale è costituita da una copertura sedimentaria (pedosfera), e il resto del suo spessore è diviso in due strati: granito e basalto (l'interfaccia tra loro è chiamata superficie di Conrad).
La composizione della crosta terrestre si è formata principalmente a seguito del rilascio di sostanze dal mantello superiore terrestre. La composizione di questo guscio si è evoluta nel tempo, principalmente a causa della sublimazione degli elementi del mantello a seguito della fusione parziale ad una profondità di circa 100 km. La profondità della Terra è 6371 km; crosta terrestre ~ 40 km, mantello superiore ~ 40-70 km, mantello inferiore: 700-2900 km; nucleo esterno ~ 2900-5150 km; nucleo interno ~ 5150-6371 km. Oltre il 92% della massa della litosfera è costituito da soli 4 elementi: ferro, ossigeno, silicio e magnesio. La composizione della crosta terrestre risulta essere più arricchita di ossigeno e silicio. Questi elementi, insieme all'alluminio, formano i composti più comuni nella corteccia: silicati e alluminosilicati. Circa il 90% della massa della crosta terrestre è formata da silicati di alluminio, ferro, calcio, magnesio, potassio e sodio, oltre che da ossido di silicio. Il guscio della Terra è spesso< 0,0001 % от объема планеты. Средний химический состав современной коры имеет следующий вид:
O-46,6%; Si - 27,7%; Al - 8,1%; Fe - 5,0%; Ca - 3,6%; Na - 2,8%; K - 2,6%; Mg - 2,1%; altro 1,4%.
Per caratterizzare la prevalenza degli elementi chimici nella crosta terrestre, il famoso geochimico A.E. Fersman ha proposto di introdurre il concetto di Clarke: il valore medio del contenuto relativo di un elemento chimico. Questa quantità prende il nome dal chimico americano che, negli ultimi decenni del XIX secolo, delineò metodi per studiare statisticamente l'abbondanza degli elementi. In un senso più ampio, Clark si riferisce non solo alla crosta terrestre, ma anche ad altri sistemi globali (ad esempio, la vegetazione dei continenti) e spaziali. Le differenze nel Clarke degli elementi chimici sono molto grandi. Convenzionalmente, gli elementi sono divisi in 2 gruppi: principali, con un contenuto di almeno lo 0,1% e sparsi. Gli elementi principali (in ordine decrescente) nella crosta terrestre comprendono i seguenti 10 elementi chimici: O, Si, Al, Fe, K, Ca, Na, Mg, Ti, H. Formano composti chimici indipendenti (minerali) e quelli compreso nel secondo gruppo è prevalentemente disperso in minerali naturali. La particolarità della distribuzione degli oligoelementi nella crosta terrestre risiede nella loro capacità di formare accumuli (depositi) in cui il loro contenuto è centinaia e migliaia di volte superiore al contenuto di clarke. Il contenuto medio di un elemento chimico in traccia in una data regione costituisce il suo background geochimico. Le aree con maggiore concentrazione di un elemento (rispetto a quella regionale) sono chiamate anomalie geochimiche o province geochimiche.
Una componente importante della litosfera sono le acque sotterranee. L'acqua è presente nello spessore terrestre sia in forma libera che legata, nonché in vari stati di aggregazione: sotto forma di vapore, liquida e ghiaccio. Le acque sotterranee sono un complesso sistema fisico e chimico che è in equilibrio dinamico con le rocce ospiti.
Le acque libere dell'idrosfera sotterranea sono mineralizzate in un modo o nell'altro e le più rare (~ 2%) sono le acque dolci. Si tratta principalmente di acque sotterranee direttamente collegate a fonti superficiali (fiumi, laghi, bacini artificiali). La loro mineralizzazione totale non supera 1 g/l (1 ‰) e per composizione sono classificati come idrocarbonati. Di norma, le acque sotterranee sono caratterizzate da un elevato contenuto (fino a 35 mg/l o più) di sostanza organica disciolta. Il volume principale dell'idrosfera sotterranea è costituito da acque salate (fino a 35 g/l) e salate (con mineralizzazione fino a 500-600 g/l). La loro formazione avviene in strati profondi di rocce sedimentarie in zone di lento scambio d'acqua nel corso di centinaia di migliaia e milioni di anni. Nella composizione sono principalmente cloruro. Una posizione intermedia tra le acque dolci (terrena e artesiana) e quelle salate è occupata solitamente dalle acque salmastre con una mineralizzazione fino a 10 g/l. Formano tutte le classi principali: idrocarbonato, cloruro e solfato. Rispetto alle acque sotterranee dolci, l'acqua salmastra contiene meno gas disciolti di origine atmosferica. All'aumentare della profondità della presenza nelle acque sotterranee, aumenta la concentrazione di gas di origine profonda (CO 2, He, CH 4, ecc.).
La crosta terrestre è costantemente esposta a vari tipi di influenze, sia interne (endogene) che esterne (esogene). La forza trainante dei processi endogeni è l'energia interna della Terra. Ad esempio, la lisciviazione microbiologica degli oligoelementi avviene non solo attraverso l'ossidazione, ma anche durante la riduzione dei minerali ossidati. Vi prendono parte vari microrganismi. In particolare, la riduzione di Fe 3+ a Fe 2+ e di Mn 4+ a Mn 2+ viene effettuata da batteri dei generi Bacillus e Pseudomonas. I processi esogeni si verificano sulla superficie terrestre o a basse profondità nella crosta terrestre e sono causati da forze esterne: l'energia della radiazione solare, le forze gravitazionali, il movimento dell'acqua e del ghiaccio e l'attività vitale degli organismi. L'attività umana è ormai diventata un potente fattore esogeno che influenza la crosta terrestre. Se prima della seconda metà del XX secolo. Il sottosuolo veniva utilizzato quasi esclusivamente per l'estrazione mineraria e l'approvvigionamento di acqua potabile, ma ora vi vengono creati impianti di stoccaggio di petrolio e gas e vengono sepolti i rifiuti dell'industria chimica e nucleare. Le esplosioni nucleari sotterranee hanno un'influenza particolarmente forte sui processi geodinamici e idrologici.
Le informazioni più attendibili sulla composizione chimica della crosta terrestre riguardano la sua parte continentale. Quando si calcola la composizione chimica della crosta terrestre, viene presa una certa proporzione di materiale acido (granito) e basico (basaltico). AP Vinogradov nel 1962 riteneva che molto probabilmente la crosta terrestre fosse una miscela di rocce acide e basiche in un rapporto 2:1. A.B. Ronov e A.A. Yaroshevskij calcolò questo rapporto approssimativamente come 4:1, A.A. Poldervat nel 1955 ipotizzò che questo rapporto fosse 1:1. Dai dati presentati ne consegue che i calcoli della composizione della crosta terrestre sono approssimativi. La composizione chimica media della crosta terrestre è la sua importante caratteristica chimica, necessaria per chiarire una serie di processi geochimici globali. Il materiale della crosta terrestre è stato rilasciato dal mantello a seguito della fusione, del degasaggio e della rimozione di questi prodotti verso gli orizzonti superiori del pianeta (Tabella 1).
Tabella 1. Composizione chimica della crosta terrestre secondo A.B. Ronov e A.A. Yaroshevskij, 1976 (in media, %)
Brevi caratteristiche delle rocce
In base alla loro origine le rocce si dividono in 3 grandi gruppi:
1. Igneo (igneo), sorto quando il magma, uno speciale silicato fuso saturo di gas, si solidificò sulla superficie o nelle profondità della crosta terrestre.
2. Sedimentario, formato dalla deposizione di sostanze inorganiche e organiche sul fondo di vari corpi idrici e sulla superficie dei continenti.
3. Metamorfico, apparso nel processo di cambiamento (ricristallizzazione) di rocce sedimentarie e ignee sotto l'influenza di temperature e pressioni elevate.
Le rocce ignee includono (%): granito (SiO 2 ~ 71, Al 2 O 3 ~ 14-15, Na 2 O ~ 3,3, K 2 O ~ 4,0, Fe 2 O 3 + Fe ~ 3,5, il resto: H 2 O , CaO, TiO 2, MgO);
Basalto (SiO 2 ~ 49, Al 2 O 3 ~ 18, Fe 2 O 3 + Fe ~ 9, CaO ~ 11, MgO ~ 8, il resto: H 2 O, TiO 2, Na 2 O, K 2 O).
Le rocce sedimentarie includono (%): a) argilla (SiO 2 ~ 62; Al 2 O 3 ~ 17; H 2 O ~ 5; Fe 2 O 3 + Fe ~ 5, il resto: CaO, TiO 2, MgO, K 2 O, Na2O, CO2);
b) arenaria (SiO 2 ~ 94; Al 2 O 3 ~ 1,1; CaO ~ 1,1; il resto: Na 2 O 3 ; K 2 O; Fe 2 O 3 + Fe; H 2 O, TiO 2, MgO ).
c) calcare (SiO 2 ~ 5; CaO ~ 43; CO 2 ~ 42; resto: fino al 100%).
Rocce metamorfiche (%): a) anfiboliti (SiO 2 ~ 50; Al 2 O 3 ~ 17; MgO ~ 7; CaO ~ 9; Fe 2 O 3 + Fe ~ 10; tutti gli altri composti - fino al 100%);
b) ardesia (SiO 2 ~ 63; Al 2 O 3 ~ 18; Fe 2 O 3 + Fe ~ 6; CaO ~ 2; Fe 2 O 3 + Fe ~ 6; K 2 O ~ 3; H 2 O ~ 2, 5; tutte le altre connessioni - fino al 100%).
Le rocce come associazioni naturali di minerali hanno una serie di proprietà fisiche, la cui conoscenza è necessaria per risolvere molti problemi: densità, conduttività termica, radioattività naturale*, proprietà elettriche (resistività elettrica, polarizzabilità, costante dielettrica, attività elettrochimica), proprietà magnetiche ( suscettività magnetica, magnetizzazione indotta, magnetizzazione residua, magnetizzazione residua naturale), proprietà elastiche e fisico-meccaniche (velocità di propagazione delle onde sismiche longitudinali e trasversali, moduli elastici dinamici, moduli di deformazione e taglio).
* - la radioattività naturale delle rocce è determinata dal decadimento spontaneo (incontrollato) degli isotopi radioattivi in esse concentrati. I principali e più comuni sono: 232 Th, 235 U, 238 U, 40 K. La radioattività si manifesta nell'emissione di particelle b, b e fotoni g.
Nella biosfera del nostro pianeta esistono varie forme di movimento della materia, interconnesse tra loro. Subisce un massiccio trasferimento di masse solide, liquide e gassose sotto l'influenza dell'energia dei raggi solari e dell'energia interna del pianeta, associata principalmente al decadimento radioattivo e al rilascio di energia atomica.
L'idea di una grande circolazione di materia negli orizzonti superiori della Terra, come dottrina dei grandi cicli geologici, fu sviluppata nella sua interezza da V.I. Vernadsky e chiamò questi cicli geochimici. Il ciclo su larga scala è il processo di formazione delle rocce ignee, che sorgono durante la solidificazione del magma che entra nella litosfera dalle profondità della Terra. Sulla superficie della crosta terrestre, il materiale delle rocce ignee subisce la distruzione, gli agenti atmosferici e passa naturalmente in uno stato mobile. I prodotti della distruzione vengono trasportati dagli agenti geologici (acqua, vento) nelle parti inferiori del rilievo (denudazione) e quindi nei corpi idrici. Pertanto, nel corso del tempo geologico, le rocce sedimentarie scendono a grandi profondità, dove subiscono metamorfismo e si fondono nuovamente in magma. Quest'ultimo, in condizioni geologiche favorevoli, può nuovamente entrare negli strati superiori della litosfera, dove solidifica sotto forma di rocce diverse. Pertanto, in enormi intervalli di tempo geologico, si verifica un ciclo globale della materia: roccia ignea - roccia sedimentaria - roccia metamorfica - magma. Le varie sezioni della crosta terrestre che osserviamo sulla superficie del globo sono essenzialmente anelli di questo ciclo.
Un tratto caratteristico dell'evoluzione della Terra è la differenziazione della materia, la cui espressione è la struttura a guscio del nostro pianeta. La litosfera, l'idrosfera, l'atmosfera, la biosfera formano i principali gusci della Terra, differendo per composizione chimica, spessore e stato della materia.
Struttura interna della Terra
Composizione chimica della Terra(Fig. 1) è simile alla composizione di altri pianeti terrestri, come Venere o Marte.
In generale predominano elementi come ferro, ossigeno, silicio, magnesio e nichel. Il contenuto di elementi leggeri è basso. La densità media della sostanza terrestre è di 5,5 g/cm 3 .
Esistono pochissimi dati affidabili sulla struttura interna della Terra. Diamo un'occhiata alla Fig. 2. Rappresenta la struttura interna della Terra. La Terra è costituita dalla crosta, dal mantello e dal nucleo.
Riso. 1. Composizione chimica della Terra

Riso. 2. Struttura interna della Terra
Nucleo
Nucleo(Fig. 3) si trova al centro della Terra, il suo raggio è di circa 3,5 mila km. La temperatura del nucleo raggiunge i 10.000 K, cioè è superiore alla temperatura degli strati esterni del Sole, e la sua densità è di 13 g/cm 3 (confronta: acqua - 1 g/cm 3). Si ritiene che il nucleo sia composto da leghe di ferro e nichel.
Il nucleo esterno della Terra ha uno spessore maggiore del nucleo interno (raggio 2200 km) ed è allo stato liquido (fuso). Il nucleo interno è soggetto ad un'enorme pressione. Le sostanze che lo compongono sono allo stato solido.
Mantello
Mantello- la geosfera terrestre, che circonda il nucleo e costituisce l’83% del volume del nostro pianeta (vedi Fig. 3). Il suo limite inferiore si trova ad una profondità di 2900 km. Il mantello è suddiviso in una parte superiore meno densa e plastica (800-900 km), da cui è formato magma(tradotto dal greco significa "unguento denso"; questa è la sostanza fusa dell'interno della terra - una miscela di composti ed elementi chimici, compresi i gas, in uno speciale stato semiliquido); e quello cristallino inferiore, spesso circa 2000 km.

Riso. 3. Struttura della Terra: nucleo, mantello e crosta
la crosta terrestre
La crosta terrestre - il guscio esterno della litosfera (vedi Fig. 3). La sua densità è circa due volte inferiore alla densità media della Terra - 3 g/cm 3 .
Separa la crosta terrestre dal mantello Confine di Mohorovicic(spesso chiamato confine di Moho), caratterizzato da un forte aumento della velocità delle onde sismiche. È stato installato nel 1909 da uno scienziato croato Andrej Mohorovicic (1857- 1936).
Poiché i processi che avvengono nella parte più alta del mantello influenzano i movimenti della materia nella crosta terrestre, essi vengono riuniti sotto il nome generale litosfera(guscio di pietra). Lo spessore della litosfera varia da 50 a 200 km.
Sotto si trova la litosfera astenosfera- guscio meno duro e meno viscoso, ma più plastico con una temperatura di 1200°C. Può oltrepassare il confine di Moho, penetrando nella crosta terrestre. L'astenosfera è la fonte del vulcanismo. Contiene sacche di magma fuso, che penetra nella crosta terrestre o si riversa sulla superficie terrestre.
Composizione e struttura della crosta terrestre
Rispetto al mantello e al nucleo, la crosta terrestre è uno strato molto sottile, duro e fragile. È composto da una sostanza più leggera, che attualmente contiene circa 90 elementi chimici naturali. Questi elementi non sono ugualmente rappresentati nella crosta terrestre. Sette elementi - ossigeno, alluminio, ferro, calcio, sodio, potassio e magnesio - rappresentano il 98% della massa della crosta terrestre (vedi Fig. 5).
Combinazioni particolari di elementi chimici formano varie rocce e minerali. I più antichi hanno almeno 4,5 miliardi di anni.

Riso. 4. Struttura della crosta terrestre

Riso. 5. Composizione della crosta terrestre
Mineraleè un corpo naturale relativamente omogeneo nella sua composizione e proprietà, formato sia nelle profondità che sulla superficie della litosfera. Esempi di minerali sono il diamante, il quarzo, il gesso, il talco, ecc. (Troverai le caratteristiche delle proprietà fisiche di vari minerali nell'Appendice 2.) La composizione dei minerali della Terra è mostrata in Fig. 6.

Riso. 6. Composizione minerale generale della Terra
Rocce sono costituiti da minerali. Possono essere composti da uno o più minerali.
Rocce sedimentarie - argilla, calcare, gesso, arenaria, ecc. - si sono formati dalla precipitazione di sostanze nell'ambiente acquatico e sulla terra. Si trovano a strati. I geologi le chiamano pagine della storia della Terra, poiché consentono di conoscere le condizioni naturali che esistevano sul nostro pianeta nei tempi antichi.
Tra le rocce sedimentarie si distinguono quelle organogene e inorganogene (clastiche e chemogene).
Organogenico Le rocce si formano a seguito dell'accumulo di resti animali e vegetali.
Rocce clastiche si formano a seguito degli agenti atmosferici, della distruzione da parte dell'acqua, del ghiaccio o del vento dei prodotti della distruzione delle rocce precedentemente formate (Tabella 1).
Tabella 1. Rocce clastiche a seconda della dimensione dei frammenti
|
Nome della razza |
Dimensione del bummer con (particelle) |
|
Più di 50 cm |
|
|
5 mm - 1 cm |
|
|
1 mm - 5 mm |
|
|
Sabbia e arenarie |
0,005 mm - 1 mm |
|
Meno di 0,005 mm |
Chemogenico Le rocce si formano a seguito della precipitazione delle sostanze in esse disciolte dalle acque dei mari e dei laghi.
Nello spessore della crosta terrestre si forma il magma rocce ignee(Fig. 7), ad esempio granito e basalto.
Le rocce sedimentarie ed ignee, quando immerse a grandi profondità sotto l'influenza della pressione e delle alte temperature, subiscono cambiamenti significativi, trasformandosi in rocce metamorfiche. Ad esempio, il calcare si trasforma in marmo, l'arenaria di quarzo in quarzite.
La struttura della crosta terrestre è divisa in tre strati: sedimentario, granitico e basalto.
Strato sedimentario(vedi Fig. 8) è formato principalmente da rocce sedimentarie. Qui predominano argille e scisti e sono ampiamente rappresentate rocce sabbiose, carbonatiche e vulcaniche. Nello strato sedimentario ci sono depositi di questo tipo minerale, come carbone, gas, petrolio. Sono tutti di origine biologica. Il carbone, ad esempio, è un prodotto della trasformazione di piante antichissime. Lo spessore dello strato sedimentario varia ampiamente: dalla completa assenza in alcune aree terrestri a 20-25 km nelle depressioni profonde.

Riso. 7. Classificazione delle rocce per origine
Strato "granito".è costituito da rocce metamorfiche ed ignee, simili nelle loro proprietà al granito. I più comuni qui sono gli gneiss, i graniti, gli scisti cristallini, ecc. Lo strato granitico non si trova ovunque, ma nei continenti dove è ben espresso, il suo spessore massimo può raggiungere diverse decine di chilometri.
Strato "basalto". formato da rocce vicine ai basalti. Si tratta di rocce ignee metamorfizzate, più dense delle rocce dello strato “granito”.
Lo spessore e la struttura verticale della crosta terrestre sono diversi. Esistono diversi tipi di crosta terrestre (Fig. 8). Secondo la classificazione più semplice si distingue tra crosta oceanica e crosta continentale.
La crosta continentale e quella oceanica variano in spessore. Pertanto, lo spessore massimo della crosta terrestre si osserva sotto i sistemi montuosi. Sono circa 70 km. Sotto le pianure lo spessore della crosta terrestre è di 30-40 km, mentre sotto gli oceani è più sottile: solo 5-10 km.

Riso. 8. Tipi di crosta terrestre: 1 - acqua; 2- strato sedimentario; 3—interstrato di rocce sedimentarie e basalti; 4 - basalti e rocce cristalline ultrabasiche; 5 – strato granitico-metamorfico; 6 – strato granulito-mafico; 7 - mantello normale; 8 - mantello decompresso
La differenza tra la crosta continentale e quella oceanica nella composizione delle rocce si manifesta nel fatto che nella crosta oceanica non è presente uno strato di granito. E lo strato basaltico della crosta oceanica è davvero unico. In termini di composizione rocciosa, differisce da uno strato simile di crosta continentale.
Il confine tra terra e oceano (segno zero) non registra la transizione della crosta continentale a quella oceanica. La sostituzione della crosta continentale con quella oceanica avviene nell'oceano ad una profondità di circa 2450 m.

Riso. 9. Struttura della crosta continentale e oceanica
Esistono anche tipi transitori della crosta terrestre: suboceanica e subcontinentale.
Crosta suboceanica localizzati lungo le pendici continentali e pedemontane, si possono trovare nei mari marginali e nel Mediterraneo. Rappresenta la crosta continentale con uno spessore fino a 15-20 km.
Crosta subcontinentale situato, ad esempio, sugli archi di isole vulcaniche.
Basato sui materiali sondaggio sismico - la velocità di passaggio delle onde sismiche: otteniamo dati sulla struttura profonda della crosta terrestre. Pertanto, il pozzo superprofondo di Kola, che per la prima volta ha permesso di vedere campioni di roccia da una profondità di oltre 12 km, ha portato molte cose inaspettate. Si presumeva che a una profondità di 7 km dovesse iniziare uno strato di “basalto”. In realtà non è stato scoperto e tra le rocce predominava lo gneiss.
Variazione della temperatura della crosta terrestre con la profondità. Lo strato superficiale della crosta terrestre ha una temperatura determinata dal calore solare. Questo strato eliometrico(dal greco helio - Sole), sperimentando fluttuazioni stagionali della temperatura. Il suo spessore medio è di circa 30 m.
Di seguito è riportato uno strato ancora più sottile, la cui caratteristica è una temperatura costante corrispondente alla temperatura media annuale del sito di osservazione. La profondità di questo strato aumenta nei climi continentali.
Ancora più in profondità nella crosta terrestre si trova uno strato geotermico, la cui temperatura è determinata dal calore interno della Terra e aumenta con la profondità.
L'aumento della temperatura avviene principalmente a causa del decadimento degli elementi radioattivi che compongono le rocce, in primis radio e uranio.
Viene chiamata la quantità di aumento della temperatura nelle rocce con profondità gradiente geotermico. Varia in un intervallo abbastanza ampio - da 0,1 a 0,01 °C/m - e dipende dalla composizione delle rocce, dalle condizioni in cui si trovano e da una serie di altri fattori. Sotto gli oceani la temperatura aumenta più velocemente con la profondità che nei continenti. In media, ogni 100 m di profondità diventa più caldo di 3 °C.
Si chiama il reciproco del gradiente geotermico fase geotermica. Si misura in m/°C.
Il calore della crosta terrestre è un'importante fonte di energia.
La parte della crosta terrestre che si estende a profondità accessibili alle forme di studio geologico viscere della terra. L'interno della Terra richiede una protezione speciale e un uso saggio.