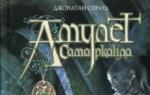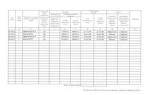Formazione della personalità nell'ontogenesi. Ontogenesi della personalità: forze motrici e condizioni per lo sviluppo della personalità
L’idea dello sviluppo personale entusiasma e rinvigorisce l’educazione russa, i suoi teorici e praticanti da più di due secoli, continuando a subire molteplici trasformazioni. Fu la Russia, più di ogni altro paese, ad essere ossessionata dall’idea di una personalità olistica, che divenne universalmente pervasiva solo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Migrò dalla letteratura e dall'arte alla scienza, in particolare alla filosofia, alla sociologia, alla psicologia e alla pedagogia. Ciò ha portato alla formulazione di compiti per uno studio completo e multilaterale della personalità (N.A. Berdyaev, S. Bulgakov, N.Ya. Grot, K.D. Kavelin, L.P. Karsavin, A.F. Losev, N.K. Mikhailovsky , L. I. Petrazhitsky, D. Roberti, V. V. Rozanov , V. S. Soloviev, P. A. Sorokin, M. M. Troitsky, O. P. Florensky, S. L. Frank, P. Ya Chaadaev, G.I. Chelpanov, L.A. Shestov, E.V. Ilyenkov, M.K. Mamardashvili).
La personalità - olistica, armoniosa, sviluppata in modo completo - era l'ideale dei nostri compatrioti. La vedevano come una forza capace di far uscire il Paese dalla situazione di stallo in cui era rimasto per troppo tempo. Le conoscenze acquisite sulla personalità furono principalmente il frutto di ragionamenti speculativi, ma aprirono la strada a ricerche più accurate, specifiche e sperimentali. L'idea di personalità non era una malattia della filosofia e della psicologia russa. Non è un'orfana senza famiglia e senza tribù. Le sue costruzioni ipotetiche erano molto russe, vicine al suo spirito popolare, alla sua mentalità, alle sue ricerche teoriche e ideologiche.
In questo lavoro che stiamo portando avanti bersaglio: considerare le fasi dello sviluppo della personalità nell'ontogenesi sulla base di un'analisi della letteratura psicologica
Oggetto La ricerca di questo lavoro è la psicologia della personalità
Soggetto la ricerca ha identificato le fasi di formazione dei tratti della personalità
Compiti le opere sono:
Ampliare la comprensione della personalità in psicologia
Condurre un'analisi delle fasi storiche dello studio della personalità in Russia
Determinare l'importanza del fattore sociale nello sviluppo della personalità
Eseguire una periodizzazione dello sviluppo della personalità sulla base di un'analisi di dati teorici e pratici tratti dalla letteratura psicologica
Individuare i momenti di crisi nello sviluppo della personalità
In psicologia esistono diversi approcci per comprendere la personalità.
1. Una personalità può essere descritta in termini di motivazioni e aspirazioni, che costituiscono il contenuto del suo "mondo personale", cioè un sistema unico di significati personali, modi individualmente unici di organizzare impressioni esterne ed esperienze interne.
2. La personalità è considerata come un sistema di tratti - caratteristiche dell'individualità relativamente stabili, manifestate esternamente, che sono impresse nei giudizi del soggetto su se stesso, così come nei giudizi di altre persone su di lui.
3. La personalità è anche descritta come l'io attivo del soggetto, come un sistema di piani, relazioni, orientamento e formazioni semantiche che regolano l'uscita del suo comportamento oltre i limiti dei piani iniziali.
4. La personalità è anche considerata un oggetto di personalizzazione, cioè i bisogni e le capacità dell'individuo di provocare cambiamenti in altre persone.
Una personalità è una persona che ha la propria posizione nella vita, alla quale è arrivata come risultato di molto lavoro cosciente. Una persona del genere non si distingue semplicemente per l'impressione che fa su un altro; si distingue consapevolmente da ciò che lo circonda. Mostra indipendenza di pensiero, sentimenti non banali, una sorta di compostezza e passione interiore. La profondità e la ricchezza di una personalità presuppongono la profondità e la ricchezza delle sue connessioni con il mondo, con le altre persone; la rottura di questi legami e l'autoisolamento la devastano. Una persona è solo una persona che si relaziona in un certo modo con l'ambiente, stabilisce consapevolmente questo atteggiamento in modo che si manifesti in tutto il suo essere.
La personalità è una formazione specificamente umana che è “prodotta” dalle relazioni sociali in cui l'individuo entra nelle sue attività. Il fatto che allo stesso tempo alcune delle sue caratteristiche individuali cambino non è la causa, ma la conseguenza della formazione della sua personalità. La formazione della personalità è un processo che non coincide direttamente con il processo della vita, cambiamenti naturalmente in corso nelle proprietà naturali di un individuo nel corso del suo adattamento all'ambiente esterno.
La personalità è un individuo socializzato, considerato dal punto di vista delle sue proprietà socialmente significative più significative. La personalità è una particella della società così propositiva e auto-organizzante, la cui funzione principale è l'implementazione di un modo individuale di esistenza sociale.
Le funzioni del regolatore del comportamento di una persona sono eseguite dalla sua visione del mondo, orientamento, carattere e abilità.
La personalità non è solo propositiva, ma anche un sistema auto-organizzante. L'oggetto della sua attenzione e attività non è solo il mondo esterno, ma anche se stessa, che si manifesta nel senso di "io", che include idee su se stessa e autostima, programmi di auto-miglioramento, reazioni abituali alla manifestazione di alcune delle sue qualità, la capacità di introspezione, introspezione e autoregolamentazione.
Cosa significa essere una persona? Essere una persona significa avere una posizione di vita attiva, di cui possiamo dire questo: sto su questo e non posso fare altrimenti. Essere un individuo significa fare scelte che nascono per necessità interne, valutare le conseguenze della decisione presa e renderne conto a se stessi e alla società in cui si vive. Essere un individuo significa costruire costantemente se stessi e gli altri, possedere un arsenale di tecniche e mezzi con cui padroneggiare il proprio comportamento e subordinarlo al proprio potere. Essere persona significa avere libertà di scelta e portarne il peso per tutta la vita.
In psicologia ci sono molti tentativi di identificare il nucleo della personalità. Gli approcci disponibili possono essere sistematizzati come segue.
1. Separazione essenziale dei concetti di “uomo”, “individuo”, “soggetto di attività”, “individualità” (nel senso di unicità di ogni persona) e “personalità”. Di conseguenza, il concetto di “personalità” non può essere ridotto ai concetti di “uomo”, “individuo”, “soggetto”, “individualità”, sebbene, d’altro canto, personalità sia allo stesso tempo persona, individuo, soggetto, e individualità, ma solo nella misura, dal lato che caratterizza tutti questi concetti dal punto di vista del coinvolgimento di una persona nelle relazioni sociali.
2. È necessario distinguere tra una comprensione “ampia” della personalità, quando la personalità è identificata con il concetto di persona, e una comprensione “di punta”, quando la personalità è considerata come un livello speciale di sviluppo sociale umano.
3. Esistono diversi punti di vista sul rapporto tra sviluppo biologico e sviluppo sociale dell'individuo. Alcuni includono l'organizzazione biologica di una persona nel concetto di personalità. Altri considerano il biologico come condizioni date per lo sviluppo della personalità, che non determinano i suoi tratti psicologici, ma agiscono solo come forme e metodi della loro manifestazione (A.N. Leontyev).
4. Le persone non nascono con una personalità, diventano una personalità; la personalità si forma relativamente tardi nell'ontogenesi.
5. La personalità non è un risultato passivo dell'influenza esterna su un bambino, ma si sviluppa nel processo della sua stessa attività.
L’idea dello sviluppo della personalità contiene un profondo patrimonio genetico teorico che fino ad oggi non è stato adeguatamente apprezzato. Tuttavia, rivela una chiara tendenza alla germinazione nelle moderne teorie psicologiche della personalità non solo in Russia, ma anche nel mondo. La genesi del concetto di personalità ha origini uniche, determinate dalle peculiarità dello sviluppo storico della Russia.
L'idea di personalità era profondamente inscritta nel thesaurus filosofico e psicologico e nei problemi filosofici e psicologici e si basava su una serie di postulati del cristianesimo. Fu il cristianesimo a diventare la base della tradizione personalistica europea, in cui l'individuo è interpretato come una sorta di santuario, come un assoluto, contenente le sembianze di un “creatore”.
Gli scienziati russi, dopo aver definito il loro atteggiamento nei confronti dell'uomo e della vita, hanno creato la propria comprensione originale delle questioni personali. Nello sviluppo dell'idea di personalità si possono distinguere almeno cinque fondamenti: spirituale e filosofico, scienze naturali, sociologico, artistico ed estetico e psicologico stesso. L'influenza di ciascuno di essi è stata specifica e multidirezionale. È difficile classificarli in base al loro contributo alla teoria della personalità e attribuirle chiaramente la misura del merito. È anche impossibile definire uno di questi modelli il più corretto o il più prezioso. Con ogni probabilità, ogni strato era necessario.
L'idea della personalità e della sua soggettività ha percorso un percorso difficile dal suo inizio fino al momento del riconoscimento del suo status ufficiale. Una serie di idee riguardanti lo studio dello sviluppo della personalità, proclamate oggi come nuove, furono al centro dell'attenzione di eminenti insegnanti e scienziati della seconda metà del XIX - inizio XX secolo. (P.F. Lesgaft, N.I. Pirogov, K.D. Ushinsky, V.N. Bekhterev, I.A. Sikorsky, A.P. Nechaev, P.F. Kapterev e molti altri). Le loro opere riflettevano le tradizioni umanistiche nell'approccio all'uomo e alla sua educazione, proclamavano gli alti ideali morali di bontà e giustizia caratteristici della mentalità russa e formulavano anche inviti a dare un contributo fattibile allo sviluppo della cultura umana.
In Russia nella seconda metà del XIX secolo. Due direzioni nello studio dell'uomo furono chiaramente identificate. Il primo era associato alla comprensione scientifica naturale dell'uomo (N.G. Chernyshevsky, N.A. Dobrolyubov, D.I. Pisarev, M.A. Bakunin, I.M. Sechenov, ecc.), il secondo - con le tradizioni dell'idealismo russo (K R. D. Kavelin, V. S. Solovyov, L. I. Shestov , N. Ya. Grot, M. M. Troitsky, S. L. Frank, L. P. Karsavin, N. A. Berdyaev, A. F. Losev, N.O. Lossky, A.I. Vvedensky, ecc.). Nei successivi cento anni, infatti, queste due direzioni furono in opposizione.
Nella psicologia della personalità si è diffusa una divisione in descrizioni “oggettive” e “soggettive” di una persona. A poco a poco, ai determinanti sociali della personalità fu data la preferenza rispetto ai determinanti naturali (organismi). I concetti basati sullo schema “organismo-ambiente” sono diventati per molto tempo preferiti, e in alcuni casi anche gli unici.
Possiamo distinguere quattro modi storicamente stabiliti dell'esistenza dell'idea di personalità, quattro tipi di costruzione della conoscenza scientifica sulla personalità, cioè possiamo tipologiezzare i fatti della sua dinamica storica. Storicamente primo tipo La costruzione della psicologia della personalità è emersa tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. (ultimo decennio del XIX – anni ’20 del XX secolo). È stato determinato dalla logica dell'autodeterminazione dell'idea di personalità ed è diventato possibile grazie al fatto che il “personale” ha acquisito lo status di socialmente approvato e sostenuto. Per questo periodo, la cosa più significativa è stata l'emergere dell'idea stessa di personalità. La trasformazione di una persona in una personalità era considerata un modello ideale, come un risultato dello sviluppo socialmente desiderabile.
Questo periodo di esistenza dell'idea di personalità si è riflesso nell'esperienza di costruzione di concetti psicologici olistici di personalità, combinando aspetti filosofici e psicologici specifici. All'inizio del XX secolo. si è tentato di far rivivere l'idea perduta di integrità personale e di sollevare il tema dell'esistenza umana nel mondo. Il desiderio di proporre questioni generali di interazione tra uomo e cultura, a partire dalla metà degli anni '20, fu intrapreso da M.M. Bachtin, che ha cercato di comprendere l'esistenza umana nelle coordinate di una certa situazione storica e culturale. Le sue ricerche erano prevalentemente di natura antropologica.
Antropologia e ontologia etica M.M. Bachtin rimase a lungo non reclamato e inutilizzato. E solo nei moderni concetti di personalità troviamo un riflesso delle sue idee.
Il punto di partenza della sua teoria era la tesi sull'unicità di ogni persona. Il posto unico dell'uomo nel mondo presuppone la presenza di un certo obbligo, che consiste nell'esigenza di tradurre in realtà il suo “eccesso di visione”. Seguendo M.M. Bachtin, ogni persona è dotata del proprio “eccesso di visione”, che si rivela solo a lui, dal suo unico posto nell'essere. In questo, secondo M.M. Bachtin, e questo è lo scopo dell'uomo: riconoscere la sua unicità e realizzarla attraverso un atto responsabile (M.M. Bakhtin, 1979).
Storico secondo tipo la costruzione della psicologia della personalità (negli anni '30 -'60 del XX secolo) è stata determinata dalla logica di preservare l'idea di personalità nello scontro con la società, che ha distrutto il “personale” in una persona, passando attraverso i filtri della la lotta contro il cosmopolitismo e le influenze aliene. La strategia emergente della “lotta” per l’idea della personalità con un “nemico esterno” rifletteva in realtà la lotta contro l’idea della personalità in quanto tale, poiché lo studio reale del fenomeno della “personalità” veniva sostituito da un “immagine della personalità” sostitutiva e attivamente accettata, adattata secondo i disegni e gli schizzi dell’ideologia dominante.
L'idea di personalità, sviluppata in questi anni, appare nelle sue forme trasformate: nelle manifestazioni di riduzionismo politico-ideologico (nel proporre slogan invece di chiarirne l'essenza, nella ricerca di segni di una “persona sovietica”, nella costruzione di un “Mentalità sovietica”); nelle manifestazioni del riduzionismo fisiologico. Principio personale difeso e attuato da B.G. Ananyev, S.L. Rubinstein, K.K. Platonov acquisì gradualmente (con tutta la sua dichiaratività) il carattere di una tradizione.
L'idea di integrare la conoscenza sull'uomo ha permeato le opere di B.G. Ananyev, che si rappresentava in psicologia proprio come l'autore di idee versatili sulla conoscenza umana, sulla loro complessa soluzione, integrazione e sintesi. Le sue opere forniscono una descrizione dettagliata dei concetti di "individuo", "personalità", "oggetto di attività", che ha permesso di concludere che i tratti della personalità si sviluppano durante tutto il percorso di vita di una persona nella società, creando la sua biografia.
Terzo periodo– metà anni ’60 – fine anni ’80 del XX secolo. Questo è il periodo di creazione del concetto di "nuovo uomo sovietico", la cui necessità era determinata dall'ordine ideologico del partito al potere: il PCUS. Questo periodo di costruzione della psicologia della personalità è caratterizzato dalla logica del “rinascita” dell'idea di personalità in una situazione di atteggiamento ambivalente della società nei confronti del “personale” in una persona.
Durante tutti gli anni del periodo sovietico, l’idea dell’“uomo nuovo”, l’idea della sua esclusività ed esemplarità, fu attentamente sviluppata. Ciò non è casuale, poiché ovunque trionfasse il totalitarismo, l'idea di una superiorità assoluta, esemplare e standardizzata occupava un posto di primo piano nel sistema di valori proclamati.
LA. Radzikhovsky notò sarcasticamente che, secondo questa idea, una persona "ha cambiato la sua pelle, temperata come l'acciaio, sollevata come terra vergine, cioè riforgiata, fusa, rieducata". Questa era l'essenza e lo scopo della "psicoterapia totalitaria", che aveva come obiettivo la rieducazione dell'individuo e utilizzava a questo scopo vari meccanismi psicologici.
Entro la fine degli anni '60, molti dei risultati degli scienziati nazionali nel campo della psicologia della personalità furono radicalmente trasformati e completamente persi. Questa idea è stata confermata da B.G. Ananyev, il quale credeva che “il campo della psicologia della personalità nel suo stato attuale rappresenta una formazione molto vaga nella struttura della scienza psicologica”.
Gli psicologi degli anni '60 e '70 del XX secolo, seguendo B.G. Ananyev e S.L. Rubinstein, iniziò la ricerca delle caratteristiche soggettive della personalità. Il “soggettivo” nella personalità è diventato ancora una volta una cosa desiderabile da considerare, coltivare e amare.
Gli studi sperimentali sullo sviluppo della personalità si sono sviluppati ampiamente nella psicologia russa solo a partire dagli anni '70 e '80 del XX secolo (L.I. Bozhovich, A.V. Petrovsky, B.S. Bratus, V.A. Petrovsky, A.I. Lipkina, V.S. Merlin, V.S. Mukhina e molti altri). Tuttavia, il compito di studiare i modelli, le forze trainanti e i meccanismi dello sviluppo della personalità nelle varie fasi dello sviluppo ontogenetico è stato formulato molto prima da M.M. Troitsky, L.S. Vygotskij, B.G. Ananyev, S.L. Rubinstein, A.V. Zaporozhets, A.N. Leontiev, D.B. Elkonin e altri. Le loro idee hanno costituito la base della ricerca che ha permesso di identificare il ritmo, il ritmo, il contenuto e l'originalità qualitativa delle formazioni emergenti della personalità in determinati periodi di età. È diventato chiaro che ogni età fornisce il proprio contributo parziale al corso dello sviluppo della personalità, che la sensibilità di ciascun periodo è qualitativamente unica ed è determinata dalla natura dei prerequisiti genetici naturali, dalle caratteristiche dell'attività vitale e dalle capacità mentali raggiunte.
È stato riscontrato che le dinamiche dei cambiamenti legate all'età avvengono nella direzione dell'integrazione, della crescita della complessità cognitiva, della differenziazione e dell'ambiguità delle valutazioni, delle descrizioni e delle immagini, della crescita del numero e della generalità delle qualità percepite e dell'arricchimento del vocabolario psicologico. I cambiamenti nello sviluppo della personalità sono stati a lungo interpretati e ridotti solo a cambiamenti nella coscienza, nell’autoconsapevolezza e nella percezione sociale.
I ricercatori hanno ottenuto prove che con l'età aumenta il numero delle categorie descrittive, aumenta la flessibilità del loro utilizzo, aumenta il livello di selettività, coerenza, complessità e integrazione delle informazioni acquisite, vengono utilizzate valutazioni sempre più sottili e le connessioni tra vengono compresi e sorge una crescente capacità di analizzare e spiegare il comportamento e di eseguire azioni e azioni coscienti e volitive.
Entro la fine degli anni '80 del XX secolo. È diventato chiaro che la personalità veniva considerata da autori diversi da posizioni spesso contraddittorie, cioè veniva studiata sulla base di premesse diverse che offrivano opportunità ineguali per prevederla, comprenderla e svilupparla. Nello stesso periodo fu effettuato un confronto tra le strutture della personalità proposto da V.N. Myasishchev, B.G. Ananyev, A.G. Kovalev, K.K. Platonov, V.S. Merlino, A.N. Leontyev e altri. Tuttavia, le strutture della personalità proposte rimasero solo modelli teorici multidimensionali che non rispondevano alla domanda sulla sua essenza.
Queste idee furono sostituite da un nuovo modello di personalità: l'“uomo che agisce”. Sembrava imporsi con un modello diverso: quello del “bisogno”, creando l'immagine di una “persona bisognosa”. Entrambi i modelli, intersecandosi, hanno creato un'immagine ideale della persona sovietica - una "figura bisognosa", che è rimasta una priorità per diversi decenni, fino agli anni '80 e '90 del XX secolo.
Per molto tempo si è formata un'idea sullo sviluppo della personalità nell'ontogenesi. Il desiderio di formare un'idea dell'ontogenesi dello sviluppo della personalità ha intensificato il pensiero scientifico dei ricercatori e, a sua volta, li ha spinti a porre e risolvere domande sulla dinamica dei cambiamenti della personalità legati all'età, sulle fasi e sulle tendenze reali del suo formazione, condizioni per l'ottimizzazione e metodi di influenza pedagogica.
Lo sviluppo personale è tradizionalmente associato al processo educativo, poiché diventa possibile in presenza di “altri” che interagiscono con esso e svolgono attività di “sviluppo” (V.I. Slobodchikov). Lo sviluppo personale è impossibile non solo senza un “altro significativo”, ma anche senza un “sé significativo per gli altri”. La ricerca di una risposta alla domanda sullo sviluppo della personalità ha portato alla scoperta di una forma di attività chiamata "aspirazione", interpretata come l'attenzione di una persona alla produzione di azioni associate all'espansione delle capacità e del campo d'azione.
Gli psicologi hanno anche sollevato la questione di trasformare queste intenzioni in mezzi per coltivare aspirazioni personali. Si è riscontrato che ciò richiede un cambiamento nelle forme e nei contenuti della comunicazione, nonché nelle modalità di interazione tra docenti e studenti. Questa formulazione della domanda ha portato a un nuovo sguardo a una delle figure centrali del processo educativo: l'educatore (insegnante). A questo proposito, lo studente (allievo) ha cominciato a essere considerato non come uno sfondo, ma come un soggetto del processo educativo, che contiene tendenze all'autosviluppo e all'autorealizzazione.
Nuovo, Il quarto periodo Lo sviluppo della psicologia della personalità si è avuto nell’ultimo decennio del XX secolo. È caratterizzato dalla logica dell '"autorealizzazione" delle idee dell'individuo, che è diventata possibile in una società che cercava un percorso verso l'uomo come individuo. Il ricercatore ha scoperto “nuovi” aspetti della personalità: personalizzazione, soggettività riflessa, comunità di eventi, attività non adattiva.
Nelle opere di V.A. Petrovsky, cominciò a formarsi una nuova immagine di una persona, superando le barriere dei suoi limiti naturali e sociali. Ha rifiutato la visione dominante e consolidata in psicologia dell'uomo come essere adattivo, dotato di uno scopo e che tende a raggiungerlo.
Proposto da V.A. L'idea di Petrovsky di attività non adattiva e soggettività riflessa ha permesso di ripensare in modo significativo il fenomeno dello sviluppo della personalità e di esprimerlo in termini di auto-movimento. La personalità appariva come un sistema in auto-sviluppo, includendo altre persone nell'orbita del suo movimento come portatrici della loro rappresentazione ideale e continuità.
Nel modello concettuale della formazione della soggettività umana, gli scienziati hanno combinato i momenti del suo attivo non adattamento e della sua riflessione nelle persone. Petrovsky è riuscito a dimostrare che la generazione e la riproduzione di se stesso come soggetto da parte di una persona forma un unico ciclo di attività di valore personale. Nelle transizioni della soggettività virtuale, riflessa e restituita, una persona agisce come una personalità libera, olistica e in via di sviluppo.
Il significato di generarsi come soggetto di V.A. Petrovsky vede d'ora in poi nell'esistere in questa veste un ritorno a se stessi, un superamento di se stessi, cioè la formazione di un individuo come personalità è da lui considerata come autoformazione.
L'immagine dei concetti di personalità è gradualmente cambiata: da astratti e insufficientemente differenziati sono diventati più operativi e complicati. Da qui la svalutazione delle idee sullo sviluppo della personalità in alcuni degli ultimi decenni del ventesimo secolo. è stato fermato dalla sua interpretazione come “fenomeno di soggettività”, come una forma speciale di integrità, comprese le sue seguenti manifestazioni: come soggetto di una relazione vitale con il mondo, soggetto di una relazione oggettiva, soggetto di comunicazione e soggetto dell'autocoscienza (V.A. Petrovsky).
Finora è stata accumulata una certa esperienza nella ricerca fenomenologica sull’argomento. Quindi, A.Sh. Tkhostov ha cercato di identificare le proprietà topologiche del soggetto che sono stabili e non cambiano sotto alcuna deformazione. È diventato chiaro che l'opposizione “io” e “non-io”, “soggetto-oggetto” solo a prima vista sembra chiara e facilmente distinguibile. La questione più difficile si è rivelata essere i criteri per distinguerli e trovarne i confini.
Ci è voluto molto tempo prima che tutti capissero che l'idea dello sviluppo della personalità è stata sostituita dall'idea della sua formazione molto tempo fa, dai tempi di K.D. Ušinsky. Allo stesso tempo, non si è reso immediatamente conto del fatto che aveva perso il momento di spontaneità e di movimento. L’approvazione e l’applicazione di un approccio sistematico ha permesso di sollevare la questione dello sviluppo della personalità olistica del bambino attraverso un processo di apprendimento olistico.
C'è un notevole desiderio da parte degli scienziati moderni di comprendere la psicologia della personalità dal punto di vista delle leggi del mondo morale. Questa idea è stata sviluppata in modo produttivo da ricercatori moderni (A.G. Asmolov, B.S. Bratus, V.A. Petrovsky, D.A. Leontyev, V.I. Slobodchikov, A.B. Orlov, ecc.). Fa eco alle idee della ricerca di una personalità morale avanzate da filosofi e sociologi russi (V.S. Solovyov, N.A. Berdyaev, L.A. Karsavin, P. Florensky, P.A. Sorokin, ecc.). La questione di considerare la personalità dal lato morale, valoriale o semantico rimane ad oggi la meno sviluppata.
Restano discutibili le questioni relative alla determinazione dello status disciplinare della psicologia della personalità, alla ricerca di segni di una teoria psicologica generale della personalità, alla risoluzione della questione delle categorie del suo sviluppo, ecc .. La teoria sistemica di una personalità integrale rimane ancora solo una teoria ripetutamente pianificata, ma compito ancora incompiuto. Nonostante l'elenco autorevole di personalità che studiano la personalità, le linee generali della formazione della personalità nell'ontogenesi sono appena delineate.
I fenomeni socio-psicologici nascono dall'interazione dell'ambiente sociale, dell'individuo e del gruppo. Chiariamo questi concetti.
L'ambiente sociale è tutto ciò che circonda una persona nella sua vita sociale, è una manifestazione specifica, l'originalità delle relazioni sociali in un certo stadio del loro sviluppo. L'ambiente sociale dipende dal tipo di formazioni economico-sociali, dalla classe e dalla nazionalità, dalle differenze intraclassi di alcuni strati, dalle differenze quotidiane e professionali.
Per un'analisi socio-psicologica della personalità, i concetti di “personalità”, “individuo”, “individualità”, “persona” dovrebbero essere chiaramente distinti.
La vita e l'attività umana sono determinate dall'unità e dall'interazione di fattori biologici e sociali, con il ruolo principale del fattore sociale.
La psicologia tiene conto del fatto che la personalità non è solo un oggetto di relazioni sociali, non solo sperimenta le influenze sociali, ma le rifrange e le trasforma, poiché gradualmente la personalità inizia ad agire come un insieme di condizioni interne attraverso le quali vengono rifratte le influenze esterne della società . Pertanto, la personalità non è solo un oggetto e un prodotto delle relazioni sociali, ma anche un soggetto attivo di attività, comunicazione, coscienza e autocoscienza.
La personalità è un concetto sociale; esprime tutto ciò che è soprannaturale e storico in una persona. La personalità non è innata, ma nasce come risultato dello sviluppo culturale e sociale.
Quando si analizza il processo ontogenetico dello sviluppo della personalità, è necessario prestare particolare attenzione alle fasi della sua socializzazione. La socializzazione della personalità è il processo di formazione della personalità in determinate condizioni sociali, il processo di assimilazione dell'esperienza sociale da parte di una persona, durante il quale una persona trasforma l'esperienza sociale nei propri valori e orientamenti, introduce selettivamente nel suo sistema di comportamento quelle norme e modelli di comportamenti accettati nella società o in un gruppo. Le norme di comportamento, gli standard morali e le credenze di una persona sono determinate da quelle norme accettate in una determinata società.
Il termine “socializzazione” corrisponde al concetto secondo cui una persona (bambino) è inizialmente asociale oppure la sua socialità è ridotta al bisogno di comunicazione. In questo caso, la socialità è il processo di trasformazione di un soggetto inizialmente asociale in una personalità sociale che possiede modelli comportamentali socialmente accettati e ha adottato norme e ruoli sociali. Si ritiene che questa visione dello sviluppo della socialità sia caratteristica principalmente della psicoanalisi.
Comprendere il processo di assimilazione di norme sociali, abilità, stereotipi, formazione di atteggiamenti e credenze sociali, apprendimento di norme di comportamento e comunicazione socialmente accettate, opzioni di stile di vita, adesione a gruppi e interazione con i loro membri poiché la socializzazione ha senso se inizialmente l'individuo è inteso come un essere non sociale, e la sua non socialità deve essere superata nel processo di educazione nella società, non senza resistenze. In altri casi, il termine “socializzazione” in relazione allo sviluppo sociale dell’individuo è ridondante. Il concetto di “socialità” non sostituisce né sostituisce i concetti di insegnamento e educazione conosciuti nella pedagogia e nella psicologia dell'educazione.
Si distinguono le seguenti fasi di socializzazione:
Socializzazione primaria, o fase di adattamento (dalla nascita all'adolescenza, il bambino assimila acriticamente l'esperienza sociale, si adatta, si adatta, imita).
Fase di individualizzazione e (c'è il desiderio di distinguersi dagli altri, un atteggiamento critico nei confronti delle norme sociali di comportamento). Nell'adolescenza, la fase dell'individualizzazione, dell'autodeterminazione “del mondo e dell'io” è caratterizzata come socializzazione intermedia, poiché tutto è ancora instabile nella visione del mondo e nel carattere dell'adolescente.
Adolescenza(18-25 anni) è caratterizzato da una socializzazione concettuale stabile, quando si sviluppano tratti di personalità stabili.
Fase di integrazione(c’è il desiderio di trovare il proprio posto nella società, di “adattarsi” alla società). L’integrazione procede con successo se le caratteristiche di una persona vengono accettate dal gruppo, dalla società. Se non accettato, sono possibili i seguenti risultati:
Conservazione della propria dissomiglianza e comparsa di interazioni (relazioni) aggressive con le persone e la società;
Cambiare te stesso, “diventare come tutti gli altri”;
Conformismo, accordo esterno, adattamento.
Fase lavorativa della socializzazione copre l'intero periodo della maturità di una persona, l'intero periodo della sua attività lavorativa, quando una persona non solo assimila l'esperienza sociale, ma la riproduce anche a causa dell'influenza attiva della persona sull'ambiente attraverso le sue attività.
Fase di socializzazione post-lavorativa considera la vecchiaia come un'età che fornisce un contributo significativo alla riproduzione dell'esperienza sociale, al processo di trasmissione della stessa alle nuove generazioni.
Ogni sociocultura ha il proprio stile speciale di genitorialità; è determinato da ciò che la società si aspetta da un bambino. In ogni fase del suo sviluppo, il bambino o si integra nella società oppure viene rifiutato. Il famoso psicologo Erikson ha introdotto il concetto di "identità di gruppo", che si forma fin dai primi giorni di vita; il bambino si concentra sull'inclusione in un determinato gruppo sociale e inizia a comprendere il mondo proprio come fa questo gruppo. Ma gradualmente il bambino sviluppa anche una “identità dell'Io”, un senso di stabilità e continuità del suo “io”, nonostante siano in corso molti processi di cambiamento. La formazione dell'identità personale è un lungo processo che comprende una serie di fasi di sviluppo della personalità. Ogni fase è caratterizzata dai compiti di questa età e i compiti vengono proposti dalla società. Ma la soluzione dei problemi è determinata dal livello già raggiunto di sviluppo psicomotorio di una persona e dall'atmosfera spirituale della società in cui vive una persona.
SU fasi dell'infanzia Il ruolo principale nella vita del bambino è svolto dalla madre, lei nutre, si prende cura, dà affetto, cura, a seguito della quale il bambino sviluppa una fiducia di base nel mondo. La fiducia di base si manifesta nella facilità dell'allattamento, nel buon sonno del bambino, nella normale funzione intestinale, nella capacità del bambino di aspettare con calma la madre (non urla né chiama, il bambino sembra fiducioso che la madre verrà e farà ciò che è necessario) . Le dinamiche dello sviluppo della fiducia dipendono dalla madre. Un grave deficit nella comunicazione emotiva con il bambino porta ad un forte rallentamento dello sviluppo mentale del bambino.
2a fase la prima infanzia è associata alla formazione dell'autonomia e dell'indipendenza, il bambino inizia a camminare, impara a controllarsi quando compie atti di defecazione; La società e i genitori insegnano al bambino a essere pulito e ordinato e cominciano a svergognarlo perché ha i “pantaloni bagnati”.
All'età di 3-5 anni, a 3a fase, il bambino è già convinto di essere una persona, poiché corre, sa parlare, amplia l'area di padronanza del mondo, il bambino sviluppa un senso di intraprendenza e iniziativa, che è incorporato nel gioco . Il gioco è molto importante per lo sviluppo del bambino, ad es. forma iniziativa, creatività, il bambino padroneggia le relazioni tra le persone attraverso il gioco, sviluppa le sue capacità psicologiche: volontà, memoria, pensiero, ecc. Ma se i genitori sopprimono fortemente il bambino e non prestano attenzione ai suoi giochi, ciò influisce negativamente sullo sviluppo del bambino e contribuisce al consolidamento della passività, dell'incertezza, del senso di colpa.
In età di scuola primaria ( 4a fase) il bambino ha già esaurito le possibilità di sviluppo all'interno della famiglia, e ora la scuola introduce il bambino alla conoscenza delle attività future, trasmette gli ego tecnologici della cultura. Se un bambino padroneggia con successo conoscenze e nuove abilità, crede in se stesso, è fiducioso e calmo, ma i fallimenti a scuola portano all'emergere, e talvolta al consolidamento, di sentimenti di inferiorità, mancanza di fiducia nelle proprie capacità, disperazione, e perdita di interesse per l’apprendimento.
Durante l'adolescenza ( 5a tappa) si forma una forma centrale di identità dell'Io. Rapida crescita fisiologica, pubertà, preoccupazione per il suo aspetto davanti agli altri, la necessità di trovare la sua vocazione professionale, capacità, abilità: queste sono le domande che sorgono davanti a un adolescente, e queste sono già le richieste della società a un adolescente riguardo a se stesso determinazione.
SU 6a tappa(gioventù) per una persona diventa rilevante la ricerca di un compagno di vita, una stretta collaborazione con le persone, il rafforzamento dei legami con l'intero gruppo sociale, una persona non ha paura della spersonalizzazione, mescola la sua identità con altre persone, un sentimento di vicinanza , appare l'unità, la cooperazione, l'intimità con certe persone. Se però la diffusione dell’identità si estende fino a questa età, la persona si isola, l’isolamento e la solitudine si radicano.
7° – palco centrale– stadio adulto dello sviluppo della personalità. Lo sviluppo dell'identità continua per tutta la vita; c'è l'influenza di altre persone, soprattutto dei bambini: confermano che hanno bisogno di te. Sintomi positivi di questa fase: l'individuo si investe nel lavoro buono e amato e nella cura dei bambini, è soddisfatto di se stesso e della vita.
Dopo 50 anni ( 8a tappa) viene creata una forma completa di identità personale sulla base dell'intero percorso di sviluppo personale, una persona ripensa tutta la sua vita, realizza il suo “io” in pensieri spirituali sugli anni che ha vissuto. Una persona deve capire che la sua vita è un destino unico che non ha bisogno di essere attraversato, una persona “accetta” se stessa e la sua vita, realizza la necessità di una conclusione logica alla vita, mostra saggezza, un interesse distaccato per la vita in faccia di morte.
Basandosi sulle idee di Freud sullo sviluppo psicosessuale umano, Erikson (1950) sviluppò una teoria che enfatizza gli aspetti sociali di questo sviluppo. È considerato come un processo di integrazione dei fattori biologici individuali con fattori di istruzione e ambiente socioculturale.
Riassumiamo il lavoro. Devi fare una serie di
La situazione dello sviluppo di un individuo umano rivela le sue caratteristiche già nelle primissime fasi. Il principale è la natura indiretta delle connessioni del bambino con il mondo esterno. Inizialmente, i collegamenti biologici diretti tra bambino e madre sono ben presto mediati dagli oggetti: la madre nutre il bambino da una tazza, gli veste addosso e, tenendolo occupato, manipola un giocattolo. Allo stesso tempo, le connessioni del bambino con le cose sono mediate dalle persone che lo circondano: la madre avvicina il bambino alla cosa che lo attrae, gliela porta o, magari, gliela toglie. In una parola, l'attività del bambino appare sempre più come la realizzazione dei suoi legami con una persona attraverso le cose e dei suoi legami con le cose attraverso una persona.
Questa situazione evolutiva porta al fatto che le cose si rivelano al bambino non solo nelle loro proprietà fisiche, ma anche nella qualità speciale che acquisiscono nell'attività umana - nel loro significato funzionale (una tazza - da cosa bevono, una sedia - su cosa si siedono, un orologio - cosa si indossa sulla mano, ecc.), e le persone sono come i "signori" di queste cose, da cui dipendono i suoi legami con loro. L’attività oggettiva del bambino acquisisce una struttura strumentale e la comunicazione diventa verbale, mediata dal linguaggio.
Questa situazione iniziale dello sviluppo del bambino contiene il seme di quelle relazioni, il cui ulteriore sviluppo costituisce una catena di eventi che portano alla sua formazione come personalità. Inizialmente, per il bambino, i rapporti con il mondo delle cose e con le persone che lo circondano sono fusi tra loro, ma poi si dividono e formano linee di sviluppo diverse, sebbene interconnesse, che si trasformano l'una nell'altra.
Nell'ontogenesi, queste transizioni si esprimono in cambiamenti alternati di fasi: fasi di sviluppo prevalentemente dell'attività oggettiva (pratica e cognitiva) - fasi di sviluppo delle relazioni con le persone, con la società
La formazione della personalità comporta lo sviluppo del processo di formazione degli obiettivi e, di conseguenza, lo sviluppo delle azioni del soggetto. Le azioni, arricchendosi sempre più, sembrano superare la gamma di attività che implementano ed entrare in conflitto con i motivi che le hanno originate. I fenomeni di tale escrescenza sono ben noti e vengono costantemente descritti nella letteratura di psicologia dello sviluppo, seppure con termini diversi; Costituiscono le cosiddette crisi dello sviluppo: la crisi di tre anni, sette anni, l'adolescenza, nonché crisi della maturità molto meno studiate. Di conseguenza, c'è uno spostamento delle motivazioni degli obiettivi, un cambiamento nella loro gerarchia e la nascita di nuove motivazioni: nuovi tipi di attività; gli obiettivi precedenti sono psicologicamente screditati e le azioni ad essi corrispondenti cessano di esistere del tutto o si trasformano in operazioni impersonali.
Le forze motrici interne di questo processo risiedono nella dualità iniziale delle connessioni del soggetto con il mondo, nella loro doppia mediazione: attività oggettiva e comunicazione. Il suo dispiegarsi dà luogo non solo alla dualità della motivazione delle azioni, ma per questo anche alla loro subordinazione, a seconda delle relazioni oggettive che si aprono al soggetto in cui entra. Lo sviluppo e la moltiplicazione di queste subordinazioni, di natura speciale, che sorgono solo nelle condizioni della vita umana nella società, richiede un lungo periodo, che può essere definito lo stadio di un'autocoscienza spontanea, non guidata dall'autocoscienza della personalità emergente. In questa fase, che prosegue fino all'adolescenza, il processo di formazione della personalità non si conclude ma prepara soltanto la nascita di una personalità autocosciente.
1. Abulkhanova K. A. Dialettica della vita umana. M., 1977.
2. Ananyev B.G. L'uomo come oggetto di conoscenza. – L.: Casa editrice dell’Università statale di Leningrado, 1968.
3. Asmolov A.G. A proposito di psicologia della personalità. - Domanda. Psicologia, 1983, n. 3
4. Asmolov A.G. Psicologia della personalità: principi di analisi psicologica generale. – M.: Smysl, 2001.
5. Golovakha E. I., Kronik A. A. Tempo psicologico della personalità. Kiev, 1984.
6. Egorova M. S. Fondamenti del metodo longitudinale. - Nel libro: Problemi di psicofisiologia differenziale. TXM, 1981
7. Kenkman P. O., Saar E. A., Titma M. X. Autodeterminazione sociale delle generazioni. - Nel libro: sociologia sovietica. T.II. M., 1982, pag. 82-110.
8. Kon I. S. Alla ricerca di se stessi. La personalità e la sua autoconsapevolezza. M., 1984.
9. Kon I. S. Categorie di età nelle scienze dell'uomo e della società. - Sociale. Ricerca, 1978, n. 3.
10. Kotova I.B. Psicologia della personalità in Russia. Un secolo di sviluppo. – Rostov sul Don: Casa editrice RPGU, 1994.
11. Leites N. S. Sul problema dei periodi sensibili dello sviluppo mentale. - Nel libro: Il principio dello sviluppo in psicologia. M., 1978.
12. Leontyev A.N. Attività. Coscienza. Personalità. – M., 1977.
13. Petrovsky V.A. Psicologia dell'attività disadattiva. – M., 1992.
14. Il principio dello sviluppo in psicologia / Ed. Antsyferova L.I. M., 1978.
15. Metodi psicodiagnostici in uno studio longitudinale complesso sugli studenti. L., 1976.
16. Psicologia della formazione e dello sviluppo della personalità / Ed. Antsyferova L.I.M, 1981.
17. Thome G. Fondamenti teorici ed empirici della psicologia dello sviluppo umano. - Nel libro: Il principio dello sviluppo in psicologia. M., 1978
18. L'uomo allo specchio delle scienze // Collezione interuniversitaria / Ed. A.O. Boronoeva. – L.: Casa editrice dell’Università statale di Leningrado, 1991.
19. Chudnovsky V. E. Stabilità morale della personalità. - Nel libro: Ricerca psicologica. M., 1981.
Erickson E. Infanzia e società. San Pietroburgo, 1996.
Vedi Asmolov A.G. A proposito di psicologia della personalità. - Domanda. Psicologia, 1983, n. 3
Vedi E. I. Golovakha, A. A. Kronik.. Tempo psicologico della personalità. Kiev, 1984.
Kon I. S. Categorie di età nelle scienze dell'uomo e della società. - Sociale. Ricerca, 1978, n. 3.
Leites N. S. Sul problema dei periodi sensibili dello sviluppo mentale. - Nel libro: Il principio dello sviluppo in psicologia. M., 1978.
Tomo G. Fondamenti teorici ed empirici della psicologia dello sviluppo della vita umana. - Nel libro: Il principio dello sviluppo in psicologia. M., 1978
Vedi Erikson E. Infanzia e società. San Pietroburgo, 1996.
Erickson E. Identità: gioventù e crisi. M., 1996.
La personalità è una formazione mentale che, nonostante tutta la sua stabilità, è soggetta a continuo sviluppo. Lo sviluppo è un attributo così importante della personalità che è considerato “la forma principale della sua esistenza”. Esistono persino teorie sulla personalità, la cui idea principale è il principio dello sviluppo. Uno di loro dice: “La personalità umana è una forma in costante processo di cambiamento. Questo processo dalla nascita alla morte è creativo. Una persona è in grado di sentirsi come qualcosa che non ha età e non è limitata da nulla. La personalità, come processo che avviene nel tempo, cresce, si sviluppa e si evolve sotto forma di un corpo in costante cambiamento, pur rimanendo invariato per se stesso. Nel suo movimento l’io non ha età, non cambia, resiste alla distruzione provocata dal tempo, e allo stesso tempo cambia,...
si adatta, si reinventa.”
Ontogenesi della personalità– sviluppo orientato alla personalità della psiche umana individuale nel corso della vita, compreso l’emergere della personalità stessa e le sue successive trasformazioni nel corso dei cambiamenti fisici nel corpo e delle molteplici interazioni sociali e di altro tipo. Durante lo sviluppo ontogenetico e il percorso di vita di una persona, avviene una progressiva individualizzazione del corpo umano e della personalità, che copre tutti i livelli di questo sviluppo.
Quasi tutti gli psicologi coinvolti nell’ontogenesi della personalità riconoscono l’emergere di un “nucleo”, che a volte è designato con il termine “sistema-io”, a volte “sistema-io” o semplicemente “io”. Questo evento è solitamente chiamato la “nascita della personalità”.
L'ontogenesi della personalità è la principale direzione di sviluppo della psiche umana. Lo sviluppo umano assume fin dall'inizio un carattere personale. Ciò significa che nel processo di sviluppo ontogenetico sorgono nella psiche formazioni qualitativamente nuove, irriducibili
ai cambiamenti nelle funzioni mentali. Queste nuove formazioni psicologiche sono sistemi integrativi, che includono funzioni meno complesse. Percezione, memoria, pensiero e altre funzioni hanno una propria logica di sviluppo, trasformandosi attraverso l'integrazione in funzioni superiori: percezione categorica, memoria logica, pensiero verbale, ecc. Le funzioni superiori rappresentano una “lega” indivisibile di funzioni mentali di base. Determinano le attività umane, i rapporti con le persone e gli atteggiamenti
a te stesso. Il loro decadimento è possibile solo a causa della patologia.
Tuttavia, insieme a questo tipo di neoplasie, esistono altri sistemi integrativi più complessi. La categoria di tali sistemi include la volontà, che non ha alcuna correlazione tra le funzioni mentali elementari e include nella sua struttura non solo obiettivi fissati consapevolmente, ma anche altre funzioni mentali superiori (memoria emotiva, immaginazione, sentimenti morali, ecc.), una certa combinazione di che consente a una persona di gestire il tuo comportamento. Tali sistemi psicologici possono cambiare
nel processo della vita, in base all'esperienza acquisita da una persona e ai cambiamenti nelle caratteristiche generali della sua personalità.
L.S. Vygotskij considerava la coscienza del bambino come un sistema complesso, stabile per natura ma che si sviluppa per tutta la vita. Ha dimostrato che quest'area della psiche organizzata sistematicamente ha una certa logica di sviluppo. Nell'infanzia la coscienza è caratterizzata dall'indifferenziazione e dalla mancanza di indipendenza delle funzioni direttamente dipendenti dalla percezione; anche le emozioni di un bambino durano solo finché lo stimolo che le provoca si trova nel campo della percezione. Poi, nel processo di ontogenesi, si attivano altre funzioni: prima la memoria, poi il pensiero. Secondo la teoria di L.S. Vygotsky, durante l’ontogenesi la struttura sistemica della coscienza del bambino cambia.
Continuando questa linea di ragionamento teorico, L.I. Bozovic considerava la personalità umana stessa come un sistema psicologico relativamente stabile, solo a un livello integrativo più elevato, attribuendole una propria logica di sviluppo. La caratteristica principale di questo sviluppo è la capacità di comportarsi indipendentemente dalle circostanze che influenzano direttamente (e anche nonostante esse), guidati dai propri obiettivi consapevolmente fissati. La natura attiva piuttosto che reattiva del comportamento significa che una persona è padrona sia delle circostanze che di se stessa.
Il meccanismo motivazionale di tale comportamento, caratteristico della maturazione della personalità, è la connessione tra gli obiettivi fissati da una persona e i suoi sentimenti più elevati, che forniscono agli obiettivi una forza motivante diretta. L'assenza o la debolezza di questi sentimenti costringe una persona a ricorrere all'autocoercizione volontaria. Il significato dello sviluppo emotivo nell'ontogenesi della personalità è spiegato dal fatto che una persona che deve costantemente affrontare conflitti interni è caratterizzata da indecisione, instabilità di comportamento e incapacità di raggiungere obiettivi prefissati consapevolmente, ad es. l'assenza di tratti fondamentali che caratterizzano una personalità psicologicamente matura.
Viene così riaffermata l'idea che l'unità dei processi cognitivi ed emotivi è un segno importante della formazione della personalità.
Il processo di formazione della personalità è spesso chiamato socializzazione. Socializzazione– il processo di formazione della personalità, comprese varie trasformazioni dell’individuo umano sotto l’influenza della cultura, principalmente l’adattamento alle condizioni sociali di vita e attività e l’acquisizione di proprietà socialmente significative. Questo processo potrebbe anche essere chiamato “personalizzazione”, cioè maturazione della personalità. Nel corso della socializzazione (formazione, educazione, accumulo di esperienza pratica), si forma il mondo interiore di una persona, il cui contenuto è un'immagine figurativa e concettuale di se stessi, del mondo esterno e del proprio posto in esso. Ma questo, ovviamente, non significa che la personalità sia un fenomeno esclusivamente sociale. Senza un'adeguata base biologica, senza le naturali capacità umane, in particolare la capacità di padroneggiare il linguaggio, la formazione della personalità è impossibile.
Tutto ciò che è naturale in una persona rimane con lui nel processo di socializzazione, manifestandosi in molti bisogni ed emozioni associate, nel temperamento, nelle capacità e negli istinti sociali. Il naturale in una persona predetermina il potenziale che una persona porta con sé nel mondo, qualcosa di nuovo che non esisteva prima della sua nascita, e in larga misura determina la sua individualità unica. Questa stessa cosa naturale pone dei limiti a ciò che un individuo può trarre dalla cultura.
L'ontogenesi della personalità non si limita all'assimilazione della cultura. Stiamo parlando dello sviluppo della psiche veramente umana. Ogni singola persona, grazie alle sue capacità naturali e all'aiuto di altre persone, padroneggia la lingua e le altre ricchezze culturali accumulate dalla società. Ciò non solo amplia i suoi orizzonti, ma crea anche opportunità favorevoli per sbloccare il potenziale del corpo umano, principalmente il cervello, il sistema nervoso, gli organi di senso, cioè tutto ciò che è direttamente correlato ai processi di informazione. Si formano una memoria quasi illimitata, la capacità di ottenere ed elaborare informazioni attraverso i sensi e il pensiero e abilità sociali che consentono le azioni sociali più complesse. Di conseguenza, l'uomo, come fenomeno naturale, diventa un essere spirituale, un membro della società; si afferma l'unità del biologico e del sociale.
La socializzazione comprende anche il processo di sviluppo oggettivo dell'individuo, il cui contenuto è lo sviluppo del mondo oggettivo, della natura e la formazione dell'atteggiamento corretto nei loro confronti. Il rapporto dell'uomo con la natura presenta aspetti naturali-biologici e culturali-sociali. L'aspetto biologico significa che una persona proviene dalla natura e rimane tale per tutta la sua vita. Come ogni creatura vivente, anche l'uomo è incluso
nella circolazione naturale delle sostanze, che ha un naturale meccanismo di autoregolazione.
L'aspetto culturale e sociale è che l'uomo, come essere cosciente che ha acquisito uno stile di vita personale, stabilisce e regola i rapporti con la natura secondo il proprio progetto, che corrisponde al livello di maturità umana. L'atteggiamento delle persone nei confronti del mondo oggettivo e materiale è solitamente considerato come la sua cognizione e trasformazione, nonché l'adattamento a quelle condizioni di vita che non possono essere modificate a un dato livello di sviluppo della scienza e della tecnologia. Tuttavia, anche la conservazione delle condizioni naturali di vita e di sviluppo della società è una tradizione. La sottovalutazione di questo aspetto salvifico nel rapporto dell'uomo con la natura in condizioni in cui la scienza e la tecnologia hanno dato all'uomo un enorme potere diventa minacciosa. Ciò significa che la direzione soggettiva della socializzazione personale è in ritardo rispetto ad altre direzioni del progresso umano. La socializzazione dell'individuo ignora il fatto che la natura, in quanto fonte comune di risorse vitali per le generazioni attuali e future, è oggettivamente inclusa nel sistema delle relazioni sociali, che l'uso di queste risorse da parte di alcune persone influisce sugli interessi di altri, e quindi è una forma significativa di comportamento sociale.
Pertanto, la socializzazione dell'individuo nelle condizioni moderne dovrebbe essere effettuata tenendo conto delle leggi ambientali. Dovremmo allontanarci dal principio dell’“antropocentrismo”
all’“ecocentrismo”. Antropocentrismo- fede nell'eccezionalismo umano, nel fatto che una persona, soggetta alle leggi dell'eredità culturale, vive in un ambiente sociale piuttosto che naturale. Ecocentrismo– un principio basato sul fatto che il valore più alto è l’armonia dei rapporti tra uomo e natura, la responsabilità delle persone per lo stato di natura e quindi per il proprio futuro.
Idee importanti sul modo in cui i fattori sociali influenzano lo sviluppo della personalità sono contenute in P. Janet e L.S. Vygotskij. Credevano che ogni funzione mentale superiore passa attraverso uno stadio esterno nel suo sviluppo, essendo inizialmente una funzione sociale. Nello sviluppo del bambino essa appare due volte sulla scena: prima – socialmente, poi – psicologicamente, tra le persone come categoria interpsichica, poi all’interno del bambino come categoria intrapsichica”. Queste disposizioni costituirono la base per il concetto di sociogenesi delle funzioni mentali superiori e, di conseguenza, della personalità.
Ci sono tre aspetti o componenti nel contenuto della socializzazione: individualizzazione, intimizzazione e produzione del piano interno di coscienza (interiorizzazione). L'individualizzazione riflette la legge genetica fondamentale dello sviluppo culturale - il passaggio dall'attività interpsichica (attività collettiva del bambino) - alle forme di attività psicologica individuale. Questo processo può essere visto chiaramente nella trasformazione del discorso sociale esterno, “discorso per gli altri”, in discorso interno, “discorso per se stessi”. L’“intimizzazione” è una transizione dal “noi”
all’io, cioè il processo di formazione dell’autocoscienza di una persona. Secondo S.L. Rubinstein, questo processo di consapevolezza del proprio “io” da parte dei bambini si manifesta nel passaggio dai bambini di due anni che chiamano se stessi in terza persona, ad es. come li chiamano gli altri, alla forma in prima persona - "Io". L’“interiorizzazione” è la produzione del piano interno di coscienza.
La dinamica dell'ontogenesi della personalità e i suoi risultati si riflettono non solo nei cambiamenti psicologici e comportamentali interni, ma anche nell'opinione pubblica, nelle valutazioni sociali che hanno forma religiosa, tradizionale o legale. Nelle fasi più precoci della storia umana si svilupparono riti di iniziazione. Come scrive il sociologo francese E. Durkheim: “Il rito di iniziazione avviene nel momento in cui l'istruzione è completata; di solito si chiude addirittura l'ultimo periodo quando gli anziani completano la formazione del giovane, rivelandogli il segreto delle credenze più fondamentali e dei rituali sacri della tribù. Una volta completato questo rituale, l'individuo che lo ha vissuto prende un posto nella società; lascia le donne tra le quali ha trascorso tutta la sua infanzia; d'ora in poi occupa un posto ben definito tra i guerrieri; allo stesso tempo acquisisce coscienza dell'appartenenza al suo sesso e dei diritti e delle responsabilità ad esso connessi. Ora è diventato un uomo e un cittadino.
E presso tutti questi popoli è diffusa la credenza secondo la quale l'iniziato, per il fatto stesso dell'iniziazione, diviene una persona del tutto nuova; cambia personalità, riceve un nuovo nome, ed è noto che il nome qui è considerato non come un semplice segno verbale, ma come un elemento essenziale della personalità. L'iniziazione è considerata come una seconda nascita. La mente primitiva immagina simbolicamente questa trasformazione, immaginando che un certo principio spirituale e qualcosa come una nuova anima si siano incarnati nell'individuo. Ma se togliamo da questa credenza le forme mitiche di cui è rivestita, non troviamo allora dietro il simbolo l'idea vagamente discernibile che l'educazione ha come risultato la creazione di un nuovo essere nell'uomo? Questa è una creatura sociale."
L'ontogenesi della personalità in una delle sue dimensioni è presentata come crescita sociale, durante la quale una persona realizza che il suo “io” è cresciuto fino alla scala di una sorta di integrità sociale, che, per così dire, diventa il suo stesso organismo. Allo stesso tempo, per persone diverse, l’integrità ultima con cui sono “identificate” è rappresentata da comunità diverse: famiglia, cerchia di amici intimi, collettivo di lavoro, nazione, paese, umanità. Di conseguenza, possiamo parlare di diverse scale di personalità. Alcune di queste identificazioni di gruppo sono limitanti, altre sono dannose, come l'identificazione con un gruppo criminale o con un altro gruppo che è in conflitto violento con altri gruppi.
Secondo questo approccio, lo sviluppo di una persona in crescita è un processo socialmente orientato. Collegamenti separati in questo processo possono essere considerati l'acquisizione di conoscenze e abilità, uno sviluppo emotivo favorevole e l'introduzione a un senso di responsabilità, compreso il rispetto per i diritti degli altri, che è necessario in qualsiasi società vitale. Il contenuto dell'ontogenesi è anche lo sviluppo dell'autocoscienza (riflessione, autostima), del comportamento di ruolo; interiorizzazione delle norme sociali, fiducia nella realizzazione delle proprie capacità, consapevolezza di se stessi come membro indipendente della società.
Ogni fase dello sviluppo personale ha il suo risultato - una certa forma di socialità umana - l'una o l'altra posizione in relazione alla società. DI. Feldstein, autore del libro “Psicologia dello sviluppo della personalità nell’ontogenesi” (1989), identifica due principali posizioni sociali nell’ontogenesi della personalità: “Io sono nella società” e “Io sono e la società”. Il primo è caratterizzato dal desiderio del bambino di comprendere il suo “io” e le sue capacità. Questo problema viene risolto sviluppando una forma di attività soggettiva. Il bambino padroneggia l'esperienza sociale padroneggiando strumenti, segni, simboli e azioni ad essi associati. Lo sviluppo di modi per maneggiare gli oggetti, la valutazione delle proprie azioni, la capacità di guardarsi da vicino e di misurarsi con l'ambiente sono associati all'affermazione della posizione dell'"io" tra gli altri - "io nella società". Questa posizione, secondo Feldstein, è sviluppata particolarmente attivamente nei periodi da 1 a 3 anni, da 6 a 9 anni e da 15 a 17 anni. È durante questi periodi che viene aggiornato il lato sostanziale e pratico dell'attività.
La formazione della seconda posizione ("Io e la società") è associata all'assimilazione delle norme di comunicazione e al processo di individualizzazione. Il bambino si sforza di esprimersi, di evidenziare il suo “io”, di ricevere il riconoscimento della sua indipendenza dagli altri, di prendere un posto attivo in varie relazioni, dove il suo “io” agisce su base di uguaglianza con gli altri, il che garantisce lo sviluppo di un nuovo livello di autocoscienza nella società, autodeterminazione socialmente responsabile. La posizione "Io e la società" si forma attivamente dai 3 ai 6 anni e dai 10 ai 15 anni. Ciò è dovuto all'intensa assimilazione delle norme di comunicazione.
Durante l'ontogenesi, il contenuto delle posizioni sociali dei bambini si arricchisce. “Io sono nella società” per un bambino di un anno significa che percepisce il fatto della presenza di altre persone. In un bambino di sei anni, una posizione simile contiene una visione di se stesso in una cerchia di persone specifiche, il desiderio di essere come loro. Se la soluzione alla domanda “Io e la società” da parte di un bambino di tre anni indica l'identificazione del suo “io” tra le altre persone, allora un bambino di dieci anni è già consapevole della società come organizzazione sociale.
Già i bambini di un anno e mezzo sono caratterizzati dalla categorizzazione sociale, cioè dalla divisione dei coetanei in una situazione di giochi accoppiati in gruppi “Noi” e “Loro”, e all'interno del gruppo “Noi” in “Io” e “ Altro". Un bambino di due anni possiede un sistema di abilità e atteggiamenti sociali, che poi utilizza nei rapporti con le persone. Alterna già i ruoli - per se stesso e per l'altro, il che gli consente di distinguere più chiaramente i confini del proprio “io” dall'“Altro”. Il movimento in questa direzione porta un bambino di tre anni a realizzare la presenza del suo “io”, creando una nuova posizione “Io e società”. All’età di sei anni, è chiaramente evidente la capacità di mettersi nei panni di un’altra persona e di vedere le cose dalla sua posizione, tenendo conto non solo del proprio, ma anche del punto di vista di qualcun altro.
Il periodo adolescenziale dell'ontogenesi della personalità è in un certo modo differenziato: in questo momento, tali linee di sviluppo umano possono apparire come: a) umanistiche, b) egoistiche, c) depressive, d) suicide. La linea umanistica di sviluppo personale è caratterizzata da un atteggiamento positivo verso se stessi e verso la società. Ha due opzioni: altruistica ed egoistica. La versione altruistica dell'orientamento umanistico è la predominanza dell'interesse per le altre persone o per la comunità sociale, la disponibilità a sacrificare i propri interessi a beneficio di tutti. L'altruismo personale in questa fase può assumere un carattere patogeno e depressivo. La versione individualistica dell'orientamento umanistico dell'individuo è un orientamento “verso se stesso” e “per se stesso”.
La cosa più importante per un adolescente in questo caso è se stesso e i suoi problemi. L'affermazione del proprio “io”, il riconoscimento da parte degli altri della propria unicità diventa sia il valore che l'obiettivo di una persona. L'orientamento egoistico significa che per un adolescente le altre persone, gli interessi e gli affari sociali sono oggetto di un atteggiamento negativo, mentre si valuta sempre positivamente. L'orientamento depressivo della personalità indica che l'adolescente svaluta il suo “io” e il sistema dei suoi affari, mantenendo un atteggiamento generalmente condizionatamente positivo o neutrale nei confronti delle altre persone. Le tendenze suicide sono caratterizzate dalla svalutazione di se stessi e della società (“la vita non ha significato”).
Il contenuto psicologico dello sviluppo della personalità, la sua specificità, secondo D.I. Feldstein, è presentato in ciascuno dei livelli (fasi) dell'adolescenza in modi diversi.
Così, il primo livello, convenzionalmente definito “localmente capriccioso” (corrispondente all’età da 0 a 11 anni), è caratterizzato da: desiderio dell’adolescente più giovane di difendere il proprio diritto “a essere come un adulto”, di partecipare a varie attività in modo realistico e su base paritaria con gli adulti, per raggiungere qualsiasi modo disponibile di riconoscere la propria età adulta.
Il secondo livello di sviluppo – “legalmente significativo” (condizionatamente l’adolescenza media,
dai 12 ai 13 anni) ha altre caratteristiche. Un adolescente in questa fase di sviluppo è concentrato personalmente sulla necessità di riconoscimento sociale. Allo stesso tempo, è importante per lui provare insoddisfazione per la sua partecipazione al sistema degli affari reali, che diventa una condizione per attivare il bisogno del bambino di padroneggiare i suoi diritti civili nel sistema di relazioni con i propri cari e altre persone significative per lui.
Il terzo livello di sviluppo – “affermativo-efficace” (tipico del periodo di età dai 14 ai 15-16 anni) – è associato ad un forte aumento della necessità di applicare la gamma di possibilità (capacità, qualità) padroneggiate da un adolescente, che è causato dalla consapevolezza del suo posto tra le persone, dall'effettiva lizzazione del bisogno di autodeterminazione, di autoaffermazione. L'adolescente si sforza di realizzare la sua maturità sociale a un livello di opportunità a lui accessibile, in cui l'immagine del suo “io” è ora presentata integralmente. Ciò significa che per un bambino di 14-16 anni un tratto come la responsabilità sociale acquisisce tutte le caratteristiche di una nuova formazione mentale.
Grazie a ciò, le relazioni multistrato della personalità di un adolescente, che durante questo periodo sviluppano i loro livelli profondamente riflessivi, acquisiscono un tipo speciale di orientamento, caratterizzato da una tendenza generale: il desiderio di esprimere veramente il proprio “io” , in conformità con i valori e gli obiettivi della società.
Il percorso di vita di una persona è la storia della formazione e dello sviluppo di un individuo in una particolare società. Nel processo di istruzione e formazione pubblica, ad es. Nel processo di formazione delle persone di una determinata generazione, si formano "caratteri tipici dell'epoca", proprietà di comportamento socialmente preziose, le basi di una visione del mondo e la disponibilità al lavoro.
La variabilità individuale di tutte queste proprietà di una persona come persona è determinata da:
- interazione delle principali componenti dello status (economica, giuridica, familiare, scolastica);
- cambiamento dei ruoli e dei sistemi di relazione nei team (macro e micro gruppi);
Di particolare importanza è l'influenza specifica dello sviluppo sociale dell'individuo sull'intensificazione dei processi verbali, linguistici e mentali dell'attività del cervello umano. Tuttavia, tale influenza della storia della formazione della personalità sull'evoluzione ontogenetica dell'individuo avviene solo a un certo stadio dell'ontogenesi e aumenta gradualmente con l'accumulo dell'esperienza di vita e dell'attività sociale dell'individuo. Ciò è spiegato dal fatto che l'inizio della personalità avviene molto più tardi dell'inizio dell'individuo.
L’individuo “inizia” molto prima della nascita, e il neonato entra nell’ambiente esterno con una storia evolutiva specifica. l'inizio di un individuo ha origini profonde nella filogenesi e nell'ereditarietà, trasmesse attraverso la coppia genitoriale.
È stato stabilito che fin dalle prime settimane di vita di un bambino, una massa di capacità sensomotorie e meccanismi di comportamento, orientamento nel mondo esterno e comunicazione con le persone si formano in modo molto intenso e con velocità crescente.
Dal momento della nascita, una persona dipende dalle condizioni sociali di esistenza, istruzione e salute. Si forma come un essere animato, la cui evoluzione mentale è, forse, più importante di quella fisica, indicatore della normalità dello sviluppo ontogenetico e della prontezza per specifici meccanismi di comportamento umano (postura eretta, articolazione, linguaggio motorio, contatti sociali, attività oggettiva sotto forma di gioco).
Subito dopo la nascita si verificano eventi importanti per la formazione della sua futura personalità: la formazione della comunicazione durante i contatti con adulti vicini. La comunicazione è direttamente correlata allo sviluppo della personalità dei bambini, perché, anche nella sua forma emotiva diretta originaria, porta alla creazione di connessioni tra il bambino e le persone che lo circondano e risulta essere la prima componente della “totalità” di relazioni sociali, che costituiscono l’essenza della personalità.
Tuttavia, i condizionamenti sociali dello sviluppo e la presenza di un apparato neuropsichico complesso, acquisito individualmente, non sono ancora sufficienti per affermare che il neonato o il lattante è una persona, che l'inizio della personalità sono i momenti della nascita, del canticchiare, del balbettare e del comparsa delle prime reazioni selettive verso una persona. Non si può considerare più convincente il fatto che le proprietà tipologiche del sistema nervoso e del temperamento, così come le inclinazioni considerate la base naturale della personalità, si manifestino in modo abbastanza chiaro durante questi periodi. Tutte queste proprietà genotipicamente determinate di una persona come individuo esistono inizialmente indipendentemente dal tipo di personalità, con quale insieme di caratteristiche sociali le possiederà. Si può ritenere assodato che sulla base dei più diversi tipi di sistema nervoso si può formare lo stesso tipo di carattere, così come in persone con lo stesso tipo di sistema nervoso si possono trovare proprietà caratteriali contrastanti. Solo durante lo sviluppo della persona emergente queste proprietà sono incluse nella struttura generale della personalità e sono da essa mediate.
Nelle prime fasi della formazione della personalità, le proprietà neurodinamiche influenzano il ritmo e la direzione della formazione delle proprietà personali di una persona. Tuttavia, le proprietà personali di una persona sono collegate allo stile di vita moderno di una determinata società e popolo, con la storia dello sviluppo sociale.
La formazione dei tratti iniziali della personalità è associata alla formazione di un complesso di connessioni sociali regolate da norme e regole, allo sviluppo di mezzi di comunicazione con il loro apparato segnico, all'attività oggettiva con la sua motivazione sociale, alla consapevolezza della famiglia e ad altri ruoli.
Proprio come l'inizio di un individuo è un processo lungo e multifase di embriogenesi, così l'inizio di una personalità è un processo lungo e multifase di socializzazione precoce di un individuo, che si verifica più intensamente nel secondo o terzo anno di vita di una persona.
Successivamente, la formazione dei tratti della personalità procede in modo non uniforme ed eterocronico, corrispondente alla sequenza di assimilazione dei ruoli e ai cambiamenti nella posizione del bambino nella società.
I punti di partenza per l'inizio dell'ontogenesi e la storia dello sviluppo della personalità sono separati da molti mesi di vita e da fattori significativamente diversi. La “personalità” è sempre più giovane dell'“individuo” nella stessa persona. La storia di una persona, sebbene segnata dalla data di nascita, inizia molto più tardi. Le sue tappe fondamentali, soprattutto quelle iniziali, sono l’ammissione del bambino alla scuola dell’infanzia e, soprattutto, alla scuola, che determina una gamma più ampia di connessioni sociali e l’inclusione nel sistema di istituzioni e comunità caratteristiche della modernità. Sotto l'influenza dell'ambiente sociale e dell'educazione, nel bambino si sviluppa un certo tipo di riflessione, orientamento nella sfera circostante e regolazione del movimento, si sviluppa la coscienza, ad es. la struttura più generale dell'uomo come soggetto di attività.
Quindi non si nasce persona, si diventa persona (A. Leontyev, S. Rubinstein). Nascendo come individuo, una persona è inclusa nel sistema di relazioni e processi sociali, a seguito dei quali viene acquisita una qualità sociale speciale: diventa una persona.
Nella prima fase della sua ricerca, L.I. Bozhovich è partito dalla posizione secondo cui una persona psicologicamente matura è una persona che ha raggiunto un certo livello abbastanza elevato di sviluppo mentale. Come caratteristica principale di questo sviluppo, ha notato la capacità di una persona di comportarsi indipendentemente dalle circostanze che lo influenzano direttamente (e anche nonostante esse), pur essendo guidata dai propri obiettivi consapevolmente fissati. L'emergere di tale capacità determina la natura attiva, e non reattiva, del comportamento di una persona e la rende non schiava delle circostanze, ma padrona sia di esse che di se stessa.
Secondo questa comprensione, L.I. Bozhovich stava cercando modelli per l'emergere di questa capacità (e quindi, come pensavamo, la natura psicologica dell'individuo) nello sviluppo di quel sistema funzionale, che in psicologia è solitamente chiamato volontà. Per fare ciò, ha studiato la formazione della motivazione, ad es. obiettivi affettivamente saturi e, soprattutto, la formazione di un "piano d'azione interno" che consente a una persona di organizzare la propria sfera motivazionale in modo tale da garantire la vittoria di obiettivi consapevolmente fissati su motivazioni che, sebbene indesiderabili per una persona in un data situazione, sono direttamente più forti. In altre parole, ha studiato l'azione di quel sistema funzionale che garantisce il controllo cosciente di una persona sul suo comportamento (Bozhovich et al., 1974).
Inizialmente, questa linea di sviluppo di L.I. Božović lo considerava centrale per le caratteristiche psicologiche della personalità.
Tuttavia, studi successivi hanno rivelato che l’attuazione degli obiettivi fissati consapevolmente non avviene sempre nel modo sopra descritto, vale a dire attraverso il ricorso della persona al piano d’azione interno allo scopo di ricostruire consapevolmente la sfera motivazionale. In condizioni ancora insufficientemente studiate, gli obiettivi stessi possono acquisire una forza motivante così diretta che è in grado di indurre una persona a un comportamento appropriato, aggirando l'esperienza del conflitto interno, la lotta delle motivazioni, la riflessione, la scelta, la formazione dell'intenzione, in una parola, aggirando un atto di volontà nel senso proprio del termine. Questo comportamento è solo fenotipicamente simile a quello che di solito viene chiamato volitivo, ma è soggetto all'influenza della motivazione "secondaria", che è diventata diretta nel processo di sviluppo sociale del bambino. L'analisi mostra che tale motivazione (come se “post-volontaria”) è assicurata dalla connessione tra gli obiettivi fissati da una persona e i suoi sentimenti più elevati, che conferiscono forza motivante diretta agli obiettivi. L'assenza di sentimenti corrispondenti (o la loro debolezza) costringe una persona a ricorrere all'autocoercizione attraverso un atto di volontà.
Ricerca di L.I. Bozhovich ha dimostrato che ogni nuova formazione sistemica che si verifica durante la vita di una persona ed è una condizione necessaria per la sua esistenza come individuo sociale, include determinate componenti affettive e quindi ha una forza motivante diretta. Una persona è direttamente motivata dalle sue convinzioni, sentimenti morali e tratti intrinseci della personalità. Ma poiché ogni azione è influenzata contemporaneamente da molti bisogni e motivazioni, tra loro si verifica una lotta che, in caso di inconciliabilità di motivazioni equivalenti ma diversamente dirette, si riflette nell'esperienza di una persona sotto forma di conflitto con se stesso. Se i motivi più forti, ma razionalmente respinti, vincono direttamente in questo conflitto, la persona sperimenta esperienze difficili. Se i desideri immediati superano le aspirazioni morali, allora queste esperienze si esprimono in sentimenti di vergogna, rimorso, ecc., Che una persona cerca di mitigare con l'aiuto di vari tipi di meccanismi protettivi di repressione o con l'aiuto di “tecniche di neutralizzazione della coscienza, ” che alcuni criminologi americani sottolineano (Bochkareva, 1972). Da qui è chiaro che una persona che deve costantemente affrontare conflitti interni sarà caratterizzata da indecisione, instabilità di comportamento e incapacità di raggiungere obiettivi prefissati consapevolmente, ad es. gli mancheranno proprio quei tratti che sono fondamentali per le caratteristiche di una personalità psicologicamente matura.
Quindi, L.I. Bozhovich sostiene che la formazione della personalità non può essere caratterizzata dallo sviluppo indipendente di uno qualsiasi dei suoi lati: razionale, volitivo o emotivo. La personalità è veramente un sistema integrativo superiore, una sorta di integrità indissolubile. E possiamo supporre che emergano in sequenza alcune nuove formazioni che caratterizzano le fasi della linea centrale del suo sviluppo ontogenetico.
Già dai primi giorni di nascita, un bambino non è solo un "apparato di reazione", come sostenevano gli psicologi riflessivi, ma un essere che possiede, sebbene molto diffuso, ma comunque una propria vita mentale individuale. Ha bisogni primari (cibo, calore, movimento), bisogni legati allo sviluppo fondamentale del cervello (ad esempio, il bisogno di nuove esperienze) e, infine, bisogni sociali che compaiono e si sviluppano durante il primo anno di vita: il bisogno di un'altra persona, in comunicazione con lui, nella sua attenzione e sostegno. (Lisina, 1974). (Questi bisogni diventeranno in seguito i più importanti per la formazione morale del bambino.) Il riconoscimento di questi bisogni richiede il riconoscimento delle corrispondenti esperienze affettive del bambino. L'insoddisfazione per qualcuno di essi provoca esperienze negative nel bambino, espresse in ansia, urla, e la loro soddisfazione è gioia, aumento della vitalità generale, aumento dell'attività cognitiva e motoria (ad esempio, il cosiddetto complesso di rivitalizzazione), ecc.
Di conseguenza, il contenuto della vita mentale dei bambini nel primo anno di vita è caratterizzato prima da sensazioni affettivamente colorate e poi da impressioni vissute affettivamente a livello globale. In altre parole, nella coscienza del bambino sono rappresentate principalmente le componenti emotive associate alle influenze da lui direttamente percepite (NOTA A PIEDI: Il fatto che le forme più elementari della vita mentale (le sue fonti) siano emozioni è abbastanza comprensibile, poiché per un bambino quasi privo di metodi istintivi per soddisfare i propri bisogni e soddisfarli attraverso un adulto, biologicamente più importanti sono l'orientamento nello stato dei propri bisogni che nella realtà circostante, e la segnalazione tempestiva di ciò (l'esperienza è un mezzo di tale orientamento.) . Tuttavia, nel corso di un anno, la coscienza del bambino si sviluppa: in esso vengono identificate le singole funzioni mentali, compaiono le prime generalizzazioni sensoriali e inizia a utilizzare elementi di parole per designare oggetti. A questo proposito, i bisogni del bambino cominciano sempre più a incarnarsi (“cristallizzarsi”) negli oggetti della realtà circostante. Di conseguenza, gli oggetti stessi acquisiscono potere motivante. Pertanto, quando entrano nel campo di percezione del bambino, attualizzano i suoi bisogni, che prima erano in uno stato potenziale, e stimolano così l’attività del bambino nella direzione adeguata alla situazione data. Ciò determina la natura situazionale dei bambini del primo anno di vita, il cui comportamento è completamente controllato dagli stimoli che rientrano nel campo della loro percezione (NOTA A PIEDI: Il comportamento situazionale è caratteristico non solo dei bambini del primo anno di vita. È insito in una forma leggermente diversa nei bambini in età prescolare, prescolare e persino scolare. Il situazionismo viene superato solo gradualmente e il suo superamento è in gran parte la prova della formazione della personalità del bambino.). Quindi, e questo va sottolineato in particolare, i bambini del primo anno di vita non hanno un atteggiamento indifferente nei confronti degli oggetti circostanti. Percepiscono solo ciò che ha senso per loro e soddisfa i loro bisogni.
L'impotenza del bambino e la sua mancanza di motivazioni extrasituazionali (interne, ma non organiche) determinano anche il comportamento degli adulti nei confronti dei bambini di questa età. Impongono loro la loro volontà, seguendo il programma prescritto di sonno, alimentazione e camminata. Di norma, ai bambini di un anno non viene chiesto se vogliono camminare, dormire o mangiare.
Ma all'inizio del secondo anno di vita arriva un momento; quando un bambino cessa di obbedire obbedientemente a un adulto e l'adulto non può più controllare il suo comportamento organizzando influenze esterne. Le osservazioni rivelano che allo stesso tempo i bambini diventano capaci di agire non solo sotto l'influenza di impressioni direttamente percepite, ma anche sotto l'influenza di immagini e idee che emergono nella loro memoria.
Apparentemente questo è naturale, poiché durante questo periodo la memoria inizia a svolgere un ruolo sempre più importante nello sviluppo mentale del bambino, assume una posizione dominante e quindi ricostruisce la struttura della coscienza del bambino e del suo comportamento. Quindi centrale, cioè Una nuova formazione personale nel primo anno di vita è l’emergere di idee cariche di affetto che motivano il comportamento del bambino nonostante le influenze dell’ambiente esterno. L.I. Bozovic le chiama “rappresentazioni motivazionali”.
La comparsa di idee motivanti cambia radicalmente il comportamento del bambino e tutte le sue relazioni con la realtà circostante. La loro presenza libera il bambino dalla costrizione di una data situazione specifica, dai dettami delle influenze esterne (comprese quelle provenienti dall'adulto); in breve, lo trasformano in un soggetto, sebbene il bambino stesso non ne sia ancora consapevole. Tuttavia, gli adulti non possono più ignorarlo. L’intensità dei nuovi bisogni è così grande che la mancata presa in considerazione di essi, tanto meno la soppressione diretta, provoca la frustrazione del bambino, che spesso determina le sue future relazioni con gli adulti e, di conseguenza, l’ulteriore formazione della sua personalità.
Durante questo periodo il bambino passa da un essere che è già diventato soggetto (cioè che ha fatto il primo passo verso la formazione della personalità) ad un essere che si riconosce come soggetto, in altre parole, all'emergere di quella nuova formazione sistemica che di solito è associata all'apparizione della parola " io".
L'intera transizione avviene in condizioni ampiamente diverse da quelle che determinavano la vita e le attività del bambino. Innanzitutto, grazie ai successi dello sviluppo precedente nell'infanzia, i bambini piccoli iniziano a occupare un posto completamente diverso nel mondo delle persone e degli oggetti che li circondano. Queste non sono più creature indifese e insensibili, si muovono esse stesse nello spazio, possono agire da sole, soddisfare molti dei loro bisogni, diventare capaci di forme primarie di comunicazione verbale, in altre parole possono già svolgere attività non mediate da adulti.
Durante questo periodo, l'attività cognitiva del bambino si rivolge non solo al mondo esterno, ma anche a se stesso.
Il processo di autoconoscenza, a quanto pare, inizia con la conoscenza di se stessi come soggetto di azione. Spesso si può osservare come un bambino di questa età ama ripetere più volte lo stesso movimento, osservando e controllando attentamente i cambiamenti che esso (o meglio, lui con il suo aiuto) produce (ad esempio, aprire e chiudere una porta, spostare oggetti, spingendoli in modo che cadano, ecc.). Questo è ciò che aiuta il bambino a sentirsi qualcosa di diverso, a differenza degli oggetti circostanti, e quindi a distinguersi come oggetto speciale (soggetto dell'azione).
Tuttavia, la conoscenza di sé nel secondo e anche nel terzo anno di vita continua ad essere per il bambino stesso (soggettivamente) conoscenza di un “oggetto” che gli è, per così dire, esterno.
Senza una ricerca speciale, è difficile comprendere il “meccanismo” psicologico del passaggio dal proprio nome al pronome I, cioè meccanismo di passaggio dalla conoscenza di sé alla consapevolezza di sé. L.I. Bozovic suggerisce che il cosiddetto “sistema del sé” comprende sia componenti razionali che affettive e, soprattutto, l’atteggiamento verso se stessi. Dopo l’emergere del “sistema-io”, nella psiche del bambino sorgono altre nuove formazioni. I più significativi sono l’autostima e il desiderio associato di soddisfare le esigenze degli adulti, di essere “buoni”.
Apparentemente l’autostima primaria è quasi del tutto priva di una componente razionale; essa nasce dal desiderio del bambino di ricevere l’approvazione di un adulto e mantenere così il benessere emotivo.
La presenza simultanea di tendenze affettive forti ma dirette in modo opposto (fare secondo i propri desideri e soddisfare le richieste degli adulti) crea un inevitabile conflitto interno nel bambino e quindi complica la sua vita mentale interna. Già in questa fase dello sviluppo, la contraddizione tra “voglio” e “devo” mette il bambino di fronte alla necessità di scegliere, provoca esperienze emotive opposte, crea un atteggiamento ambivalente nei confronti degli adulti e determina l'incoerenza del suo comportamento (Sorokina, 1977 ).
Tuttavia, nei primi periodi (fino a 6-7 anni), i bambini non sono ancora consapevoli del posto che occupano nella vita e non hanno il desiderio cosciente di cambiarlo. Se hanno nuove opportunità che non si realizzano nel quadro dello stile di vita che conducono, allora sperimentano insoddisfazione, provocando loro proteste e resistenze inconsce, che si esprimono nelle crisi di 1 anno e 3 anni.
Al contrario, nei bambini di 6-7 anni, in connessione con i loro progressi nello sviluppo mentale generale, appare un desiderio chiaramente espresso di assumere una posizione nuova, più “adulta” nella vita e di realizzare un nuovo, importante non solo per se stessi , ma anche per le persone che ci circondano. Nelle condizioni di scolarizzazione universale, ciò si realizza solitamente nel desiderio dello status sociale dello studente e dell'apprendimento come nuova attività socialmente significativa. Naturalmente, a volte questo desiderio ha un'altra espressione concreta: ad esempio, il desiderio di eseguire determinate istruzioni degli adulti, assumersi alcune delle loro responsabilità, diventare aiutanti in famiglia, ecc. Ma l'essenza psicologica di queste aspirazioni rimane la stessa: i bambini in età prescolare più anziani iniziano a lottare per una nuova posizione nel sistema di relazioni sociali a loro disposizione e per nuove attività socialmente significative (Bozhovich, 1951, 1968).
L'apparizione di tale aspirazione è preparata dall'intero corso dello sviluppo mentale del bambino e sorge al livello in cui diventa consapevole di se stesso non solo come soggetto d'azione, che era caratteristico dello stadio di sviluppo precedente), ma anche come soggetto nel sistema delle relazioni umane. In altre parole, il bambino diventa consapevole del proprio sé sociale.
Il nuovo livello di autocoscienza che sorge alla soglia della vita scolastica di un bambino è espresso in modo più adeguato nella sua "posizione interna", formata come risultato del fatto che le influenze esterne, rifratte attraverso la struttura delle caratteristiche psicologiche precedentemente sviluppate del bambino , vengono da lui in qualche modo generalizzati e formati in una speciale nuova formazione personale centrale che caratterizza la personalità del bambino nel suo insieme. L'apparizione di una tale neoplasia diventa un punto di svolta nell'intero sviluppo ontogenetico del bambino.
In futuro, durante il passaggio da una fascia di età all'altra, il contenuto psicologico di questa nuova formazione sarà diverso, poiché sono diversi quei processi mentali interni sulla base dei quali nasce l'esperienza del bambino della sua posizione oggettiva. Ma in tutti i casi, rifletterà il grado di soddisfazione del bambino per la posizione che occupa, la presenza o l’assenza della sua esperienza di benessere emotivo e darà origine anche ai bisogni e alle aspirazioni corrispondenti.
La presenza di una posizione interna caratterizza non solo il processo di formazione della personalità nell'ontogenesi. Una volta sorta, questa posizione diventa inerente a una persona in tutte le fasi del suo percorso di vita e determina anche il suo atteggiamento verso se stesso e la posizione che occupa nella vita.
Quali processi di sviluppo mentale in età prescolare portano a questa neoplasia? Come viene preparato e quali caratteristiche specifiche per l'età lo caratterizzano?
Nel contesto del comportamento quotidiano e della comunicazione con gli adulti, così come nella pratica del gioco di ruolo, un bambino in età prescolare sviluppa una conoscenza generalizzata di molte norme sociali, ma questa conoscenza non è ancora pienamente realizzata dal bambino stesso ed è direttamente fusa con le sue esperienze emotive positive o negative. In altre parole, le prime autorità etiche sono ancora formazioni sistemiche relativamente semplici, che, tuttavia, sono gli embrioni di quei sentimenti morali, sulla base dei quali si formano successivamente sentimenti morali e credenze morali pienamente maturi.
Le autorità morali danno origine a motivazioni morali di comportamento nei bambini in età prescolare che, secondo dati sperimentali (Elkonin, 1960), possono avere un impatto più forte di molti altri bisogni immediati, compresi quelli elementari.
Nei bambini in età prescolare non si verifica solo una subordinazione dei motivi, ma una loro subordinazione relativamente stabile e non situazionale. Allo stesso tempo, i motivi specificamente umani, cioè mediati nella loro struttura, diventano a capo della gerarchia emergente.
In alcuni casi, i bambini in età prescolare possono già superare gli altri desideri e agire secondo il motivo morale "dovrebbe". Ma questo è possibile non perché a questa età i bambini sappiano già gestire consapevolmente il proprio comportamento, ma perché i loro sentimenti morali hanno una forza motivante maggiore rispetto ad altri motivi. Ciò consente loro di sconfiggere le motivazioni concorrenti in una battaglia spontanea non controllata dal bambino stesso. In altre parole, i bambini in età prescolare sono caratterizzati da una sorta di “casualità involontaria”, che garantisce la stabilità del loro comportamento e crea l'unità della loro personalità.
Quando diciamo che il bambino si realizza prima come soggetto d'azione e poi come soggetto sociale (soggetto di relazioni), allora in questo caso dobbiamo tenere presente che questa “consapevolezza” nei bambini non è tanto razionale quanto è di natura sensuale (intuitiva). Pertanto, la "visione del mondo" di un bambino in età prescolare dovrebbe essere chiamata più accuratamente non tanto "visione del mondo", ma, usando l'espressione di I.M. Sechenov, “una visione del mondo olistica”.
L.I. Bozovic ritiene che tutte le teorie sull'adolescenza che tentano di spiegare la psicologia dell'adolescente basandosi su fattori esterni allo sviluppo mentale siano insostenibili. Dopotutto, i fattori sia di ordine biologico che sociale non determinano direttamente lo sviluppo; sono inclusi nel processo di sviluppo stesso, diventando componenti interni delle formazioni psicologiche risultanti.
Sulla base dei dati disponibili in letteratura e delle proprie ricerche, L.I. Bozhovich ritiene che la crisi dell'adolescenza sia associata all'emergere durante questo periodo di un nuovo livello di autocoscienza, una caratteristica del quale è l'emergere in un adolescente della capacità e del bisogno di conoscere se stesso come persona che possiede la propria , a differenza di tutte le altre persone, qualità intrinseche. Ciò dà origine al desiderio dell'adolescente di autoaffermazione, autoespressione (cioè il desiderio di esprimersi in quei tratti della personalità che considera preziosi) e autoeducazione. La privazione dei bisogni di cui sopra è alla base della crisi adolescenziale.
L.I. Bozhovich traccia quei cambiamenti nella psiche dei bambini in età scolare che portano alla comparsa della suddetta neoplasia sistemica durante il periodo di transizione:
L'attività educativa e, soprattutto, il processo di assimilazione della conoscenza stessa, che pone nuove esigenze al pensiero di un bambino in età prescolare; in una parola, l'attività educativa nel suo insieme diventa leader in età scolare, ad es. quello in cui si formano le principali nuove formazioni psicologiche di questo periodo: forme teoriche di pensiero, interessi cognitivi, capacità di controllare il proprio comportamento, senso di responsabilità e molte altre qualità della mente e del carattere di uno scolaro che lo distinguono da bambini in età prescolare. In questo caso, il ruolo principale è giocato dallo sviluppo del pensiero che avviene durante l'assimilazione della conoscenza scientifica.
Naturalmente non è solo lo sviluppo del pensiero a determinare l’emergere di una forma di autocoscienza specifica degli adolescenti. Ciò è facilitato anche dalle nuove circostanze che distinguono lo stile di vita di un adolescente da quello dei bambini in età di scuola primaria. Prima di tutto, si tratta di crescenti richieste nei confronti di un adolescente da parte di adulti, compagni, la cui opinione pubblica è determinata non tanto dal successo dello studente nell'apprendimento, ma da molti altri tratti della sua personalità, punti di vista, abilità, carattere e capacità di conformarsi con il “codice di moralità” accettato tra gli adolescenti. Tutto ciò dà origine a motivazioni che incoraggiano un adolescente a dedicarsi all'analisi di se stesso e al confronto con gli altri. Pertanto, sviluppa gradualmente orientamenti di valore e sviluppa modelli di comportamento relativamente stabili che, a differenza dei modelli dei bambini in età di scuola primaria, sono presentati non tanto sotto forma di un'immagine di una persona specifica, ma in determinati requisiti che gli adolescenti fanno delle persone e di se stessi.
I materiali della ricerca hanno mostrato che comuni a tutti gli adolescenti, indipendentemente dalle differenze nella loro socializzazione, sono quelle caratteristiche psicologiche che si basano sullo sviluppo della riflessione, generando il bisogno di comprendere se stessi e di essere all’altezza delle proprie esigenze per se stessi, vale a dire raggiungere il campione selezionato. E l'incapacità di soddisfare questi bisogni determina un intero “bouquet” di caratteristiche psicologiche specifiche della crisi adolescenziale.
In connessione con l'apprendimento, la maturazione, l'accumulo di esperienze di vita e, di conseguenza, il progresso nello sviluppo mentale generale, gli scolari all'inizio dell'adolescenza formano interessi nuovi e più ampi, sorgono vari hobby e il desiderio sembra assumere un aspetto diverso, più indipendente, più “ posizione adulta", che è associata a tale comportamento e a tali qualità della personalità che, a loro sembra, non possono trovare la loro realizzazione nella vita scolastica "ordinaria".
La crisi del periodo di transizione procede molto più facilmente se, già a questa età, lo studente ha interessi personali relativamente permanenti o altri motivi di comportamento stabili.
Gli interessi personali, a differenza degli interessi episodici (situazionali), sono caratterizzati dalla loro “insaziabilità”: più sono soddisfatti, più diventano stabili e intensi. Questi sono, ad esempio, interessi cognitivi, bisogni estetici, ecc. La soddisfazione di tali interessi è associata a una ricerca attiva (o creazione) dell'oggetto della loro soddisfazione. Ciò spinge gli adolescenti a porsi sempre più nuovi obiettivi, spesso andando oltre la situazione attuale e addirittura oltre il presente.
Pertanto, la presenza di interessi personali stabili in un adolescente lo rende orientato agli obiettivi, e quindi internamente più raccolto e organizzato. È come se stesse conquistando la libertà.
Il periodo critico e transitorio termina con l’emergere di una speciale nuova formazione personale, che può essere designata con il termine “autodeterminazione”. Dal punto di vista dell’autocoscienza del soggetto, si concretizza in una posizione nuova, socialmente significativa.
L’autodeterminazione si forma nella seconda fase dell’adolescenza (16-17 anni), nel contesto dell’imminente diploma di scuola, associato alla necessità, in un modo o nell’altro, di risolvere il problema del proprio futuro.
L'autodeterminazione differisce dai sogni di un adolescente legati al futuro in quanto si basa sugli interessi e sulle aspirazioni del soggetto già saldamente stabiliti; il fatto che ciò comporti la presa in considerazione delle proprie capacità e delle circostanze esterne; si basa sulla visione del mondo emergente dell’adolescente ed è associato alla scelta della professione.
Va notato che le opinioni di L.I. Bozhovich contiene molte idee e approcci costruttivi significativi per la psicologia moderna. Tra questi ci sono le disposizioni sulla posizione interna e il suo ruolo nello sviluppo personale del bambino, gli sviluppi psicologici dei fenomeni di direzione e stabilità della personalità e un'analisi dettagliata delle fasi di formazione della personalità nell'ontogenesi. L'intero orientamento della sua visione del mondo e del concetto di personalità è molto in sintonia con la moderna psicologia della personalità. L.I. Bozovic difendeva la “sovranità psicologica” dell'individuo, la sua emancipazione dalla pressione sociale, si opponeva alla trasformazione dell'uomo in un “ingranaggio” della macchina sociale, per il suo diritto di essere non solo un trasformatore dell'ambiente, ma anche un creatore di se stesso.
TEMPO E SVILUPPO PERSONALE NELL'ONTOGENESI
Basandosi sul fatto che lo sviluppo umano avviene in “un tempo speciale, vivo, spesso chiamato psicologico” [V. P. Zinchenko, 1991], cercheremo di tracciare il processo olistico di funzionamento e sviluppo della personalità, la formazione delle sue proprietà e caratteristiche strutturali nel tempo.
Il tempo vissuto è notevole in quanto contiene contemporaneamente tutti e tre i colori del tempo: passato, presente e futuro. Ecco perché la psiche, come scrisse A.I. Severtsov, non è solo un prodotto dell'evoluzione, ma
non è nemmeno l'unico fattore, ma la forza trainante dell'evoluzione, ovviamente, non è l'unica. Allo stesso modo, la coscienza, che ha questa proprietà, è la forza motrice della storia. Sia la psiche che la coscienza sono libere di scegliere il momento della costruzione e di determinare la direzione del volo. Naturalmente, sia la psiche che la coscienza sono soggette al flusso del tempo naturale, ma lo superano, non senza successo, lo scambiano con energia e spazio e addirittura lo fermano. Come nota correttamente il vicepresidente Zinchenko nel suo trittico di articoli "Leggere O. Mandelstam", una persona non vive al di fuori del tempo. "È auspicabile, ovviamente", come scrive O. Mandelstam, che viva nel tempo storico, e non nell'atemporalità, in ogni caso una persona vive nel tempo che gli appartiene. Anche il senso stesso del tempo è dato alla persona per agire, vincere, morire, amare” /1996/.
La trascuratezza del tempo, i cambiamenti nel flusso oggettivo del tempo, l’etercronicità dello sviluppo fisico, mentale e sociale, sia a livello interindividuale che intraindividuale, il restare indietro o in anticipo rispetto al “proprio tempo” possono, pensiamo, influenzare lo sviluppo del potenziale personale. Come osserva I. S. Kon, le differenze interindividuali qui sono piuttosto grandi.
Pertanto, tra i ragazzi che sono “in anticipo sui tempi”, i ragazzi acceleratore che maturano precocemente, la crescita massima si verifica nel 13° anno, mentre i loro coetanei “indietro rispetto ai tempi”, che maturano tardivamente, sono due anni indietro nel loro sviluppo fisico. Questa eterocronia non è solo un fatto oggettivo che determina la posizione e l'attività di un adolescente, ma deve esserlo
essere considerato anche in relazione al significato e al potenziale personale, al significato personale che ha per la stessa personalità in via di sviluppo.
La tendenza all'influenza eterocronica del tempo storico e biologico è particolarmente evidente nell'ontogenesi precoce, quando l'accelerazione della maturazione somatica e fisiologica generale cambia le fasi della maturazione sociale e cancella i confini dell'età.
L'accelerazione dello sviluppo copre non solo le caratteristiche fisiologiche e intellettuali, ma si estende in gran parte anche alla formazione della personalità.
L'eterocronicità dello sviluppo di diverse sottostrutture del corpo umano e della personalità, che hanno diversi livelli di determinazione sociale, dà origine a una serie di problemi di adattamento di una persona come soggetto di attività, porta a difficoltà nel funzionamento e nell'interazione di l’individuo a diversi livelli di età. Pertanto, la marginalità di un adolescente, come conseguenza dell'eterocronicità dello sviluppo della personalità e delle sue sottostrutture, dà origine anche a tratti comportamentali caratteristici di una personalità marginale, come l'instabilità emotiva, la sensibilità, la timidezza e l'aggressività. Da qui i rapporti conflittuali con gli altri e la tendenza a giudizi e valutazioni estremi.
La multitemporalità degli aspetti biologici e sociali della maturazione, generata dalla fusione profonda del tempo storico e biologico, si intensifica nell'ontogenesi e si accompagna alla sua crescente individualizzazione. Ciò è evidenziato dall'accelerazione della maturazione somatica e fisiologica generale nella prima ontogenesi; d'altra parte, le fasi della maturazione sociale sono allungate. L'influenza del tempo storico sullo sviluppo mentale individuale porta ad un allungamento del periodo dell'infanzia e dell'adolescenza in una persona e, di conseguenza, a una discrepanza tra le fasi della maturazione generale somatica, sessuale e sociale. Questi punti di sviluppo e tappe fondamentali dell’età vengono raggiunti in tempi diversi. P. P. Blonsky ha un'idea molto profonda che tutto nel mondo, compresa l'età, ha una sua storia. "Con ogni probabilità", scrive P. P. Blonsky, "la giovinezza umana non è un fenomeno eterno, ma un'acquisizione molto tardiva dell'umanità avvenuta quasi davanti agli occhi della storia". Come ogni acquisizione tardiva, varia notevolmente tra i diversi popoli e differisce notevolmente nella durata nei diversi gruppi sociali.
La giovinezza, come ultima acquisizione dell'umanità, funge da preludio alla maturità e alla questione della sua scadenza
la durata non è chiara L’aumento del divario temporale tra la maturazione fisica e quella sociale può avere due conseguenze. La presenza di un lungo periodo dell'adolescenza consente di preparare una persona alla sua vita futura in molti modi. I confini sociali e le differenze nella durata di questo periodo, che, secondo P. Blonsky, può raggiungere i dieci o più anni, indicano il condizionamento sociale diretto di questo periodo. D'altra parte, i ritardi nella maturazione sociale portano a difficoltà di adattamento alle attività pratiche stesse. L'etercronicità dei tassi di maturazione sessuale, intellettuale e sociale sconvolge la formazione olistica di una persona, della sua personalità e porta all'impoverimento di alcuni aspetti della personalità in via di sviluppo.
A giudicare dai dati degli studi longitudinali, nell'adolescenza i segni del somatotipo hanno un significato relativamente indipendente, mentre nella giovinezza compaiono principalmente in connessione con caratteristiche più generali del processo di maturazione. Poiché sia gli adulti che i coetanei di solito percepiscono i ragazzi accelerati come più maturi, non devono lottare per la posizione e lo status.
La maggior parte dei dirigenti delle scuole superiori proviene da loro. Al contrario, i ritardanti sembrano “piccoli” agli altri non solo in senso fisico, ma anche in senso socio-psicologico. La risposta a ciò può essere rappresentata da azioni infantili inadeguate all'età e al livello di sviluppo, attività esagerate progettate per ottenere effetti esterni e attirare l'attenzione o, al contrario, isolamento e ritiro in se stessi.
In generale, come osserva lo psicologo americano D. Clausen, le proprietà corporee, permanenti o
temporaneo, può influenzare il comportamento e la psiche di un adolescente in tre modi. Innanzitutto, la maturità relativa, l'altezza e il fisico influenzano direttamente le corrispondenti capacità fisiche: avendo vantaggi in altezza, peso e forza, un ragazzo acceleratore può sovraperformare i suoi coetanei negli sport e nelle attività fisiche per diversi anni. Inoltre, la maturità e l'apparenza hanno un certo valore sociale, suscitando sentimenti e aspettative corrispondenti tra le persone che li circondano. Tuttavia, le capacità individuali non sempre corrispondono alle aspettative basate sull'apparenza, ad esempio, un ragazzo alto con scarsa coordinazione sarà un cattivo giocatore di basket, ma ci si aspetta molto da lui.
Da qui la terza dimensione: l'immagine dell'io, in cui si rifrangono le proprie capacità e la loro percezione e valutazione da parte degli altri, quella che chiamiamo “posizione interna”.
La “posizione interna” consiste nel modo in cui il bambino, dalla sua precedente esperienza, dalle sue capacità, dai suoi primi bisogni e aspirazioni, si relaziona con la posizione oggettiva che attualmente occupa nella vita e quale posizione vuole occupare. È questa posizione interna, come scrive L.I. Bozhovich, che determina una certa struttura del suo atteggiamento verso la realtà, verso gli altri e verso se stesso. Attraverso questa posizione interna le influenze provenienti dall'ambiente vengono rifratte in ogni dato momento.
In questo caso, l’ambiente dovrebbe essere considerato come un “ambiente di sviluppo” che determina esternamente lo sviluppo del bambino. Le influenze dell'ambiente stesso cambiano qualitativamente e quantitativamente a seconda del modo in cui vengono rifratte le proprietà psicologiche precedentemente emerse, comprese le caratteristiche dell'età del bambino. L.S. Vygotsky ha sottolineato che la formazione di una persona come individuo e personalità presuppone una combinazione speciale, una coincidenza nel tempo dei processi di sviluppo interno e delle condizioni esterne, che è tipica di ogni fase di età e determina le dinamiche dello sviluppo mentale durante l'età corrispondente periodo, e nuove formazioni psicologiche peculiari e qualitative che sorgono verso la sua fine. Questa interazione, l'influenza reciproca simultanea del sociale e dell'individuo sui processi di sviluppo della personalità nell'ontogenesi, è chiaramente espressa nel concetto di "situazione sociale di sviluppo" proposto da L. S. Vygotsky. Secondo Vygotsky, il contenuto dell'ontogenesi, la formazione della personalità nell'ontogenesi, è determinato dall'interazione di due serie di sviluppo relativamente autonome, ma inestricabilmente legate: naturale e sociale. La serie naturale si basa su processi di maturazione determinati biologicamente e modelli generali di ontogenesi. Ma la formazione di una persona come soggetto di attività e come individuo si realizza solo nel processo di socializzazione, quando, sotto l'influenza a lungo termine dell'ambiente nel suo insieme, l'individuo viene introdotto alle norme e alle regole di esistenza sociale, assimila cultura, comportamento nei contatti interpersonali, nonché si afferma attraverso l'adempimento di vari ruoli sociali.
Le fasi del percorso di vita si sovrappongono così strettamente alle fasi dell'ontogenesi che spesso non notiamo le loro differenze e addirittura chiamiamo concetti "legati all'età" come "bambino in età prescolare" o "scolarizzatore", che in realtà corrispondono alle fasi del pubblico educazione, istruzione e formazione accettate oggi.
Tuttavia, queste due serie non sono identiche. Come scrive B. G. Ananyev, “l'inizio della maturità di una persona come individuo (maturità fisica), personalità (civile), oggetto di conoscenza (mentale) e lavoro (capacità di lavorare) non coincidono nel tempo, e tale eterocronicità della maturità è preservato in tutte le formazioni”.
Il primo tentativo di indagare l'evoluzione psicologica della personalità in tempo reale è stato fatto da P. Janet. L. Sav chiama la vera base della personalità l'uso del tempo, sottolineando l'esistenza di diversi tipi di uso del tempo. "Solo una struttura temporanea può corrispondere alla logica interna dell'attività di un individuo, della sua riproduzione e del suo sviluppo", osserva L. Sav. Nella psicologia russa, l'aspetto temporale dello sviluppo della personalità, in termini di studio del suo percorso di vita, lo troviamo per la prima volta nelle opere di S. L. Rubinstein, B. G. Ananyev e dei suoi colleghi. Recentemente si tratta di opere di K. A. Abulkhanova-Slavskaya, V. I. Kovalev, A. A. Kronik e E. Golovakha, A. K. Bolotova.
Come sottolinea K. A. Abulkhanova-Slavskaya, esiste una “coscienza sociale dell’individuo, una coscienza tipica”. Una personalità intesa in questo modo è un certo livello di sviluppo sociale di un individuo, “corrispondente al livello attuale di un dato sistema sociale, il cui sviluppo è condizionato dal coinvolgimento prolungato dell'individuo nelle connessioni e nelle relazioni sociali nel tempo. , le capacità mentali e sociali dell'individuo si espandono, più sono inclusi nel campo della sua coscienza e attività, piani di vita e obiettivi distanti nel tempo, strati più profondi del tempo della sua vita: passato e futuro, formando così un orizzonte o orizzonte temporaneo dell’individuo, un certo orientamento personale-temporale nel tempo della vita,
L'espansione degli orizzonti temporali diventa tanto più fruttuosa e tangibile quanto più profondamente e pienamente l'individuo è coinvolto in una varietà di attività oggettive e comunicative e quanto più spesso si rende conto, analizza e riflette sulle cause e le conseguenze di questa attività.
La complicazione della struttura personale del tempo di vita come risultato dell'accumulo di esperienze di vita individuali e dell'emergere di una serie di prospettive temporali di vita, che portano alla formazione dell'orizzonte temporale di una persona, può essere designata come tempo personale.
Pertanto, il livello della personalità adulta caratterizza diversi tipi di organizzazione del tempo di vita,
che esprimono
non più una gerarchia di età, ma una gerarchia personale. Raggiungere il livello di trasformazione creativa del tempo di vita, sia personale, di gruppo che sociale, attraverso un rapporto problematico con la vita è tempo soggettivo. Lo sviluppo di queste diverse tipologie di organizzazione del tempo consente all'individuo non solo di assimilare l'esperienza accumulata dall'umanità nel passato, ma anche di andare oltre i suoi limiti nel presente reale, padroneggiandola e arricchendola per il futuro.
In altre parole, una personalità è un individuo che padroneggia e arricchisce attivamente la sua essenza sociale, trasformando creativamente l'esperienza passata, superando la ristrettezza o le limitazioni del presente, strutturando e regolando le attività attuali nel tempo; capace di prevedere, anticipare gli eventi futuri e immaginarli realmente, vivendoli come attuali. Troviamo un'analogia in questa comprensione della personalità negli studi di K. N* Abulkhanova-Slavskaya, il quale scrive che la personalità è caratterizzata anche da abilità individuali speciali come “la capacità di organizzare il tempo” (e la capacità di essere attivi in un contesto tempestivamente), la capacità di programmare attività future, anticiparne gli eventi, stabilire modalità ottimali di attività e passività per se stessi e determinare i ritmi di attività (1991).
Già a livello biologico e fisiologico generale, l'anticipazione del futuro è di fondamentale importanza nella regolazione del comportamento (P.K. Anokhin, N. Bernstein, C. Sherrington, ecc.); “Possiamo supporre”, come ha scritto a questo proposito Charles Sherrington, “che nella realizzazione di azioni finalizzate all’atto conclusivo, il Processo di Selezione apra l’opportunità ad elementi di Memoria (seppur rudimentali) ed elementi di anticipazione (seppur rudimentali) insignificante) per svilupparsi nella capacità mentale di “spiegare” il presente indietro, nel passato, e in avanti nel futuro, che negli animali superiori è un segno indispensabile di uno sviluppo mentale superiore”.
Una caratteristica distintiva di una personalità in via di sviluppo normale, come scrive B.V. Zeigarnik, è “la capacità di valutare più o meno oggettivamente la situazione che si è creata, di vederla non solo nel momento immediato, ma anche in una prospettiva temporale dettagliata e di trovare l’opportunità di fissare obiettivi reali e realizzabili, la cui riuscita attuazione ci avvicinerà all’obiettivo ideale in futuro.”
Come ritiene giustamente B.V. Zeigarnik, sulla base di numerosi materiali sperimentali, l'assenza
posizionalità correttiva tempestiva, la possibilità di una valutazione esterna più o meno imparziale dell'intera situazione nel suo insieme, non solo in relazione ai propri bisogni attuali, alle attività attuali, ma anche in relazione a se stessi, all'intera situazione nel suo insieme, può essere considerata come la base per evidenziare il criterio essenziale per il pieno sviluppo della personalità. "Finché "voglio e posso", "vorrei e potrei", gli obiettivi ideali e reali non sono separati, fusi, possiamo solo parlare dell'immaturità psicologica dell'individuo" (1982).
Nel corso della storia della cultura umana, nel campo dell'educazione, del management, dell'arte e della poesia, la questione della prospettiva temporale, o prospettiva (V.I. Kovalev) del comportamento umano, è estremamente rilevante. Ogni epoca si distingue per la sua soluzione al problema della combinazione ottimale di passato e presente, presente e futuro, sia nella vita della società nel suo insieme che dell'individuo. Qui si può rintracciare la lotta costante tra due tendenze: 1) basarsi sulla realtà attuale e sull'esperienza passata, sul realismo e sulla praticità associati al momento attuale nel tempo e 2) superare la ristrettezza e i limiti del presente, procedere dal futuro: conosciuto, prevedibile e riflesso in scopi volitivi, piani di vita, ideali.
Si presume spesso che il primo si realizzi naturalmente, come da solo. Allo stesso tempo, in psicologia e nell'arte la seconda tendenza si esprime più spesso e in modo più emotivo. Così, F. M. Dostoevskij scrisse: "Il realismo, limitato alla punta del naso, è più pericoloso della fantasia più folle, perché è cieco" (Collezione di opere Dostoevskij F. M.. T. 8. M., 1957. P. 155 ). La capacità di subordinare il proprio comportamento a obiettivi sempre più distanti, la trasformazione di questi obiettivi in obiettivi effettivamente efficaci che regolano il comportamento attuale, non è solo una regolarità dello sviluppo ontogenetico di una persona, ma anche un criterio della sua maturità morale. Come ha scritto K. Levin, una prospettiva temporale positiva creata da obiettivi degni è uno degli elementi principali dell'alta moralità. Allo stesso tempo, questo è un processo reciproco: l'alta moralità stessa crea una prospettiva a lungo termine e stabilisce obiettivi meritevoli.
Pertanto, nella formazione e nello sviluppo della personalità, il fattore tempo, la strutturazione del tempo nel corso della vita agisce come un elemento integrante della personalità, un criterio per una personalità in via di sviluppo normale, come una delle manifestazioni delle capacità regolatrici di una persona durante l'ontogenesi.